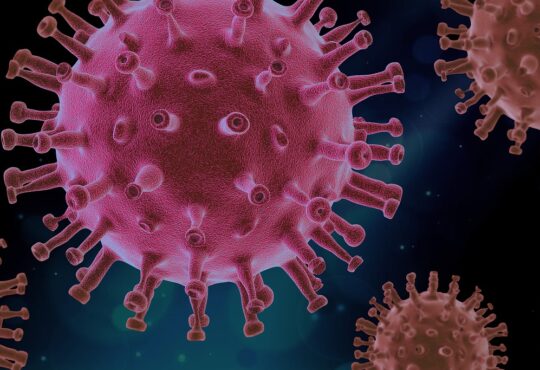Il calvario dei pazienti con la sindrome post-Covid
Molte persone dichiarate guarite dal coronavirus sono afflitte da disturbi che durano mesi. Succede anche ai giovani che avevano sviluppato sintomi lievi. Un monito per chi ancora pensa che la Covid-19 sia solo un’influenza
Difficoltà a respirare. Palpitazioni. La febbre che sale e scende. E poi dolori muscolari, mal di testa lancinanti e fastidiosi formicoli. Nausea. Disturbi gastrointestinali. Vuoti di memoria. E soprattutto, una spossatezza estrema che rende impossibile persino salire una rampa di scale, farsi la doccia o scrivere una mail. Sono alcuni dei sintomi che affliggono un numero crescente di persone – quante non si sa, forse centinaia di migliaia in tutto il mondo – dichiarate guarite dalla COVID-19 dopo due tamponi negativi, ma che guarite non sono affatto. C’è chi è stato dimesso dall’ospedale dopo aver superato la fase acuta dell’infezione, e chi in ospedale non ha mai messo piede, perché aveva sviluppato solo sintomi lievi. In comune hanno però il calvario che ne è seguito: una costellazione di disturbi debilitanti che possono protrarsi per mesi. Li chiamano long-hauler, malati a lungo termine di una sindrome ancora oscura e che, in mancanza di meglio, viene indicata come sindrome post-COVID. Per molti di loro, tornare alla vita di prima dopo essere stati infettati da SARS-CoV-2 si è rivelato finora impossibile.
La storia di Jemma
Jemma Kennedy ha raccontato al Guardian di essersi ammalata a metà marzo. La diagnosi parlava di una forma lieve di COVID-19, senza necessità di ricovero ospedaliero. Gli esami erano buoni: sangue, cuore, polmoni; sembrava tutto a posto. «Ma il corpo mi diceva qualcosa di diverso. Per sei settimane mi sono sentita come se ogni mia cellula fosse stata avvelenata. Avevo il fiatone e un costante dolore al petto. A maggio mi sono sentita meglio e ho pensato che il peggio fosse passato, finché non sono stata travolta da un affaticamento post-virale che si è rivelato quasi peggiore della malattia». A fine luglio Kennedy aveva paura persino di coricarsi e spesso era costretta a dormire seduta per placare il dolore ai polmoni che la tormentava da sdraiata. «Mesi di gastroenterite virale mi hanno lasciato con una colite intestinale che necessita di un regime dietetico rigoroso; mi fa male la testa, la pelle mi pizzica e la stanchezza mi schiaccia come una coperta imbottita di cani morti».
Jemma Kennedy è una scrittrice e la sua potente testimonianza ha dato voce a molte altre persone che, come lei, si chiedono quando l’incubo che stanno vivendo finirà. Nessuno conosce la risposta. Non abbiamo ancora abbastanza dati per sapere tutto quel che può fare SARS-CoV-2 una volta che si è insediato nei nostri corpi. Ormai è però evidente che la COVID-19 si comporta come una malattia multiorgano: oltre ai polmoni, può colpire il cuore, il cervello, il sistema nervoso, il pancreas, i reni, l’intestino, la pelle, la tiroide e il sistema muscolo-scheletrico. Questo può spiegare il ventaglio di sintomi riscontrati nei pazienti. Ma non è chiaro che cosa possa scatenare tutto questo pandemonio a distanza di settimane o mesi dal contagio.
Le ipotesi sulle cause
Forse il coronavirus è ancora annidato negli organi dei long-hauler: sfugge ai tamponi nasofaringei ma non ha perso la capacità di replicarsi e di fare danni. Oppure potrebbe avere innescato una riposta immunitaria sproporzionata e persistente, all’origine delle infiammazioni agli organi che non si placano neppure dopo che il coronavirus è stato debellato. È quel che del resto accade con la febbre dengue, che provoca un terribile affaticamento anche quando il virus non è più presente nell’organismo. Nei polmoni infettati da SARS-CoV-2 si possono così formare coaguli e cicatrici che ostacolano l’afflusso di sangue ossigenato agli altri organi, inducendo la famigerata fame d’aria: un senso di profondo affanno anche in seguito a un leggero esercizio fisico.
Alcuni esperti hanno messo in relazione la sindrome post-COVID con la disautonomia, una disfunzione del sistema nervoso autonomo che controlla importanti funzioni corporee come la respirazione, il battito cardiaco e la pressione sanguigna. Questo potrebbe spiegare perché molti long-hauler hanno difficoltà di respiro anche con livelli di ossigeno nella norma o perché presentano un battito cardiaco irregolare. Sono state avanzate analogie anche con la sindrome da stanchezza cronica, che darebbe conto conto dell’estremo affaticamento provato da gran parte delle persone con la sindrome post-COVID.
Non morti, non guariti, non malati
L’incertezza è un’ulteriore fonte di angoscia per chi si trova nel limbo della sindrome post-COVID. Non si è morti, è vero, ma non si è neanche guariti e spesso non si viene neppure riconosciuti come malati. Nei primi mesi della pandemia i long-hauler hanno dovuto affrontare lo scetticismo di medici e famigliari, disorientati da sintomi che non rientravano tra quelli tipici della COVID-19 e che mutavano di giorno in giorno senza un’apparente spiegazione. A molti di loro non era stata neppure diagnosticata la malattia, perché all’inizio i tamponi venivano fatti solo a chi presentava sintomi gravi o finiva in ospedale. Fin troppo facile liquidare tutto come suggestione causata dall’ansia e dallo stress. Del resto, nella prima fase dell’emergenza, medici e infermieri erano impegnati a salvare quante più vite possibile, travolti da un’ondata di pazienti in gravi condizioni che nelle terapie intensive lottavano per non morire. Chi aveva il tempo di preoccuparsi per qualcuno a casa con il fiatone?
È anche colpa di come la COVID-19 è stata raccontata. Per molto tempo si è ripetuto come un mantra che solo una minoranza di persone (per lo più anziani con malattie croniche pregresse) rischia di sviluppare sintomi gravi, mentre la gran parte dei contagiati è asintomatica o presenta sintomi lievi. È corretto, ma adesso sappiamo che questa è solo metà della storia. Esiste una terza categoria di persone che non sviluppa subito sintomi gravi ma poi soffre di disturbi invalidanti a medio e a lungo termine. Molti di loro sono giovani adulti senza malattie pregresse.
Si è a lungo dato per scontato che le persone con sintomi lievi tornassero in piena salute entro un paio di settimane, come avviene per l’influenza e il raffreddore. Questo paragone è stato forse l’errore peggiore nel racconto della pandemia. La COVID-19 non è un’influenza né un raffreddore. Guardando invece a quel che abbiamo appreso con la SARS, non mancano storie di pazienti che hanno avuto difficoltà di recupero e sofferto di disturbi persistenti. Il senso di affaticamento estremo che caratterizza la sindrome post-COVID era stato riscontrato anche in molti dei sopravvissuti alla SARS, afflitti da problemi respiratori anche a 18 mesi di distanza dalla risoluzione della polmonite. Ma queste informazioni non erano alla portata delle persone come Jenna Kennedy, e forse neppure della gran parte dei medici che seguivano il loro decorso clinico.
In cerca di sostegno
In preda a un frustante senso di solitudine e incomprensione per qualcosa che nessuno sapeva spiegare, alcuni dei primi long-hauler hanno cominciato a condividere le loro storie sul web, cercando il sostegno di altre persone con esperienze simili. Si sono formati dei gruppi di mutuo aiuto che hanno raccolto testimonianze e mostrato come il problema fosse molto più diffuso di quanto si immaginava. Tuttavia, poiché la COVID-19 è una nuova malattia, è normale che le informazioni sugli effetti a lungo termine scarseggiassero. Così i long-hauler hanno deciso di studiare se stessi, catalogando i sintomi e spronando la comunità medico-scientifica a fare altrettanto. Anche in Italia esiste un gruppo Facebook chiamato Noi che il Covid l’abbiamo sconfitto. Nel nostro Paese i «guariti dimessi» (come sono definiti dal bollettino della Protezione Civile) sono oltre 206 mila. Se però stiano bene o male, se abbiano avuto un pieno recupero o lottino ancora con i postumi della COVID-19 non è dato sapere.
Di recente sono stati pubblicati i primi studi sistematici sulle riviste scientifiche. Seppure basati su campioni di pazienti troppo ristretti per offrire risultati conclusivi, hanno fornito un supporto scientifico al riconoscimento della sindrome post-COVID. Una delle prime ricerche è stata condotta dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma su 143 pazienti dimessi dopo un ricovero ospedaliero. I risultati, pubblicati in luglio sulla rivista Jama, mostrano che l’87% dei pazienti presentava ancora sintomi a distanza di due mesi dal contagio. Altre ricerche condotte in Gran Bretagna e in Germania sono arrivate a conclusioni molto simili. Uno studio dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi ha invece evidenziato che circa un terzo dei pazienti non ospedalizzati presentava diversi sintomi dopo due o tre settimane. Secondo alcune stime basate sul monitoraggio delle persone contagiate in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, almeno il 10% dei pazienti con sintomi lievi mostra ancora sintomi dopo tre settimane.
Le istituzioni sanitarie sono state lente a riconoscere l’esistenza della sindrome post-COVID, ma da qualche tempo qualcosa è cambiato. I giornali hanno cominciato a raccontare le vicende dei long-hauler, i medici che prendono seriamente i sintomi sono sempre di più e alcuni ospedali hanno organizzato percorsi terapeutici di riabilitazione. Ora che l’attenzione si è spostata sui sopravvissuti, servono linee guida per trattare i pazienti e la rivista medica The Lancet ha tentato di colmare il vuoto con una pubblicazione ad hoc. Nei giorni scorsi una delle principali associazioni di pazienti, Long COVID SOS, è stata ricevuta dal direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha promesso di farsi portavoce presso i governi affinché forniscano l’assistenza necessaria. Nel frattempo la ricerca ha preso piede e si spera che presto possa fare luce su questo aspetto ancora trascurato della pandemia.
Siamo noi la seconda ondata
Tracciare una linea netta fra salute e malattia è sempre difficile e arbitrario, ma ha conseguenze importanti su chi si ritrova al di qua o al di là di quella linea. Otto mesi dopo l’inizio della pandemia è evidente che non sempre bastano le dimissioni dall’ospedale o due tamponi negativi per essere realmente guariti dalla COVID-19. Prima di dichiarare una persona guarita è cruciale accertarsi che abbia anche recuperato integralmente le sue funzionalità, sostiene Nisreen A. Alwan, esperta di salute pubblica dell’Università di Southampton, che in un articolo su Nature ha descritto la sindrome post-COVID con cui è costretta a convivere da mesi. Nessuno sa dire ai long-hauler quando i disturbi passeranno, né dissolvere il dubbio che possano cronicizzarsi e non andarsene più, lasciando cicatrici indelebili. Ed Yong scrive su The Atlantic che dopo quattro o cinque mesi molti pazienti cominciano a sentirsi meglio, ma il decorso ha spesso alti e bassi e purtroppo il pieno recupero non può essere dato per scontato.
Tutto ciò dovrebbe essere un monito per chi ancora pensa che la COVID-19 sia solo un’influenza. Nel tentativo di rassicurare l’opinione pubblica, una comunicazione del rischio sbagliata e pericolosa ha indotto i più giovani a credere che in caso di contagio se la sarebbero cavata con qualche giorno di tosse e di febbre. Purtroppo non è sempre così. Tra i pazienti con la sindrome post-COVID ci sono molti giovani adulti che prima di infettarsi erano in buona salute. Conosciamo il profilo delle persone più rischio di sviluppare sintomi gravi, ma non quello di chi può andare incontro a un periodo prolungato di malattia.
È importante che queste persone non siano lasciate sole di fronte alle conseguenze a lungo termine, ancora in gran parte sconosciute, della COVID-19. «Siamo noi long-hauler la seconda ondata e abbiamo bisogno di aiuto subito», ha scritto Kennedy sul Guardian. Il bilancio della pandemia è ancora tutto da scrivere, ma è evidente che non basterà contare il numero delle vittime e delle dimissioni ospedaliere. L’effettivo impatto sanitario della COVID-19 dovrà tenere conto anche della scia di disturbi fisici e psicologici che stanno impedendo a tante persone di tornare alla loro vita di prima.
Leggi anche: Prevenire una seconda ondata di Covid-19
Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. 
Immagine: Pixabay