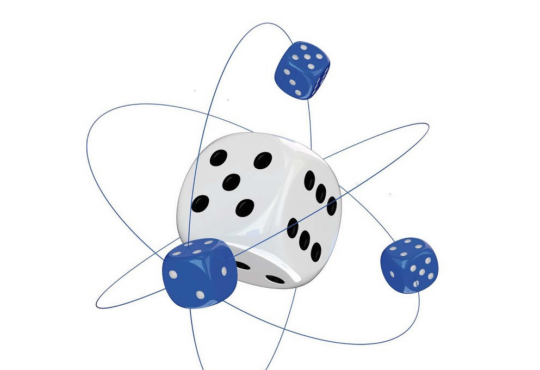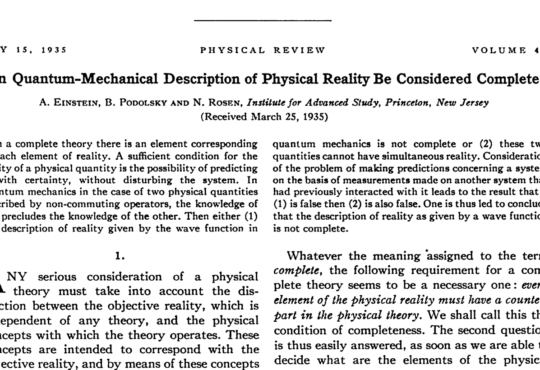“Quando abbiamo smesso di capire il mondo”, di Benjamín Labatut
Racconti di personaggi della scienza che hanno fatto la storia in diversi campi di azione e attraverso molteplici prospettive.

Quando abbiamo smesso di capire il mondo (Adelphi 2021, 18 €) è stato tradotto da Lisa Topi, pubblicato in italiano a febbraio. La versione originale, il cui titolo spagnolo è Un verdor terrible, risale al settembre 2020.
Benjamín Labatut è uno scrittore nato in Olanda, cresciuto in Argentina e Perù, ed ora residente in Cile. I suoi libri sono stati tradotti in varie lingue. L’autore, premiato in più occasioni, in quest’opera di finzione basata su fatti reali riprende le biografie di numerosi scienziati e le riporta, con qualche dettaglio inventato, in un testo che suscita riflessioni distinte in ogni lettore. Il metodo narrativo utilizzato è per certi versi simile e per altri molto diverso da quello esposto, ad esempio, da Telmo Pievani in Finitudine. Riprende, a suo modo, la tendenza di raccontare la storia con l’ausilio della fantasia, un genere che sta avanzando in molti contesti culturali, ad esempio nel cinema, come nella serie Leonardo.
In particolare, Labatut ha sistemato alcune biografie in originali sequenze, con un andirivieni dei fatti e dei concetti che mostra naturalmente il segno di un narratore geniale. Gli eventi centrali delle storie sono ampiamente accertati, e molti degli episodi sono ricostruiti con l’ausilio di fonti attendibili. Come informa l’autore però, all’interno della narrazione e soprattutto nella seconda parte si trovano elementi di fantasia. Ad ogni modo, ad eccezione del personaggio di Shinichi Mochizuki, la maggior parte delle vicende sono effettivamente avvenute.
Il libro da un lato genera qualche dissapore per coloro che amano le biografie, dall’altro, però, offre un invito ai lettori più vicini ai generi romanzati. Ed è notevole che il quesito retrostante resta efficace per tutti i lettori: abbiamo smesso di capire il mondo? Sì, se proviamo a comprenderlo con gli occhiali di ieri. No, invece, se pensiamo che il mondo l’abbiamo compreso sempre e mai. Un aspetto strabiliante del libro è proprio questo: consapevolmente o meno, nell’avvicendarsi dei giorni così come nello scorrere delle pagine, non sappiamo con chiarezza dove iniziano e finiscono la realtà o la finzione.
L’intervista
Per l’edizione italiana Labatut ha dialogato con Claudia Durastanti in un’intervista introdotta da Paolo Soraci. In questo colloquio la Dr.ssa Durastanti chiede l’opinione dell’autore a proposito del titolo del libro nelle diverse lingue. Da “Un verde terribile” in spagnolo si è passati a “Quando abbiamo smesso di capire il mondo” in italiano e in inglese, e a “La luce cieca” nella versione tedesca ed olandese. Labatut afferma che da una parte “quando abbiamo smesso di capire il mondo” restringe l’astrazione delineata dal titolo spagnolo, dall’altra pone giustamente l’accento sul problema di capire noi stessi, mentre il titolo tedesco ed olandese punta l’attenzione sui pericolosi rapporti tra ragione e oscurità.
Sullo stile narrativo Labatut pone l’accento sul peso delle parole e del linguaggio nella percezione e comprensione del mondo. Per esempio, dice, il problema di descrivere a parole un’immagine poetica è qualcosa che ci pone di fronte alla consapevolezza che il mondo che vediamo e leggiamo non coincide necessariamente con quello che avvertiamo ed esprimiamo. La conoscenza, come il linguaggio, muovendosi tra descrizioni, percezioni e realtà, è in grado di generare cose che prima non esistevano. Così avvenne con lo sviluppo di quella teoria fisica che portò alla descrizione della “singolarità”, cioè dei famosi “buchi neri” del cosmo.
Nei termini del libro, nondimeno, le singolarità non sono solo quelle dell’universo fisico, i buchi neri appunto, ma anche quelle pertinenti alla formazione di nuove conoscenze per mezzo di scoperte geniali. L’autore non nega la condivisa visione collettiva con la quale oggi rappresentiamo gli avanzamenti della scienza, la ragnatela con la quale si riferisce al mondo della sapienza ne è la prova. D’altro canto, Labatut trascrive casi in cui le invenzioni sono il risultato di singoli contributi geniali. Certo, ogni innovatore parte da un punto di una ragnatela già esistente, ma a volte ciò che emerge è perlopiù il prodotto di un’attività singolare.
L’autore confessa che la stesura del testo è stata eseguita con serendipità, senza un’intenzione prestabilita, se non quella di formare qualcosa di nuovo per mezzo di un dato genere di materiali. Ciò che è emerso è una ragnatela formata da tanti episodi circoscritti e da tante brevi storie che si congiungono in collegamenti e cambiamenti grandi e duraturi.
La storia è controversa e imprevedibile
All’inizio del XVIII secolo il color carminio si otteneva triturando milioni di esemplari di cocciniglia. L’insetto per mezzo del quale si produceva quel rosso vivace fu tra i tesori più preziosi rinvenuti in America, e la monarchia spagnola aveva il monopolio su questo prodotto. Johann Jacob Diesbach si stava adoperando per spezzare quel monopolio, cercava infatti di realizzare quel pigmento in laboratorio. Pensava che aggiungendo cremor tartaro a un distillato di resti animali sarebbe riuscito a ricavare quel rosso rubino. Non fu così: ciò che ottenne fu un blu cielo meraviglioso come non se ne vedeva dai tempi degli antichi egizi, quando quel blu colorava la pelle delle loro divinità. Lo chiamò “blu di Prussia”.
Prima di Diesbach il blu dei dipinti, utilizzato in tante occorrenze per il manto della Madonna e per le tuniche degli angeli nel Rinascimento, veniva estratto dalla macinazione dei lapislazzuli, pietre preziose conosciute fin dall’antichità ed estratte prevalentemente da alcune miniere in Afghanistan. Il blu di Prussia fu il primo pigmento sintetico moderno, era certamente più economico del blu dei lapislazzuli e si diffuse fino a ricoprire le uniformi della fanteria dell’esercito prussiano, e ad apparire in dipinti come la Notte stellata di van Gogh o La Grande onda di Kanagawa di Hokusai.
Nel 1782, Carl Wilhelm Scheele, ovvero lo scienziato che scoprì il maggior numero di elementi chimici, compreso l’ossigeno (che chiamava “aria-fuoco”), forse per distrazione trattò il blu di Prussia con un cucchiaio sul quale vi erano residui di acido solforico. Cosa ne seguì? Ne seguì uno dei veleni più letali mai esistiti: il cianuro, da lui chiamato “acido prussico”. Costituito da un atomo di azoto, uno di carbonio e uno di potassio, il cianuro interrompeva quasi immediatamente la respirazione. In forma liquida venne conosciuto come “acido blu”, un acido altamente volatile che rilasciava un aroma di mandorle amare. Secoli dopo quell’aroma avrebbe impregnato le camere a gas dei campi di concentramento nazisti. Ancora oggi alcuni mattoni mostrano tracce di quell’orribile blu.
Tra le storie dagli aspetti imprevedibili e controversi troviamo poi Fritz Haber, colui che a detta dei giornalisti di allora “fece il pane dall’aria”. Nel 1907 Haber aveva trovato il modo di ottenere azoto dall’aria. L’azoto è un elemento chimico fondamentale per la crescita delle piante. All’epoca l’aumento della popolazione mondiale stava causando una domanda di alimenti talmente alta che vennero riesumati milioni di scheletri, dato che si poteva ricavare l’azoto dalle ossa dei morti. Dai soldati e cavalli deceduti nelle battaglie di Austerlitz, Lipsia, Waterloo, ai bisonti americani e fino agli schiavi delle tombe dei faraoni egizi, le ossa di milioni di scheletri finirono nei campi agricoli. Ma non era abbastanza e l’Europa si preparava a una carestia che avrebbe fatto morire di fame milioni di persone.
Come la produzione di un vaccino contro una malattia dilagante, l’azoto di Haber cambiò le sorti dell’umanità. Tuttavia, egli non stava ricercando l’azoto per l’agricoltura, le sue ricerche si svolgevano in ambito militare: doveva fabbricare esplosivi e polvere da sparo per la guerra. Con lo stesso metodo innovativo utilizzato per ottenere azoto dall’aria Haber costruì la prima arma di sterminio di massa, un gas nocivo utilizzato per la prima volta nel 1915 ad Ypres. Con quel metodo aveva prodotto un’arma della guerra chimica le cui modifiche successive, nel 1917, avrebbero portato al “gas mostarda”, la cui ulteriore modifica porterà, decenni dopo, ai primi farmaci antitumorali e alle basi della chemioterapia.
Le nuove sostanze che Haber andava rintracciando, combinate con il cianuro, produssero un pesticida terrificante: lo Zyklon, il “ciclone”. La sua prima versione, lo Zyclon A, fu utilizzata sugli aranceti californiani e sui treni statunitensi, la susseguente, lo Zyclon B, per sterminare milioni di persone nelle camere a gas.
Oroscopi? No, grazie
Nel 1915 Albert Einstein ricevette una lettera dal più giovane professore di Germania, l’astronomo, fisico, matematico e tenente dell’esercito tedesco Karl Schwarzschild. Nella lettera Schwarzschild risolveva per la prima volta le equazioni della teoria della relatività generale. Dimostrava che la massa di una stella deforma lo spazio e il tempo circostanti. Eppure, quelle soluzioni mostravano qualcosa di strano: una massa troppo grande concentrata in un’area piccola non deformava lo spazio e il tempo, li lacerava. Un fenomeno che venne conosciuto come la “singolarità di Schwarzschild”.
Lo stesso scienziato dubitava di quella singolarità, forse non era un fenomeno reale, forse era solo un riflesso delle formule matematiche. La singolarità era troppo strana, se una persona fosse riuscita ad arrivare al centro del buco nero senza essere disintegrata avrebbe visto tutto il passato congelato in un attimo e tutto il futuro accelerato alla velocità della luce. Ciò implicava che ci fosse una sola ed unica storia passata e futura. Comunque, vent’anni dopo la comunità scientifica accettò le idee di Schwarzschild.
Nel corso degli anni ’30 Erwin Schrödinger sviluppò una teoria in cui le particelle elementari potevano essere studiate con le leggi fisiche conosciute. Un fisico brillante, però, non era d’accordo. Werner Karl Heisenberg aveva prodotto una teoria in cui gli elettroni non erano propriamente né onde né particelle, gli elettroni avevano una natura indeterminata, non analizzabile con le leggi note. Il suo maestro, Niels Bohr, gli aveva detto, a riguardo degli atomi, che il linguaggio del fisico doveva esprimersi come quello del poeta: poteva riportare metafore e suscitare connessioni mentali ma non descrivere realmente i fatti. Heisenberg accettò la sfida e studiò un modo per far parlare i fatti, ma suo malgrado si rese conto che ogni progresso lo allontanava dal mondo reale. Realizzò così la prima formulazione della meccanica quantistica.
Einstein pensava che la biologia fosse disordinata perché aveva troppi fattori casuali, questo fu uno dei motivi principali per cui scelse di studiare fisica. Quando vide il lavoro di Heisenberg gli sembrò che il caso si fosse insinuato nella sua ordinata disciplina. Heisenberg doveva essere fermato, la sua teoria doveva essere confutata e a farlo avrebbe dovuto essere Louis-Victor Pierre Raymond, il settimo duca di de Broglie. Impegnandosi costui riuscì a dimostrare che ogni atomo, non solo ogni particella di luce, aveva natura sia ondulatoria che corpuscolare, una natura che poteva essere studiata con le leggi fisiche conosciute. A quel punto Schrödinger fu chiamato a presentare e chiarire le idee di de Broglie. Si apprestò a questo lavoro ma constatò che l’elettrone formava una nuvola, non una particella o un’onda come lui stesso aveva precedentemente formulato, bensì un enorme varietà di stati sovrapposti. Aveva trovato un mistero ancora più problematico di quello che de Broglie doveva smontare contestando Heisenberg. Le idee nel mondo hanno un prezzo da pagare, quello di Schrödinger fu di realizzare l’esatto opposto di ciò che avrebbe dovuto fare.
Schrödinger, entrato ormai nella visione indeterministica della fisica, si concentrò sulla ricerca di una formula che avrebbe permesso di racchiudere, tutti insieme e contemporaneamente, gli stati di un elettrone, fondò così la “funzione d’onda Ψ”. Sapeva nondimeno che nessuno avrebbe mai potuto capire appieno quella funzione, non per i difetti nel metodo o negli strumenti ma perché vi era l’infinito vero e proprio al suo interno. Comunque, Heisenberg mise insieme le sue idee con quelle del fisico austriaco e dimostrò che uno stesso elettrone esisteva in più luoghi, si spostava a a più velocità, possedeva diverse energie e si muoveva in più tempi. Di osservazione in osservazione, però, la particella mostrava solo uno dei suoi possibili stati. Come veniva selezionato di volta in volta quello stato che si prestava all’osservazione? A caso, totalmente a caso. Einstein andò su di giri, “Dio non gioca a dadi col mondo”, disse. Ma forse Einstein era mosso da motivazioni personali più che scientifiche a proposito di questa sua storica avversione al caso. Ben gli rispose Bohr dicendo che “non spetta a noi dire a Dio come manovrare il mondo”.
Mentre racconta queste e molte altre storie, Labatut rende evidente quanto vicine siano la scienza e la società, e cosa può stare a significare quella contiguità.
Leggi anche: “Breve storia delle pseudoscienze”, di Marco Ciardi
Articolo pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()