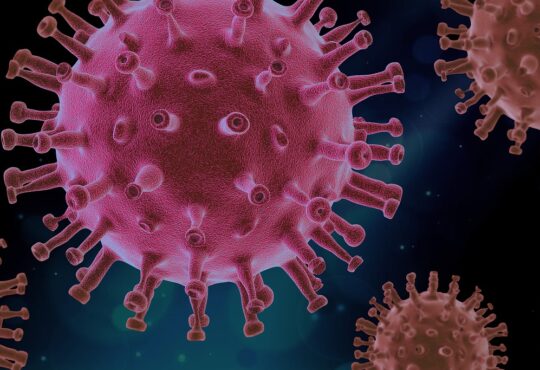Zoonosi e allevamenti animali: perché è necessario che qualcosa cambi
Dai wet market agli allevamenti intensivi, l'insorgere di malattie potenzialmente pericolose anche per noi è dietro l'angolo. Ripensare il settore zootecnico è più che mai urgente.
Le prime notizie sul Covid-19 davano per certo che il virus avesse avuto origine nel discusso mercato di Wuhan, nel quale venivano venduti generi alimentari e animali vivi. Nonostante si stia ancora cercando di stabilire con certezza la genesi del nuovo Coronavirus, gli occhi di tutto il mondo sono puntati sui cosiddetti wet market. Tutti ne abbiamo sentito parlare, tutti abbiamo visto almeno un video sui social o in televisione nel quale si denunciano le scarse condizioni igieniche e le modalità con cui vengono tenuti cani, gatti, polli, maiali, anatre e così via. Si tratta di mercati diffusi soprattutto nel Sud Est Asiatico e in Africa, nei quali vengono vedute merci deperibili, tra cui pesce e carne.
Nella maggior parte dei casi gli animali sono vivi e vengono macellati sul momento dopo essere stati acquistati. Importantissimi per l’economia di molti paesi, sono però purtroppo spesso focolai di malattie, tra cui la prima ondata di influenza aviaria nel 1997. Proprio per questo la Fao ha istituito un gruppo di lavoro e nel 2015 ha pubblicato un manuale per la biosicurezza al loro interno (Biosecurity guide for live poultry market).
Il legame tra sanità pubblica e benessere animale
Astrid Tripodi, veterinaria con più di vent’anni di esperienza a livello internazionale nel controllo di malattie zoonotiche (di origine animale e trasmissibili all’uomo), ha fatto parte dell’équipe Fao, analizzando decine e decide di mercati nel Sud Est Asiatico, prevalentemente in Vietnam. Ne parla durante il webinar organizzato dall’Associazione Italiana di Epidemiologia, che ha come argomento il legame tra sanità pubblica e benessere animale.
I problemi principali che vengono riscontrati nei wet market sono la scarsa igiene (sia nell’esposizione di carne e animali sia per la macellazione di questi ultimi), il commercio di fauna selvatica e l’impossibilità di tracciare la provenienza dei prodotti venduti. La mancanza di un sistema di tracking fa si che, se anche si trovasse un animale infetto, non si sarebbe in grado di definire con esattezza l’allevamento di origine. La catena di distribuzione delle merci è molto lunga e complessa, gli animali vengono stoccati in via via in vari magazzini e numerosi mezzi di trasporto.
Un grandissimo problema è rappresentato anche dagli stessi allevamenti. Ne esistono di due tipi: quelli certificati, di solito molto grandi e importanti economicamente parlando, catalogati troppo spesso dalla Fao con un bassissimo livello di biosicurezza, e altri allevamenti “non ufficiali”, dei quali nemmeno si conoscono le condizioni. In comune hanno una gestione problematica dei liquami organici, la compresenza di più specie di animali all’interno di uno stesso allevamento e il mancato isolamento tra animali allevati e specie selvatiche che vivono nell’ambiente circostante.
Il caso del pipistrello
Prendiamo ad esempio il bistrattato pipistrello, utilissimo per l’ecosistema in quanto si nutre di insetti nocivi e impollina svariate specie di fiori. Oltre a ciò, risulta essere però un vero e proprio ricettacolo di Coronavirus, una famiglia di virus che ha la caratteristica di essere molto adattabile e quindi di mutare il proprio genoma, passando così da una specie all’altra. Con la deforestazione e la riconversione di grandi territori in allevamenti, il confine con l’habitat della fauna selvatica sono diventati molto permeabili, aumentando esponenzialmente i contatti con gli animali da cortile. Anche la presenza di più specie in una stessa struttura risulta molto problematica: nel sangue e nelle deiezioni si trovano molti virus diversi tra loro, come ad esempio i Coronavirus aviari e quelli gastrointestinali suini. Tenerli separati previene lo spillover, il salto di specie, che ha conseguenze disastrose sia per l’intero allevamento, sia per tutti gli animali che verranno in contatto con quelli infetti durante il trasporto e nei mercati.
Quali sono le procedure di controllo previste
La dottoressa Tripodi racconta a OggiScienza la sua esperienza nel gruppo di lavoro della Fao sulle procedure di controllo negli allevamenti nel Sud Est Asiatico e in Africa:
“Non essendoci una banca dati con tutti gli allevamenti è molto difficile effettuare dei controlli sistematici: quelli industriali sono solo una piccola parte rispetto al totale. In caso di sospetto focolaio gli allevatori dovrebbero contattare i veterinari, ma spesso cercano di risolvere la questione da soli dando per esempio antibiotici o vendendo i capi sani per ridurre le perdite economiche. Nel caso invece in cui gli allevatori contattino i veterinari (questo accade in presenza di un’alta mortalità tra gli animali, ad esempio), si eseguono i test in laboratorio. Seguono la quarantena e l’investigazione epidemiologica, soprattutto in caso di malattie a notifica obbligatoria”.
Detto ciò, bisogna fare un’osservazione importante: l’insorgere di malattie potenzialmente pericolose per l’uomo avviene anche in allevamenti molto controllati. Gli allevamenti intensivi, nello specifico, hanno delle caratteristiche molto simili tra loro: gli animali hanno poco spazio vitale, sono di solito ammassati tra loro, si provocano spesso delle ferite che poi diventano infette. Oltre a ciò, ogni allevamento produce una quantità enorme di rifiuti biologici, che devono essere smaltiti correttamente. Chi lavora a stretto contatto con gli animali deve quindi seguire delle norme molto precise, tra le quali: pulire e sanificare gli ambienti, fare attenzione nelle operazioni di trasporto, carico e scarico degli animali, indossare sempre guanti e indumenti protettivi, sterilizzare tutti gli strumenti di lavoro.
Un ulteriore problema: l’antibioticoresistenza
Il grande spettro degli allevamenti intensivi e industriali si chiama antibioticoresistenza. Non ha a che fare stavolta con patologie a trasmissione virale, ma con alcuni ceppi di batteri che diventano immuni agli antibiotici che utilizziamo per debellarli. Secondo il Ministero della Salute in Italia il 50% degli antibiotici venduti (compresi anche quelli a consumo umano) è destinato agli animali. Vengono utilizzati in tre modalità: la prima, per trattare un animale ammalato; la seconda, detta metafilassi, consiste nel trattare un gruppo di animali che è stato a contatto con quello ammalato; la profilassi invece, prevede il trattamento preventivo gli animali, prima ancora che qualcuno si ammali.
Proprio l’uso profilattico sarebbe la causa dello sviluppo di una resistenza da parte di alcuni ceppi batterici pericolosi per l’uomo, come per esempio quelli dell’Escherichia Coli o della Salmonella. Alcuni sono presenti negli intestini di animali e vengono in contatto con le loro carni (trasmettendosi poi a chi le mangia) durante la macellazione . Secondo l’OMS, l’antibioticoresistenza rappresenta, oggi, una delle maggiori minacce per la salute pubblica a causa dell’impatto epidemiologico ed economico del fenomeno (fonte: Ministero della Salute).
David Quammen, in Spillover, scrive che “le malattie infettive sono dappertutto. Rappresentano una sorta di collante naturale, che lega un individuo all’altro e una specie ad un’altra all’interno di quelle complesse reti biofisiche che definiamo ecosistemi”. Negli ecosistemi vige però una sorta di equilibrio, che come abbiamo visto viene spesso alterato dalle modalità con le quali l’uomo si rapporta all’animale: ci troviamo davanti alla necessità di ripensare tale rapporto, iniziando dalle dinamiche di allevamento. Un primo passo potrebbe essere prediligere sistemi che abbiano tra le proprie priorità la sicurezza, il benessere animale e la sostenibilità ambientale.
Leggi anche: Gli animali e le città: cosa racconta di noi Covid-19
Articolo pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()
Fotografia: Pixabay