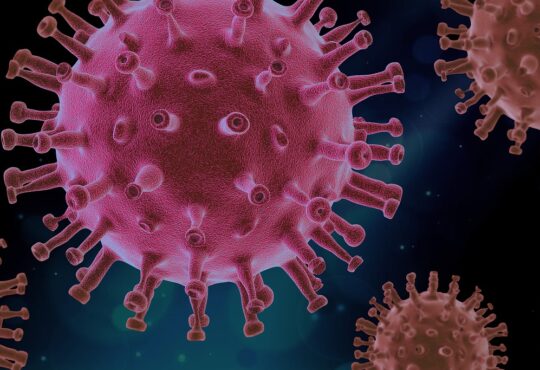Il vaccino contro la Covid-19 sarà disponibile per tutti?
Gli sforzi per trovare in fretta un vaccino contro il nuovo coronavirus non hanno precedenti, ma sollevano molte questioni etiche e politiche
Preparatevi a sentirne di cotte e di crude. Nei prossimi mesi la corsa al vaccino – che l’Economist paragona alla corsa allo spazio che negli anni Sessanta contrappose USA e URSS – farà la parte del leone in ogni discussione sulla pandemia di COVID-19. Perché, se guardiamo alle nostre vite, abbiamo affidato al vaccino l’incombenza di sottrarci alla difficile convivenza con il coronavirus SARS-CoV-2. Se invece parliamo di scenari globali, l’esito di questa impresa scientifica, destinata ad alimentare la competizione tra le odierne potenze economiche – Stati Uniti, Cina ed Europa in testa – potrebbe ridisegnare gli equilibri geopolitici del dopo-pandemia.
E allora aspettatevi un crescendo di proclami roboanti, strepitose accelerazioni e brusche frenate, grandi speranze e delusioni cocenti, colpi bassi e guerre di spie. Sebbene non ci sia garanzia che un giorno avremo un vaccino efficace, già si pongono alcune questioni cruciali. La prima: il vaccino sarà disponibile per tutti o chi vincerà la corsa se lo terrà per sé, assicurandosi il vantaggio di poter rilanciare l’economia mentre gli altri ancora arrancano? La seconda: siamo sicuri che il vaccino metterà la parola fine alla pandemia o, comunque vada, SARS-CoV-2 resterà con noi a lungo, molto più a lungo di quanto pensiamo?
Quanto ci vorrà davvero per avere un vaccino?
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono allo studio un centinaio di potenziali vaccini contro la COVID-19, otto dei quali già in fase di sperimentazione sugli esseri umani grazie a un protocollo di approvazione rapida che ha consentito di saltare i test sugli animali. Finora sono stati bruciati i tempi e, se tutto dovesse filare liscio, tra meno di un anno potremmo avere un vaccino efficace. Sarebbe un risultato straordinario considerato che di solito lo sviluppo di un vaccino per una nuova malattia richiede da quattro a dieci anni.
La prudenza è d’obbligo perché in fase clinica almeno nove candidati su dieci finiscono con un buco nell’acqua. I test di efficacia e sicurezza sull’uomo prevedono infatti un iter rigoroso: bisogna anzitutto assicurarsi che il preparato non sia tossico, quindi che induca una risposta immunitaria e infine che sia in grado di garantire un’effettiva protezione dal contagio, sperimentando il vaccino a un numero crescente di persone. Il 18 giugno la società statunitense Moderna ha annunciato che i primi test del suo innovativo vaccino a mRNA, condotti su un campione di otto volontari, si sono conclusi con successo: il vaccino ha dimostrato di essere «sicuro e ben tollerato» e di indurre la produzione di anticorpi. È una notizia incoraggiante, ma il traguardo è ancora lontano: di annunci come questo, avverte il New York Times, rivolti per lo più ad azionisti e finanziatori, ne sentiremo sempre più spesso.
Nessuno dei vaccini sperimentali contro la COVID-19 è tuttavia ancora arrivato alla cosiddetta fase 3, la più lunga e dispendiosa, perché richiede di monitorare migliaia di volontari per un prolungato periodo di tempo, in genere non meno di sei mesi. Un vero collo di bottiglia nella sperimentazione clinica. In realtà, un modo per accelerare i tempi (e risparmiare centinaia di milioni di euro) ci sarebbe: contagiare di proposito un numero ristretto di volontari a cui è stato somministrato il vaccino sperimentale e vedere se si ammalano. Il protocollo è chiamato human challenge trial e in passato è già stato impiegato contro altre malattie infettive. Oggi uno studio pubblicato sul Journal of Infectious Diseases lo ha riproposto per la COVID-19.
Si tratta però di una scorciatoia non priva di implicazioni etiche giacché implica il contagio di persone sane, e senza neppure disporre di una cura per rimediare al danno nel caso il vaccino non si rivelasse efficace. Tuttavia l’OMS ha già predisposto delle specifiche linee guida da seguire affinché questa opzione risulti eticamente accettabile, perciò è probabile che sarà presa in seria considerazione. Secondo l’OMS, i volontari dovranno avere un’età compresa fra 18 e 30 anni, non soffrire di patologie pregresse ed essere informati in modo trasparente sui rischi, anche letali, a cui andrebbero incontro.
Tuttavia, provare l’efficacia e la sicurezza di un vaccino non basta: l’altro grande ostacolo sono i tempi di produzione e distribuzione. Per vaccinare l’intera popolazione umana serviranno infatti miliardi di dosi. Persino rinunciando a produrre gli altri vaccini di cui abbiamo bisogno – un’ipotesi che in realtà appare impensabile – e dedicando ogni risorsa al vaccino contro la COVID-19, non si riuscirebbe a sintetizzare più di cinque miliardi di dosi all’anno, che dovranno poi essere distribuite in ogni angolo del pianeta.
Servirà tempo, molto tempo: tra la prima e l’ultima persona che riceverà il vaccino potrebbero passare anche diversi anni. Questo impone di stabilire delle priorità e si può supporre che la precedenza sarà data alle persone più a rischio (a partire dal personale sanitario e dagli anziani con altre patologie) e ai lavoratori impiegati in attività essenziali. Se non rientrate in queste categorie, dovrete mettervi in coda. E se avete la sfortuna di abitare in un Paese del sud del mondo, la coda potrebbe essere ancora più lunga.
Il vaccino sarà per tutti?
Purtroppo c’è da scommettere che la corsa al vaccino, come ogni corsa, produrrà vincitori e vinti. La nazione che taglierà per prima il traguardo vorrà soddisfare anzitutto la richiesta interna, acquisendo un vantaggio economico senza uguali nel mondo post-coronavirus, perché potrebbe far ripartire le attività produttive a pieno ritmo con diversi mesi di anticipo su tutti gli altri.
Del resto è già accaduto nel 2009, quando il primo vaccino contro l’influenza suina venne sviluppato da un’azienda farmaceutica australiana: le nazioni ricche fecero a gara per accaparrarsi le prime dosi, l’Australia negò l’esportazione finché non venne soddisfatto il fabbisogno interno e persino l’amministrazione di Barack Obama si rimangiò la promessa di donare il vaccino ai Paesi poveri per avvantaggiare la distribuzione negli Stati Uniti.
Nelle scorse settimane abbiamo già assistito a diversi tentativi di accaparrarsi le scorte di ventilatori polmonari e dispositivi di protezione, con Berlino che ha accusato Washington di «pirateria moderna» per aver dirottato verso gli Stati Uniti un carico di mascherine destinato al mercato tedesco. Oggi molti governi stanno già stringendo accordi per assicurarsi la priorità di accesso al futuro vaccino contro la COVID-19.
Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere l’intenzione dell’azienda farmaceutica Sanofi di riservare le prime dosi del suo potenziale vaccino al mercato statunitense. Parigi, che ospita il quartier generale di Sanofi, ha subito protestato: «Il vaccino dovrebbe essere un bene comune sottratto alle leggi del mercato», ha tuonato il presidente Emmanuel Macron, colto alla sprovvista. Ma dal colosso farmaceutico hanno chiarito che gli Stati Uniti si sono guadagnati una corsia preferenziale grazie ai generosi finanziamenti già versati e a procedure di autorizzazione più snelle: «L’Europa faccia altrettanto», ha suggerito (o se preferite, minacciato) Olivier Bogillot, responsabile di Sanofi France, ramo francese della multinazionale.
L’Unione Europea ha dato man forte a Macron, sostenendo che l’accesso al vaccino dovrebbe essere equo e universale. Mentre il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha dichiarato a nome di molti leader dei Paesi del sud del mondo che «nessuno dovrebbe finire in fondo alla fila per il vaccino per colpa del suo luogo di nascita o del suo reddito». Tuttavia non esiste alcuna autorità internazionale con il potere di influenzare le scelte dei governi e dell’industria farmaceutica, neppure riguardo alle priorità di distribuzione di un vaccino salvavita.
In queste settimane l’Europa e l’OMS hanno cercato di mantenere viva la collaborazione internazionale, ma Stati Uniti e Cina, già ai ferri corti per la diatriba sui dazi, oggi sembrano più interessate a sfidarsi sul terreno della corsa al vaccino, in un clima da guerra fredda che ha portato Washington ad accusare Pechino di spionaggio industriale nel tentativo di rubare informazioni utili per trovare un rimedio alla COVID-19.
Dal canto suo, Donald Trump ha promesso 300 milioni di dosi entro fine anno, anzi, a partire da novembre, giusto in tempo per le elezioni presidenziali. Naturalmente, destinate soltanto ai cittadini americani (ma in questo caso sarebbe meglio parlare di elettori). Possibile? Dietro di lui, Anthony Fauci, a capo della task force di esperti della Casa Bianca contro la COVID-19, di solito molto prudente, ha applaudito. Sotto la sua guida esperta saranno monitorati i 14 progetti più promettenti e, non appena emergerà un candidato con buone probabilità di successo, si procederà alla produzione, senza neppure attendere l’autorizzazione della Food and Drug Administration, anche al rischio di perdere centinaia di milioni di dollari.
Come nella corsa allo spazio, l’obiettivo è uno solo: arrivare per primi. E per riuscirci Trump ha dato il via libera all’operazione Warp Speed (nel telefilm Star Trek, era il temine che indicava l’ipervelocità delle astronavi), un piano di sviluppo vaccinale con risorse senza precedenti. La direzione è stata affidata all’immunologo Moncef Slaoui, ex responsabile della ricerca della GlaxoSmithKline e al generale Gustave Perna: una coppia che non lascia dubbi sul valore strategico attribuito dagli Stati Uniti alla corsa al vaccino. Del resto, anche in Cina la ricerca è stata militarizzata e le pressioni per battere sul tempo l’avversario hanno già portato a un risultato considerevole: quattro degli otto prototipi in sperimentazione sugli esseri umani sono cinesi.
Ogni scorciatoia potrebbe però rivelarsi molto rischiosa, e non solo per la possibilità di accorgersi di eventuali effetti collaterali soltanto quando il vaccino sarà distribuito su larga scala, ma anche, se ciò dovesse succedere, per l’inevitabile perdita di fiducia che travolgerebbe i programmi di vaccinazione.
E se dovessimo fallire?
D’altro canto, niente assicura che riusciremo a sviluppare un vaccino contro la COVID-19. Quando nel 1984 venne confermata l’origine virale dell’AIDS, si promise un vaccino entro due anni. Fauci, già allora direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, si dimostrò più cauto, avvertendo che nessuno poteva dire quanto tempo sarebbe stato necessario, né se davvero saremmo stati mai in grado di mettere a punto un vaccino. Aveva ragione: ancora oggi non abbiamo un vaccino contro l’HIV.
Così come ancora non abbiamo vaccini contro alcun coronavirus: questo sarebbe il primo. I coronavirus umani furono isolati per la prima volta negli anni Sessanta, ma poiché causavano per lo più un raffreddore nessuno si impegnò nella ricerca di un vaccino almeno finché, nel 2003, non arrivò la SARS. Ma in quel caso la ricerca fu abbandonata per mancanza di finanziamenti quando la malattia scomparve prima del previsto. Oggi le cose potrebbero andare diversamente.
Se invece tutti gli sforzi dovessero fallire, non resterebbe che sperare in terapie più efficaci per trattare le persone contagiate, come avviene per l’AIDS. Purtroppo si stima che, senza vaccino, servirebbero quattro o cinque anni per raggiungere un’immunità di gregge, con costi umani molto elevati. A quel punto la COVID-19 diventerebbe una malattia endemica con cui imparare, nostro malgrado, a convivere.
In ogni caso, spesso neppure la disponibilità di un vaccino consente di sbarazzarsi di una malattia infettiva. Il vaiolo, eradicato alla fine degli anni Settanta dopo un programma di vaccinazione ventennale, resta una felice eccezione, resa possibile anche dal fatto che il virus non aveva ospiti animali e il vaccino garantiva una protezione a vita. Il morbillo, al contrario, continua a circolare fra gli esseri umani nonostante il vaccino, sia per le difficoltà di assicurare programmi vaccinali anche nei Paesi più poveri, sia per la crescente ostilità nei confronti della vaccinazioni.
Durante il briefing del 13 maggio, Mike Ryan, direttore del programma di emergenze sanitarie dell’OMS, ha sottolineato che, per averla vinta sul nuovo coronavirus, oltre a un vaccino molto efficace e disponibile per tutti, avremo bisogno della volontà dei cittadini a vaccinarsi. Secondo un sondaggio di Morning Consult, tuttavia, oggi solo il 64% degli adulti statunitensi sarebbe disposto a vaccinarsi contro la COVID-19, il 14% è contrario, il 22% è indeciso. Nella fascia fra 35 e 44 anni, la percentuale gli intervistati disponibile a vaccinarsi scende al 53%. A riprova di quanto ogni rimedio tecnologico, per essere davvero efficace, richieda fiducia e cooperazione.
È infine possibile che, come racconta Gina Kolata sul New York Times, prima di trovare una soluzione medica, la pandemia arrivi a una “conclusione sociale”, indotta dall’assuefazione al pericolo. In fondo è accaduto anche per l’HIV che, in mancanza di un vaccino, ci costringe a prendere alcune precauzioni per limitare il rischio di contagio, senza però che l’epidemia sia più percepita come un’emergenza.
Forse anche i coronavirus del raffreddore, quando hanno infettato per la prima volta gli esseri umani, erano più letali e in grado di scatenare una pandemia. Il sospetto è che l’ultima volta possa essere accaduto nel 1889 con l’influenza russa, una pandemia forse causata da un coronavirus che emerse nell’Asia centrale per diffondersi in pochi mesi in tutto il mondo, uccidendo un milione di persone. SARS-CoV-2 potrebbe seguire lo stesso destino e aggiungersi ai tanti malanni di stagione che già conosciamo. Stavolta, tuttavia, abbiamo l’opportunità di interferire nel processo naturale sviluppando un vaccino efficace. Non basterà a sbarazzarci del nuovo coronavirus, ma potrebbe salvare milioni di vite. E forse ridisegnare gli equilibri geopolitici del mondo così come lo abbiamo conosciuto.
Leggi anche: In sala parto ai tempi del Covid-19
Articolo pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()
Immagine: Pixabay