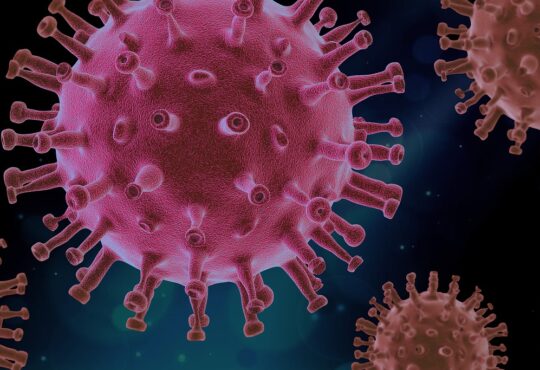Decidere in condizioni di incertezza durante l’emergenza Covid-19
La scienza non può offrire certezze inconfutabili, ma per orientare le politiche pubbliche nelle situazioni di crisi possiamo contare sui principi della gestione partecipata del rischio.
Nei giorni scorsi la pretesa di avere «certezze inconfutabili» dalla comunità scientifica per affrontare l’emergenza COVID-19 avanzata dal ministro Francesco Boccia, titolare del dicastero per gli Affari regionali e le autonomie, ha scatenato un mare di polemiche. In un’intervista al Corriere della Sera, Boccia ha cercato di eludere una domanda sul ritardo dei test affermando: «Chiedo alla comunità scientifica, senza polemica, di darci certezze inconfutabili e non tre o quattro opzioni per ogni tema. Chi ha già avuto il virus, lo può riprendere? Non c’è risposta. Lo stesso vale per i test sierologici. Pretendiamo chiarezza, altrimenti non c’è scienza. Noi politici ci prendiamo la responsabilità di decidere, ma gli scienziati devono metterci in condizione di farlo».
Per ricordare al ministro che non si possono chiedere certezze inconfutabili alla scienza c’è chi ha scomodato Karl Popper, secondo cui, come ben noto, una teoria può essere considerata scientifica soltanto se è confutabile. A ben guardare, però, nelle situazioni di crisi – siano esse di natura economica, politica o, come accade oggi, sanitaria – la delega delle scelte a qualche forma di governo tecnocratico è un espediente ricorrente. Così non sorprende se, nell’oggettiva difficoltà di affrontare la pandemia, gli esperti scientifici sono tornati al centro dell’arena mediatica e politica, arrivando a dettare l’agenda alla politica.
Scienza e società
La tentazione di affidare a una task force di esperti l’ingrato compito di levare le castagne dal fuoco incontra però due grossi ostacoli. Il primo deriva dal fatto che le politiche pubbliche hanno sempre ricadute etiche, economiche e sociali che vanno ben al di là degli aspetti tecnico-scientifici. E ciò vale a maggior ragione per le decisioni che siamo chiamati a prendere in questi giorni drammatici, secondo molti osservatori destinate a influenzare le nostre vite anche nel post-emergenza. In democrazia la politica non può certo abdicare al suo ruolo delegando le scelte cruciali a un manipolo di esperti, per quanto illuminati possano essere. Tanto meno se di questi esperti non conosciamo neppure l’identità: i nomi dei componenti della task force che consiglia il governo per la COVID-19 sono stati resi pubblici soltanto lo scorso 20 aprile, quasi tre mesi dopo la dichiarazione dello stato di emergenza in Italia.
Il secondo problema è che nella gestione del rischio molte decisioni devono essere prese in condizioni di incertezza, quando cioè le conoscenze disponibili non sono sufficienti a indicare una soluzione univoca. Questo è tanto più vero di fronte a un rischio emergente, categoria in cui rientra la minaccia di un nuovo agente infettivo. La natura del coronavirus SARS-CoV-2 è ancora in parte sconosciuta e, per fare un solo esempio, non sappiamo con certezza se le persone guarite possano ammalarsi una seconda volta, o al contrario se, come probabile, sviluppino un’immunità; né se questa immunità sia permanente oppure temporanea; e neppure, nel caso sia temporanea, quanto a lungo può durare, forse uno o due anni, chi lo sa. Lasciando così il ministro Boccia e il governo interno senza certezze sulla possibilità di individuare gli immuni con i test sierologici che, a loro volta (ormai non vi sorprenderà) non sono affidabili al 100%, e quanto siano o meno affidabili è ancora oggetto di studio.
Convivere con l’incertezza
In questo contesto poco importa se con il progredire delle ricerche alcune di queste incertezze troveranno risposta, mentre altre resteranno nel limbo dell’imponderabile: in una situazione di crisi o di emergenza le decisioni non possono essere rinviate; vanno prese ugualmente, anche in assenza di certezze. Quel che stiamo vivendo con la pandemia di COVID-19, del resto, vale anche per la crisi climatica, dove procrastinare l’azione significa aggravare la situazione, talvolta in modo irreversibile. Del resto, l’incertezza è una condizione tutt’altro che infrequente pure nella nostra vita quotidiana, dove siamo costretti a prendere gran parte delle nostre decisioni in base a conoscenze limitate e incomplete.
Le società industrializzate della prima metà del Novecento avevano cercato di esorcizzare l’incertezza mediante il calcolo probabilistico dei rischi, ma oggi siamo chiamati a confrontarci con fenomeni globali che, per la loro intrinseca complessità, rendono più difficile, se non impossibile, quantificare i rischi in modo affidabile prima che le loro conseguenze si manifestino. E se da un lato la comprensione di questi fenomeni richiede una solida expertise tecnico-scientifica, dall’altro la portata delle ricadute sociali delle decisioni che siamo costretti a prendere in condizioni di incertezza impone un più ampio coinvolgimento pubblico, facendo della gestione del rischio un problema non più esclusivamente tecnico, ma anche politico e sociale.
La governance dei rischi è una faccenda complessa persino in tempo di pace, figuriamoci nel bel mezzo di un’emergenza. Ma se è questo lo scenario, occorre chiedersi di che scienza e di che politica abbiamo più bisogno per venire a patti con l’incertezza. Citando gli scienziati sociali Silvio Funtowicz e Jerome R. Ravetz, dovremmo adottare la prospettiva della scienza post-normale, che riconosce l’incertezza come un fattore cruciale della gestione del rischio, imponendo una maggiore partecipazione ai processi decisionali. Come diceva John Kemeny, la scienza non può dirci dove andare, ma una volta che abbiamo preso questa decisione fondandola altrove, può indicarci la strada migliore per giungerci.
I limiti delle conoscenze
Nella gestione dei rischi il punto di partenza è l’ammissione dell’incertezza. In altre parole, abbiamo bisogno di esperti che sappiano dire «non lo so» e riconoscere i limiti delle conoscenze anche in una situazione di crisi, quando per salvare vite può essere indispensabile condividere in modo tempestivo e trasparente le informazioni disponibili sul pericolo, comprese quelle ancora incerte o incomplete. È infatti nelle primissime fasi di un’emergenza, quando inevitabilmente prevale l’incertezza, che ci si gioca gran parte dell’esito finale.
Ecco perché già nel 2005, nel bel mezzo dell’allarme causato dal virus H1N1, Margaret Chan, allora responsabile per l’influenza aviaria e futura direttrice generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), non esitò ad ammettere pubblicamente l’incertezza sugli sviluppi dell’epidemia: «Avere a che fare con un virus emergente è un’esperienza umiliante, come ho scoperto a mie spese. Non dovremmo pretendere di sapere cosa succederà. L’epidemia sarà lieve o severa? Quali fasce d’età saranno più colpite? Semplicemente non lo sappiamo. […] Io devo dire alle persone cosa sappiamo, e la verità è che davvero non lo sappiamo».
Chan era stata un funzionario del governo cinese e due anni prima aveva vissuto le conseguenze del tentativo di nascondere la SARS, comprendendo il valore della trasparenza nella comunicazione del rischio per mantenere la fiducia dei cittadini. La tempestività e la trasparenza dell’OMS nel fornire al pubblico tutte le informazioni sul rischio, senza negare l’esistenza di aree di incertezza e di ignoranza sugli sviluppi dell’epidemia, sono oggi considerate requisiti fondamentali per un’efficace comunicazione del rischio, e costituiscono un modello adottato da molte altre istituzioni internazionali per favorire la cooperazione nella gestione dell’emergenza.
Una lezione appresa negli anni Novanta dalla fallimentare gestione della BSE in Europa, quando l’incertezza sulle possibilità di contagio agli esseri umani, anziché essere considerata un campanello d’allarme, portò all’erroneo convincimento che non sarebbe potuto accadere, impedendo di assumere le precauzioni necessarie. In tempi più recenti, un errore simile è stato compiuto nella gestione del terremoto dell’Aquila, nel 2009, quando l’incertezza sull’evolversi dello sciame sismico venne trasformata nell’infondata certezza che non ci sarebbero state scosse più violente, assimilando così la bassa probabilità a un rischio nullo e mettendo in pericolo la vita delle persone.
Le politiche dell’incertezza
Per quanto riguarda il decision making, abbiamo invece bisogno di politici disposti ad ascoltare gli esperti, certo – rifacendosi però al consenso raggiunto nella comunità scientifica, anziché dare retta al singolo virologo con tanti follower o all’immunologo così bravo a parlare in tv – ma anche di promuovere un dialogo continuo con la società, coltivato in tempo di pace e valorizzato durante l’emergenza. Infine, abbiamo bisogno di scelte coraggiose di fronte incertezza, che non può mai essere un alibi per rinviare gli interventi.
Ancora una volta è possibile rifarsi alle esperienze maturate nella gestione dei rischi e adottare quel che è oggi considerato un principio guida nelle politiche dell’incertezza: in senso ampio, lo si può definire un principio precauzionale che, nella sua formulazione più semplice, prescrive di «sbilanciarsi sempre dalla parte della sicurezza». L’esperienza empirica insegna infatti che, sebbene le prime fasi dell’emergenza siano spesso caratterizzate da un alto grado di incertezza, è preferibile prepararsi ad affrontare lo scenario peggiore, adottando in modo preventivo le misure che possono contribuire a scongiurarlo, anche se magari non si verificherà, piuttosto che attendere di avere informazioni certe per intervenire, quando per molte persone potrebbe essere ormai troppo tardi. Come dice il proverbio inglese, better safe than sorry: meglio sovrastimare il rischio, ma restare al sicuro, che sottostimarlo, e doversi dispiacere per le conseguenze.
Infine, c’è un unico modo di non trovarsi impreparati quando gli eventi precipitano e l’incertezza alimenta i dubbi rischiando di paralizzare l’azione: pianificare in tempo di pace gli interventi in risposta ai diversi scenari di rischio. In altre parole, predisporre un piano di emergenza, condiviso fra le istituzioni deputate a gestire la crisi, con l’inclusione attiva della società civile. Un piano strategico partecipato può consente di fare quel che in emergenza risulta spesso impossibile: anticipare gli eventi, agire in modo proattivo, assicurare la cooperazione della cittadinanza. Da sempre il miglior antidoto contro l’incertezza è immaginare le nostre risposte alle incognite del futuro. Per i rischi ricorrenti – terremoti, alluvioni e anche epidemie – l’esperienza consente di delineare gli scenari possibili e le contromosse più efficaci. Incertezza permettendo, naturalmente.
Leggi anche: La perdita di gusto e olfatto in COVID-19
Articolo pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()
Foto di copertina: Pixabay