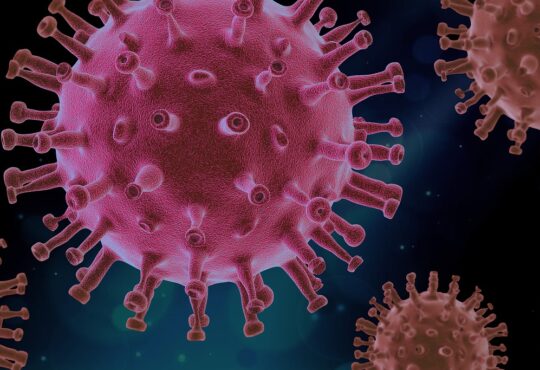Perché l’Asia ha gestito meglio la pandemia di Covid-19
L’esperienza della Sars, protocolli di tracciamento collaudati, diverse abitudini sociali, nessuna negazione del rischio: ecco come l’estremo oriente è riuscito a fermare la diffusione del coronavirus
Nonostante la pandemia di COVID-19 abbia avuto origine in Cina e non abbia risparmiato le popolazioni confinanti, i governi dell’estremo oriente hanno avuto maggiore successo nell’arginare il contagio rispetto all’occidente. Mentre l’Europa e il continente americano sono funestati dalla seconda ondata pandemica, a Taiwan, Singapore, Hong Kong, Corea del Sud, Vietnam e nella stessa Cina il numero delle infezioni resta limitato a poche decine o al più a qualche centinaia di nuovi casi al giorno. Non è semplice spiegare le ragioni di questo successo perché sono il risultato di un complesso intreccio di fattori organizzativi, sociali e culturali. Ma a un anno di distanza dalla scoperta del coronavirus SARS-CoV-2 tra gli avventori del mercato di Wuhan, vale la pena chiedersi se c’è qualcosa che possiamo imparare dalla gestione dell’emergenza nell’Asia orientale.
Reazione rapida
Un fattore decisivo per riuscire a domare la prima ondata epidemica è stata la rapidità con cui i governi hanno introdotto le misure di contenimento. Una reazione rapida da sola non basta a fermare un virus così contagioso, ma offre senz’altro un grande vantaggio per non perdere il controllo sugli eventi. Taiwan, per esempio, aveva attivato il tracciamento di tutti i passeggeri in arrivo da Wuhan fin dalle prime incerte notizie di una polmonite anomala circolante in Cina. Prima ancora che la COVID-19 fosse identificata, il sistema di contact tracing e le prime norme di distanziamento sociale erano già entrate in vigore. La vicinanza geografica con l’epicentro dell’epidemia, e forse anche il fatto che Taiwan aveva un epidemiologo come vicepresidente, hanno certamente giocato un ruolo importante, ma ha contribuito anche il sospetto che la situazione potesse essere peggiore di quanto ammesso dalle autorità cinesi.
Tuttavia, se questa risposta rapida ha funzionato è stato anche perché non è stata affatto improvvisata. Sull’esperienza delle precedenti epidemie di SARS (2003) e MERS (2015), nei Paesi dell’Asia orientale i piani pandemici erano pronti e collaudati. In Corea del Sud il sistema di contact tracing era stato persino messo alla prova mediante un’esercitazione svolta in dicembre. E così, quando è arrivata l’epidemia di COVID-19, i Paesi dell’estremo oriente avevano già strategie e protocolli operativi. In Europa e in Nord America, al contrario, quel che stava accadendo in Cina è stato percepito come un problema lontano. Del resto, con l’eccezione del Canada, l’epidemia di SARS aveva causato solo poche infezioni tra i viaggiatori occidentali di rientro dall’estremo oriente. Di fronte ai primi allarmi per la COVID-19, si è perciò pensato soprattutto a rafforzare i controlli negli aeroporti, supponendo, a torto, che anche questa volta il contagio potesse restare confinato in Asia.
In fondo erano decenni che l’occidente non viveva un’epidemia con gravi effetti sulla salute pubblica. L’ultima pandemia, quella causata nel 2009 dal virus H1N1 dell’influenza suina, aveva allarmato il mondo intero, ma alla fine, in termini di vittime, non si era rivelata peggiore di un’influenza stagionale. E così, nonostante negli ultimi anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) avesse più volte esortato i governi ad aggiornare i piani pandemici e a rafforzare i loro sistemi sanitari, nelle nazioni occidentali pochi avevano preso sul serio l’avvertimento. E mentre l’Europa stringeva i cordoni della borsa alla sanità pubblica, in oriente il campanello d’allarme della SARS aveva suonato abbastanza forte da indurre i governi a consolidare la capacità di risposta per la prossima epidemia. In Vietnam, per esempio, dove a oggi si sono registrati poco più di 1.300 casi e appena 35 vittime, tra il 2000 e il 2016 la spesa pro capite in salute pubblica è aumentata in media del 9% all’anno. Solo quando l’epidemia di COVID-19 è dilagata anche in occidente abbiamo scoperto di non essere affatto al sicuro né preparati a fronteggiare la minaccia.
Spezzare la catena del contagio
Quel che più sarebbe servito era un sistema di contact tracing per identificare e isolare le persone infette, interrompere la catena del contagio e spegnere sul nascere ogni focolaio. Ben presto si è capito che non si poteva prescindere da un impiego massiccio di test perché, a differenza della SARS, la COVID-19 può essere trasmessa anche da persone asintomatiche. In Corea del Sud, il Paese più colpito dopo la Cina nella prima fase della pandemia, è stato possibile arginare la diffusione del contagio solo con un ampio ricorso ai tamponi molecolari e a un rigoroso tracciamento delle infezioni.
La scorsa primavera, tuttavia, la disponibilità di tamponi in Europa era così limitata che i test venivano per lo più riservati alle persone ospedalizzate. Potevano dunque servire a confermare l’infezione, ma non avevano alcuna utilità per il contact tracing. Negli Stati Uniti è andata anche peggio perché i test messi a punto dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erano difettosi, mentre l’approvazione di quelli prodotti dai laboratori indipendenti è stata ritardata per settimane da difficoltà burocratiche.
Passata la prima fase dell’emergenza, si è capito che senza un contact tracing affidabile non sarebbe stato possibile gestire una seconda ondata autunnale. Eppure, sebbene il sistema sia stato indubbiamente rinforzato – in Italia si è passati dai circa 30 mila test giornalieri della scorsa primavera agli oltre 200 mila odierni – è evidente che la contagiosità di SARS-CoV-2 è stata ancora una volta sottovalutata, giacché in Europa, con poche eccezioni, il contact tracing si è rivelato il tallone d’Achille anche durante la seconda ondata. In Italia è diventato chiaro a metà ottobre, quando abbiamo visto le lunghe colonne di automobili ai drive through e le autorità sanitarie sono state costrette ad ammettere che in diverse regioni il tracciamento era ormai saltato. Tradotto: l’epidemia era fuori controllo e non restava altra opzione che reintrodurre restrizioni più severe.
Il modello è la SARS, non l’influenza
Il fatto che in Occidente il modello dominante per la gestione delle epidemie faccia riferimento ai virus influenzali non è stato di aiuto. Come abbiamo raccontato su OggiScienza in questo articolo, infatti, il coronavirus della COVID-19 si diffonde prevalentemente a grappoli (o cluster, nel gergo degli epidemiologi) sfruttando i cosiddetti eventi di superdiffusione. Questo implica che una percentuale minoritaria di persone infette sia responsabile della gran parte dei contagi. In realtà è così per molti virus, compresi quelli della SARS e della MERS su cui sono stati costruiti i piani pandemici dei Paesi asiatici, ma non per l’influenza, che si diffonde in modo più uniforme nella popolazione.
È una distinzione importante perché ha implicazioni pratiche nella scelta delle misure più efficaci per contenere l’epidemia. La diffusione a grappoli impone infatti di concentrare gli sforzi nei luoghi in cui è più probabile che possa verificarsi la superdiffusione: bar, ristoranti, palestre, mezzi di trasporto, chiese, sale riunioni, residenze per anziani, prigioni, ecc. Si tratta per lo più di ambienti al chiuso, spesso poco ventilati, dove le persone condividono spazi ristretti e dove non indossano la mascherina per conversare, bere, mangiare o fare attività fisica.
È inoltre probabile che in questi ambienti svolga un ruolo più importante la trasmissione mediante aerosol, che si deve contrastare indossando sempre la mascherina, arieggiando spesso i locali ed evitando di parlare ad alta voce. In Giappone, per esempio, dove la strategia di contenimento si è concentrata su questi aspetti, i parchi pubblici sono stati lasciati aperti ma con il divieto di urlare o cantare, in metropolitana si deve restare in silenzio e persino negli stadi è vietato fare il tifo.
La forza del tracciamento retrospettivo
Il modello di diffusione a grappoli ha implicazioni anche sulle modalità con cui viene condotto il contact tracing perché risulta più efficace sottoporre a tampone tutte le persone presenti nel luogo in cui si è originato il focolaio, piuttosto che rintracciare chi nei giorni seguenti è venuto in contatto con la persona infetta. Si parla di contact tracing retrospettivo perché si concentra sull’origine del contagio anziché sulle trasmissioni successive, considerate meno probabili perché nel modello di trasmissione a grappoli la gran parte delle infezioni avviene durante gli eventi di superdiffusione.
L’idea implicita è quella di sopprimere la diffusione virale spegnendo sul nascere ogni focolaio fino a ridurre a zero le infezioni, anziché limitarsi a controllare l’epidemia tenendo basso (qualche centinaia di casi al giorno, a livello nazionale) il numero di nuovi casi giornalieri. Per riuscirci, ancora una volta, è però necessaria una vigilanza continua, basata sull’impiego massiccio di test mirati, e il ricorso a severi lockdown nelle zone interessate dai focolai, che devono essere prolungati fino alla completa soppressione della catena del contagio.
In Cina, dove non si è avuta una seconda ondata e la vita quotidiana è tornata pressoché normale, non si esita a sottoporre a tampone intere metropoli pur di spegnere focolai costituiti anche da due o tre casi. Nelle scorse settimane è accaduto in città come Shanghai, Tianjin, Kashgar e Manzhouli, dove in pochi giorni milioni di persone sono state sottoposte a tampone in risposta a un numero di contagi che si potevano contare sulle dita di una mano. È la strategia perseguita anche in Australia e in Nuova Zelanda, dove non si è esitato a ricorrere a lockdown prolungati per oltre tre mesi di fronte a qualche centinaio di casi.
Sotto sorveglianza
Si è molto parlato dell’impiego intrusivo delle tecnologie di sorveglianza impiegate in oriente per tracciare l’epidemia, spesso a scapito della privacy delle persone. In Corea del Sud, per esempio, sono stati integrati i dati raccolti con la localizzazione dei telefoni cellulari, le transazioni delle carte di credito e le numerose telecamere a circuito chiuso disseminate in ogni angolo del Paese. Tutto questo è stato possibile grazie a una riforma approvata nel 2015 per fronteggiare la MERS e lasciata in vigore in previsione di una futura pandemia. Ancora una volta, dunque, si trattava di un sistema già collaudato e operativo prima dell’emergenza.
In quest’ambito gli aspetti normativi e socioculturali sono però cruciali. Nel bene e nel male, le app di tracciamento europee hanno dato più enfasi alla tutela della privacy dei cittadini, ma finora si sono rivelate di scarsa utilità per il tracciamento dei contagi. Talvolta anche perché non è stato organizzato un sistema per dare seguito alle segnalazioni degli utenti, trascurando il fatto che la tecnologia può offrire un valido strumento di supporto ma non può sostituire il lavoro manuale di tracciamento.
Secondo Michael Ryan, direttore per le emergenze sanitarie dell’OMS, un altro fattore molto importante è il monitoraggio delle persone in isolamento, che nei Paesi dell’Asia orientale è molto rigoroso. La quarantena viene infatti scontata in apposite strutture residenziali per evitare i contagi in famiglia, ma per assicurare il rispetto del confinamento a Hong Kong si arriva a impiegare braccialetti elettronici, mentre a Singapore le persone isolate sono contattate diverse volte al giorno da appositi operatori. Sono misure molto efficaci ma difficilmente accettabili per i cittadini occidentali.
Cambiare le nostre abitudini
Nel corso di questi mesi siamo stati costretti ad abbandonare alcune delle nostre abitudini sociali più consolidate: stringerci la mano per salutarci, andare ogni mattina a scuola o in ufficio, festeggiare con amici e parenti i momenti importanti della vita. Le routine sono spesso difficili da modificare: serve una forte motivazione, una chiara comprensione delle ragioni che lo rendono necessario e il tempo per adattarsi alle nuove consuetudini. Ecco perché è così importante che le istituzioni esercitino quel ruolo di guida credibile e coerente nella gestione dell’emergenza, che non può realmente funzionare senza la cooperazione della cittadinanza.
In molti Paesi dell’Asia orientale, tuttavia, alcune differenze di abitudine potrebbero avere reso tutto più semplice anche laddove, come in Cina e a Hong Kong, scarseggia la fiducia nelle istituzioni governative. Indossare le mascherine, per esempio, era una prassi diffusa già prima della pandemia per proteggersi dallo smog o per tutelare le altre persone quando si è raffreddati. Inoltre, le distanze interpersonali tra estranei spesso sono maggiori, mentre l’atto di stringersi la mano, abbracciarsi o baciarsi in segno di saluto è poco diffuso. Oggi che sappiamo quanto siano importanti le mascherine e il distanziamento sociale, non è difficile comprendere che queste diverse abitudini si sono rivelate un vantaggio.
Il negazionismo dei governi fa vittime
Durante un’emergenza, però, il ruolo di maggiore responsabilità spetta alle istituzioni e i governi asiatici, memori dell’esperienza con la SARS, si sono ben guardati dal cercare di sminuire il rischio del nuovo coronavirus. È un atteggiamento sano perché ogni tentativo di ridimensionare le minacce induce le persone ad abbassare la guardia e a esporsi maggiormente ai pericoli. In Italia è successo una prima volta a fine febbraio, con il risultato di dare una spinta decisiva alla prima ondata, e una seconda volta quest’estate, con un prematuro «liberi tutti» che gli esperti additano a causa della risorgenza dell’epidemia. «Negli Stati Uniti e in Europa volevamo riavere le nostre vite, quindi abbiamo agito come se il virus fosse sotto controllo», ha detto al Wall Street Journal Ashish Jha, decano della Brown University School of Public Health. «In Asia, anziché negare l’evidenza, hanno invece capito che avrebbero potuto riavere indietro la loro vita soltanto seguendo alcune precauzioni».
Persino in Cina, dopo un deprecabile tentativo iniziale di nascondere la pandemia che per diversi giorni ha impedito al mondo di sapere quel che stava avvenendo a Wuhan, le autorità di Pechino non hanno più sottovalutato la gravità della situazione, imponendo misure drastiche per riprendere il controllo della situazione. All’opposto, non è certo un caso se Stati Uniti, India e Brasile, dove per mesi i rispettivi governi hanno ostinatamente cercato di negare e sminuire il pericolo, sono i tre Paesi con più contagi e vittime. Se tempestività, trasparenza e precauzione possono salvare vite, non c’è dubbio che il negazionismo dei governi possa causare gravi danni, e questa terribile pandemia ne è l’ennesima conferma.
Leggi anche: Il coronavirus dei visoni che potrebbe mettere a rischio il vaccino per la Covid-19
Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. 
Immagine: Jérémy Stenuit, Unsplash