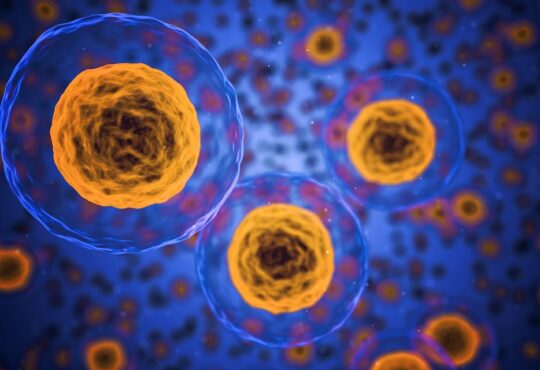SALUTE – Il principale componente psicoattivo della marijuana, il THC (comunemente chiamato tetraidrocannabinolo) ha la potenzialità di sopprimere le funzioni immunitarie del nostro corpo, agendo su molecole chiamate istoni ed eliminando così l’infiammazione, che in questa circostanza è benefica. Da un diverso punto di vista questa scoperta, risultato delle ricerche del team di Mitzi Nagarkatti della University of South Carolina, potrebbe aprire nuove possibilità per l’utilizzo terapeutico della marijuana nel trattamento delle malattie autoimmuni come artrite, lupus, colite, sclerosi multipla e via dicendo, nelle quali l’infiammazione gioca un ruolo fondamentale. La pianta in questione -e il suo utilizzo a scopi terapeutici e non- è ancora al centro di dibattiti ideologici in cui visioni contrapposte non trovano un punto d’accordo: quanto possono essere promettenti ricerche di questo tipo? Quali i limiti nell’ottica di un utilizzo prolungato del THC per trattare le malattie autoimmuni? Ne parliamo con Elio Acquas dell’Isituto Nazionale di Neuroscienze, esperto in farmacologia delle sostanze d’abuso.
In che modo è stato osservato il meccanismo scatenato dal THC nello studio?
Partendo dall’osservazione che la marijuana ha proprietà immunomodulatorie, gli scienziati hanno investigato -su un campione di topi- le conseguenze dell’esposizione in vivo al principio attivo sulla metilazione e acetilazione degli istoni nei linfociti T, dopo aver evocato una significativa risposta antigenica. Lo scopo dello studio era verificare se le proprietà anti-infiammatorie della THC possano essere mediate da modificazioni epigenetiche. Il team ha analizzato metilazioni e acetilazioni degli istoni nelle cellule di linfonodi poplitei murini, a intervalli opportuni da due somministrazioni di THC (20 mg/kg i.p.). A tutti i topi era stata iniettata, in precedenza, un’enterotossina B stafilococcica.
Che cosa hanno osservato, nell’immediato?
I risultati pubblicati sul Journal of Biological Chemistry dimostrano complesse modificazioni stimolatorie nell’espressione genica per le citochine nelle cellule Th2 e, all’opposto, complesse modificazioni inibitorie dell’espressione genica per le citochine nelle cellule Th1. In base a queste osservazioni, si aprono importanti prospettive verso le conseguenze epigenetiche dell’esposizione al THC, dal punto di vista della risposta immunitaria. Risultati in accordo con studi precedenti che avevano dimostrato simili azioni epigenetiche da parte dell’endocannabinoide endogeno anandamide [qui la ricerca] e sull’espressione genica da parte del cannabinoide di sintesi HU210 in altri tipi cellulari in studi in vitro [qui la ricerca].
Quali sono i limiti dello studio, ipotizzando un utilizzo del THC per trattare pazienti umani?
Come riconoscono gli stessi autori, rimane aperta una serie di domande. Resta ancora da determinare:
- se gli effetti rilevati si estendono anche a risposte indotte da altri antigeni;
- se si tratta di risposte transitorie o permanenti;
- se anche altri enzimi, responsabili delle metilazioni e acetilazioni istoniche, possono essere coinvolti nel trattamento con THC.
A tali questioni se ne aggiungono altre. Lo studio non chiarisce quali recettori (CB1 o CB2) siano responsabili degli effetti, né le potenziali conseguenze di un’esposizione cronica al THC. Va inoltre determinata la rilevanza di tali dosi e tempistiche di somministrazione del THC rispetto al suo potenziale di dare dipendenza. Sono necessari studi comparativi per stabilire se tali effetti siano comparabili, migliori e/o sostitutivi rispetto a quelli di altre terapie.
Come spesso accade per studi che indagano le potenzialità terapeutiche di simili principi attivi, quindi, possiamo dire che è ancora presto per poter trarre conclusioni robuste?
Lo studio offre certamente evidenze importanti e degne di futuri approfondimenti. Le stesse domande rimaste aperte, come ammesso dagli stessi autori, suggeriscono cautela contro facili entusiasmi a favore dell’impiego terapeutico della marijuana in toto o del THC. Cautela dettata dal fatto che, se da una parte questo studio contribuisce alla comprensione di un meccanismo alla base di un fenomeno noto da tempo, dall’altra è lungi dall’offrire un’inequivocabile dimostrazione della validità di questo approccio terapeutico. In altre parole, soprattutto a livello della stampa divulgativa, seppur specializzata, sarebbe auspicabile l’applicazione del principio di precauzione alla base della cultura scientifica. L’utilizzo di parti di piante con finalità terapeutiche è una pratica antica, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Ci troviamo tuttavia in un’epoca in cui la tecnologia e la sintesi farmaceutica sono -per certi versi a pieno titolo- approcci imprescindibili per la prevenzione e la cura delle malattie. Potrebbe dunque sorprendere che si voglia investigare, con approcci e tecniche all’avanguardia come quelle per la determinazione delle modificazioni epigenetiche conseguenti ad un trattamento farmacologico, i meccanismi alla base di proprietà terapeutiche note da secoli. Se a questo aggiungiamo che la pianta in questione è famosa per essere al centro di vecchie battaglie ideologiche in cui opposte visioni continuano ancora a contrapporsi, come è il caso della marijuana, allora la sorpresa potrebbe esser ancora maggiore.
Crediti immagine: M. Martin Vicente, Flickr