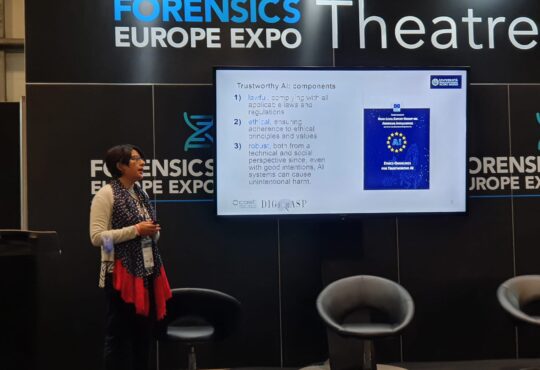Prosopagnosia e vespe cartonaie: le meraviglie del riconoscimento facciale
I volti sono stimoli cruciali nella vita di tutti i giorni, non solo per noi ma in molte altre specie. E continuano a riservarci sorprese: l'area del cervello coinvolta nel riconoscimento facciale prolifera mentre cresciamo.

Il fatto che ci fossero altri come me divenne chiaro in molteplici modi. L’incontro tra due persone che soffrono di prosopagnosia, in particolare, può essere davvero complicato. Qualche anno fa ho scritto a uno dei miei colleghi per dirgli che avevo molto apprezzato il suo nuovo libro. Il suo assistente chiamò Kate per organizzare una cena e si accordarono per il weekend, in un ristorante nel mio quartiere. “Potrebbe esserci un problema”, disse Kate. “Il Dr. Sacks non è in grado di riconoscere nessuno”. “È lo stesso per il Dr. W.”, rispose il suo assistente”. “Un’altra cosa”, aggiunse Kate. “Il Dr. Sacks non è in grado di trovare i ristoranti o altri posti; si perde molto facilmente, alle volte non trova neanche casa sua”. “È lo stesso per il Dr. W.”, rispose il suo assistente. Alla fine riuscimmo a incontrarci e fu una cena piacevole. Ma non ho idea di che aspetto abbia il Dr. W. e anche lui, probabilmente, non saprebbe riconoscermi (A Neurologist’s Notebook, Oliver Sacks)
APPROFONDIMENTO – Fino a non molto tempo fa si pensava che la prosopagnosia, l’incapacità di riconoscere i volti, fosse un disturbo raro causato da un danno neurologico, come un ictus. Poi è diventato evidente che ne soffrivano molte più persone del previsto (la prevalenza oggi è stimata al 2-2,5%) anche senza aver mai subito danni neurologici, e che il meccanismo cerebrale coinvolto nel riconoscimento facciale doveva essere estremamente specifico. Non a caso la prosopagnosia è stata anche definita un deficit “selettivo” del riconoscimento facciale, perché molti altri processi cognitivi, che un tempo ci si aspettava fossero egualmente compromessi, sono in realtà perfettamente funzionanti. Anche la genetica ha dato il suo contributo: uno studio condotto sui gemelli qualche anno fa, per esempio, ha confrontato gemelli monozigoti con gemelli eterozigoti e concluso che l’abilità di riconoscimento facciale molto probabilmente si eredita.
I ricercatori del laboratorio di Bradley Duchaine, nel 2010, hanno sfruttato l’elettroencefalogramma (EEG) per registrare come il cervello delle persone con prosopagnosia rispondeva a immagini di persone famose e hanno scoperto che i potenziali evocati dalle fotografie non erano uguali per tutti. In alcuni partecipanti c’era una risposta già dopo 250 millisecondi, anche se non riconoscevano il soggetto, mentre in altri no. Così Duchaine ha ipotizzato che la prosopagnosia fosse molto più varia del previsto: in alcune persone il cervello aveva l’informazione, ma qualcosa andava storto nel suo processamento, mentre in altre l’impossibilità di riconoscere il volto si collocava a uno stadio ancora precedente. Nel primo caso si parla di covert recognition, ovvero c’è un riconoscimento ma senza consapevolezza: il comportamento o la risposta elettrofisiologica di una persona ci dice che sa chi sta guardando, ma non ne è consapevole.
“Il lobo temporale contiene un gran numero di aree deputate al processamento dei volti”, spiegava Duchaine in un comunicato, “perciò è facile immaginare che questo sistema possa compromettersi in molti modi. Può esserci un’area che non funziona, ma anche le connessioni tra diverse aree possono essere compromesse, ovvero è probabile che ci siano decine di varianti in questa condizione”.
Progettati per riconoscere le facce
I volti sono cruciali nella nostra vita di tutti i giorni, stimoli enormemente informativi: usiamo continuamente l’abilità di riconoscerli, che si tratti di familiari, colleghi di lavoro o dell’edicolante dove compriamo il giornale la domenica mattina, al punto che già da molto piccoli sembreremmo “progettati” per preferire gli stimoli che ci ricordano un volto. Di fronte a uno stimolo simile a una faccia (con due punti in alto per gli occhi e uno in basso per la bocca) e ad altri con i punti disposti diversamente, i nostri neonati preferiscono il primo. D’altronde li aspetta una vita intera in cui vedranno centinaia di migliaia di volti differenti, gran parte dei quali dovranno tenere a mente.
Non siamo affatto unici in questo: anche nelle altre specie riconoscere i volti aiuta a identificare i conspecifici e a distinguerli dai predatori, permette di “leggere” le loro intenzioni, di ricordarsi chi è al di sopra e chi al di sotto di te sulla scala sociale e molto altro. Una pecora può riconoscere fino a 50 volti di pecore e ricordarseli per anni, mentre la vespa cartonaia Polistes fuscatus è perfettamente in grado di distinguere l’una dall’altra le sue compagne nella comunità. Dato il gran numero di regine fondatrici, sapere con chi ha a che fare le permette di rispettare le gerarchie e consente all’intero gruppo di conservare un equilibrio. Una specie imparentata, Polistes metricus, ha molti meno impicci: non è altrettanto abile nel riconoscimento facciale, ma semplicemente perché nella sua colonia c’è un’unica regina.
Il riconoscimento facciale negli esseri umani e nelle altre specie è sempre stato un tema affascinante per le neuroscienze e per le scienze cognitive, per capire come si è evoluto, chi ne è dotato e perché. Non solo per comprendere il meccanismo in sé ma anche per capire meglio disturbi come la prosopagnosia e altri in cui quest’abilità è alle volte compromessa, come la sindrome di Turner, la sindrome di Williams e in alcuni casi i disturbi dello spettro autistico. C’è anche una difficoltà aggiunta: il giro fusiforme, una struttura anatomica del cervello fondamentale per il processamento e il riconoscimento dei volti (che nel giro di 50-400 millisecondi ci dice se stiamo guardando Mariah Carey o nostra zia) per ora è stata identificata solamente nella nostra specie e nelle grandi scimmie, gorilla, scimpanzé, bonobo e oranghi.
Il cervello che non smette di crescere
Ora due studi coordinati dalla scienziata Kalanit Grill Spector, professoressa di psicologia a Stanford, potrebbero cambiare il modo in cui la scienza approccia il riconoscimento facciale. Studiando il cervello dei bambini, un gruppo finora poco considerato (ovviamente) per lo studio della perdita dei tessuti, hanno scoperto che non solo il cervello non smette di crescere come pensavamo, ma che continua ad arricchirsi di nuovi tessuti proprio nella regione deputata al riconoscimento dei volti, che si modifica anche per funzionalità.
Nel primo lavoro, su Cerebral Cortex, Grill Spector e colleghi hanno esaminato le aree responsabili per il riconoscimento facciale scoprendo che hanno una componente cellulare unica nel suo genere; nel secondo, pubblicato su Science, hanno individuato minuscole strutture cerebrali che cambiano di pari passo con l’abilità della persona di riconoscere i volti. Come è potuto sfuggirci, finora, un cervello che cambia?
La sola risonanza magnetica funzionale (MRI) non permette di indagare i tessuti del cervello in profondità, hanno spiegato gli scienziati, che hanno usato un approccio diverso e lavorato su dei campioni prelevati da cervelli post-mortem. Associando quanto trovavano nei tessuti alle regioni identificate da MRI sono riusciti a “estrarre” le strutture cellulari che, si sono resi conto in seguito, mostravano differenze. Si trattava di quelle coinvolte nel riconoscimento dei volti ma anche in quello dei luoghi: non solo c’era una differenza nell’attività ma un particolare tessuto coinvolto nel riconoscimento facciale cresceva con lo sviluppo, contribuendo alle differenze nella struttura del cervello adulto e all’effettiva capacità di identificare i volti. Quale di questi elementi causa gli altri? Ancora non lo sappiamo.
Uno dei possibili responsabili è la mielinizzazione, il processo in cui le fibre nervose vengono ricoperte dalla guaina mielinica, un rivestimento fatto all’80% di grassi, e che solitamente termina alla fine dell’adolescenza. Secondo gli scienziati è improbabile che la mielinizzazione sia l’unico elemento coinvolto, ma combinando la MRI funzionale (che monitora l’attività del cervello) a quella quantitativa (che rivela il rapporto tra tessuti e acqua nel cervello), su un gruppo di 22 bambini e un altro di 25 adulti, si sono accorti che il rivestimento continuava a cambiare nel tempo. “Se potessi camminare nel cervello di un adulto e potessi dare un’occhiata alle cellule, sarebbe come passeggiare in diversi quartieri”, commenta in un comunicato Jesse Gomez, prima autrice del paper su Science. “Le cellule appaiono diverse. Sono organizzate in modo differente”.
Il che è affascinante anche rispetto a quanto sappiamo dello sviluppo del cervello: siamo abituati all’idea della perdita di neuroni (per il normale invecchiamento o a causa delle malattie neurodegenerative) ma quest’organo straordinario fin da piccoli sembra attuare la politica del “less is more”. Fino ai due anni di età circa formiamo nuovi neuroni e nuove sinapsi, a un ritmo incredibile – fino a 40 000 nuove sinapsi al secondo – ma alla fine di questo processo frenetico ci ritroviamo con più connessioni di quante effettivamente ce ne servono. Così ha inizio il pruning, letteralmente la “potatura” di tutte le sinapsi extra che non vengono utilizzate e riducono l’efficienza della nostra rete neurale. Quest’opera di sfrondatura prosegue all’incirca fino a quando compiamo 10 anni e, a quel punto, una buona metà delle sinapsi che avevamo a due sono ormai perdute. In realtà gli scienziati hanno scoperto da poco che qualcosa di simile si verifica anche nel cervello femminile con la gravidanza, a dimostrazione che, lassù, avviene molto più di quanto avessimo anche solo iniziato a immaginare.
Leggi anche: La scienza della coscienza, da Francis Crick ai TED Talk