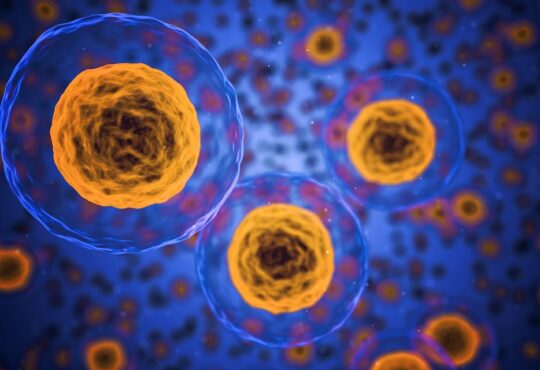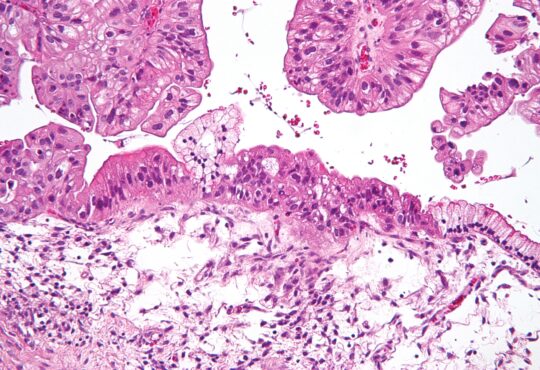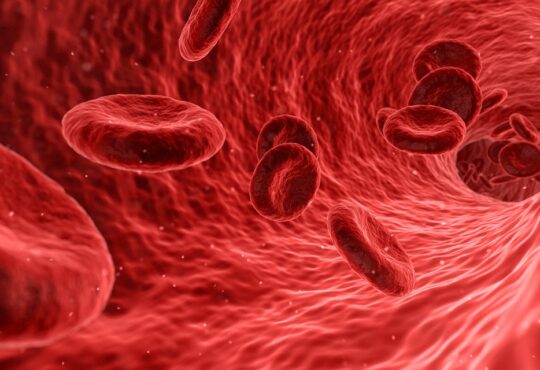Cellule staminali e fertilità: a che punto siamo
Dai primi lavori che suggerivano l'esistenza di cellule staminali ovariche agli ultimi risultati su maturazione in vitro di ovociti e staminali mesenchimali.
Nel 2004 il gruppo di ricerca di Jonathan Tilly, allora alla Harvard Medical School di Boston, pubblicò sulla rivista Nature un articolo che molti non esitarono a definire “rivoluzionario”. L’articolo suggeriva che, almeno in femmine di topo, le ovaie fossero in grado di continuare a produrre nuovi ovociti per tutta la vita degli animali: una posizione in netto contrasto con quello che era riconosciuto da decenni come un dogma assoluto della biologia riproduttiva, cioè la convinzione che la riserva ovarica delle femmine dei mammiferi viene stabilita durante la vita in utero, per cui dopo la nascita sarebbe impossibile formare nuove cellule uovo. Negli anni successivi, sia il gruppo di Tilly sia altri gruppi avrebbero individuato le cellule responsabili della produzione di nuovi ovociti in età adulta in topi e altri mammiferi, esseri umani compresi, suggerendone un futuro, possibile ruolo nell’ambito dei trattamenti per l’infertilità. Sono le famose – e controverse – OSC, dall’inglese Oogonial Stem Cells (cellule staminali in grado di produrre ovociti): cellule che secondo Tilly e altri ricercatori come Evelyn Telfer, dell’Università di Edimburgo, sarebbero caratterizzate dalla presenza in superficie di una proteina chiamata DDX4. Ma a che punto siamo, a distanza di 16 anni, verso il possibile sviluppo di applicazioni cliniche di queste osservazioni.
Diciamolo subito: siamo ancora ben lontani, anche perché non è stata ancora definitivamente risolta la questione dell’esistenza stessa e della natura delle OSC. “Dopo l’uscita dei primi risultati di Tilly il mondo scientifico si è spaccato” commenta Francesca Klinger, professoressa di istologia all’Università di Roma Tor Vergata, che nel suo laboratorio si occupa proprio di biologia della riproduzione e di cellule staminali. “Da una parte c’è chi ‘crede’ – dati alla mano – nell’esistenza e nella possibile utilità di queste cellule, dall’altra chi è scettico sul loro ruolo effettivo o addirittura ritiene – altri dati alla mano – che non esistano”. Non sempre chi ha tentato di riprodurre gli esperimenti di Tilly è riuscito a ottenere gli stessi risultati e sono stati avanzati dubbi sulle tecniche utilizzate dal ricercatore (che nel frattempo ha fondato una company biotecnologica che si occupa di servizi per la fertilità).
È il caso del gruppo di Outi Hovatta, del Karolinska Institutet di Stoccolma, che ha pubblicato pochi giorni fa sulla rivista Nature Communications uno studio sulla caratterizzazione di varie popolazioni cellulari dell’ovaio umano, tra le quali non sono state individuate cellule staminali ovariche. O meglio, sono state individuate cellule con la proteina DDX4 in superficie, che sono però state descritte come periciti (cellule che circondano il rivestimento interno dei capillari sanguigni). Pur dichiarando senza mezzi termini che i dati raccolti “non sostengono l’esistenza di cellule staminali ovariche nelle ovaie di donne adulte, rinforzando così il dogma di una limitata riserva ovarica”, gli autori riconoscono che eventuali OSC presenti in numero molto basso potrebbero essere sfuggite alle loro analisi per ragioni tecniche.
Secondo Klinger, che con il gruppo della collega Elena Bonanno ha avviato un progetto per la ricerca di OSC con un approccio di microscopia elettronica, non è ancora detta l’ultima parola sull’argomento. “Molti – noi compresi – ritengono che nell’ovaio ci sia davvero qualcosa potenzialmente in grado di rispondere a particolari sollecitazioni, dando una mano a una riserva ovarica danneggiata o in via di esaurimento. Quello che rimane da capire è cosa sia esattamente: staminali ovariche, come le chiama Tilly, oppure mesenchimali stromali? E ancora, cellule residenti nell’ovaio oppure provenienti da altre parti come il midollo osseo?”. Se è vero, come afferma un articolo pubblicato nel gennaio 2019 sul British Journal of Obstetrics and Gynaecology da Telfer e altri, che l’applicazione più ovvia delle OSC nell’ambito di trattamenti per l’infertilità sarebbe la produzione di ovociti in vitro, è ovvio dunque che la strada sia ancora lunga. Al di là della ricerca sulle staminali ovariche, però, anche altro si sta muovendo nell’ambito della biologica cellulare della fertilità.
Per esempio è di poche settimane fa l’annuncio dato sulle pagine degli Annals of Oncology della nascita del primo bambino al mondo da ovociti maturati in vitro, in laboratorio (IVM). La mamma del piccolo, che si chiama Jules ed è nato lo scorso luglio, aveva ricevuto a 29 anni una diagnosi di tumore al seno: la chemioterapia e i successivi trattamenti previsti avrebbero sicuramente compromesso la sua fertilità ma le opzioni disponibili per proteggerla erano scarse. In questi casi in genere si procede con il congelamento di ovociti prelevati dopo stimolazione ovarica, ma questa non era possibile per il tipo di tumore che aveva colpito la donna, mentre è stata lei stessa a rifiutare l’altra via disponibile, cioè il congelamento di tessuto ovarico. Da qui l’idea di prelevare ovociti immaturi, che sono stati fatti maturare in laboratorio per 24 ore e infine congelati. Cinque anni dopo, ricevuto l’ok dagli oncologi per un’eventuale gravidanza, gli ovociti sono stati scongelati e fecondati in vitro e gli embrioni ottenuti impiantati in utero, fino alla nascita di Jules.
Attenzione: in questo caso non parliamo di staminali, ma di uno stadio immaturo degli ovociti (che così si presentano alla nascita a maturano poco alla volta nel corso della vita). Si tratta comunque di un risultato importante, perché – come ha sottolineato Richard Anderson del Centro di biologia riproduttiva dell’Università di Edimburgo – “la maturazione degli ovociti in laboratorio è sempre stata una sfida, che richiede abilità tecniche differenti rispetto alla più comune fecondazione in vitro”. Secondo Anderson, il fatto che abbia funzionato rappresenta un avanzamento importante per le donne che ricevono una diagnosi di cancro ma più in generale per le donne e le coppie che si rivolgono alla riproduzione assistita.
Tornando invece a parlare di staminali, è inevitabile chiudere con un accenno alle cellule mesenchimali, da diversi anni al centro di un’esplosione di progetti di ricerca soprattutto nell’ambito della medicina rigenerativa e, ora, anche della biologia della riproduzione. Nell’agosto 2018, per esempio, un gruppo di ricerca guidato da Antonio Pellicer dell’Istituto valenciano di infertilità (IVI), il gruppo privato di riproduzione assistita più grande al mondo, ha annunciato di aver ottenuto risultati molto interessanti in un piccolo campione di donne con scarsa riserva ovarica e ridotta capacità di risposta alla stimolazione ovarica in seguito ad autotrapianto di cellule mesenchimali ottenute dal midollo osseo delle pazienti stesse. Dopo il trattamento, infatti, nella maggioranza dei casi sono migliorati la conta dei follicoli antrali e il livello di ormone antimulleriano, entrambi parametri di stima della riserva ovarica. Secondo gli autori dello studio, questi effetto positivo sarebbe da attribuire alla produzione da parte delle mesenchimali di molecole in grado di mobilizzare la riserva ovarica esistente, in particolare fattori di crescita e fattori angiogenetici (che stimolano la produzione di vasi sanguigni). “L’ipotesi è che queste staminali non svolgano la loro capacità rigenerativa differenziandosi direttamente in ovociti, ma impattando in modo positivo sull’ambiente circostante attraverso la produzione di molecole” precisa Klinger, sottolineando che queste molecole potrebbero un giorno rivelarsi utili anche per proteggere le ovaie in caso di trattamenti chemioterapici. Di nuovo, però, la strada non è breve: “Occorre ancora tanta ricerca, soprattutto di base, che purtroppo è quella sempre più penalizzata”.
Leggi anche: Aborto ricorrente, novità dalla ricerca
Articolo pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()
Immagine: Pixabay