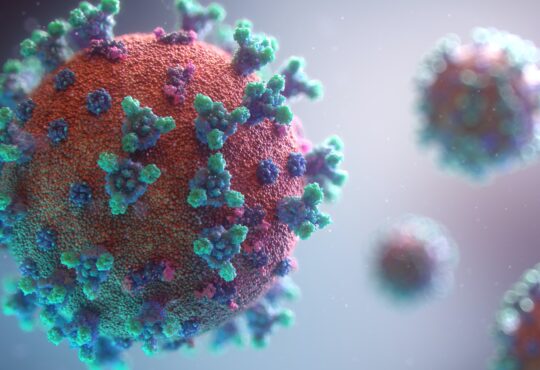Dal Covid-19 all’Aids, passando per la Mers: i nomi sono importanti
Come vengono stabiliti i nomi per i nuovi virus? Ne parliamo con la giornalista e comunicatrice scientifica Roberta Villa.
Covid-19: è l’11 febbraio quando l’OMS assegna un nome al nuovo Coronavirus, undici giorni dopo la dichiarazione di Emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, un mese e undici giorni dopo l’allarme dato dalla Cina rispetto a “una polmonite di causa sconosciuta, rilevata nella città di Wuhan, nella provincia di Hubei, in Cina”. Abbiamo chiesto a Roberta Villa, giornalista e comunicatrice scientifica, membro della task force istituita dal Governo Conte per contrastare le fake news sul virus, di raccontarci la genesi di questo nome.
“In realtà il primo nome viene dato dall’Ictv (International committee on taxonomy of viruses) ed è Sars-Cov2, per la somiglianza genetica del virus con la Sars (Severe acute respiratory syndrome) del 2003. Ma all’Oms decidono che la Sars aveva fatto davvero molta paura, in particolar modo nel sud est asiatico, e l’assonanza non fosse proprio una grande idea. La soluzione? Il virus si chiama Sars-Cov2, la patologia invece Covid-19.”
Con che criteri vengono scelti questi nomi?
“Nel 2015 l’Oms ha stilato un documento che norma la nomenclatura delle nuove malattie. Le indicazioni sono molto precise: no a nomi difficili, che incutono pura o trasmettono incertezza, no a nomi propri, che connotano popolazioni specifiche, paesi o regioni geografiche. Con il nome Covid-19 sono finalmente scomparsi gli attributi che richiamano costantemente alla Cina”.
Virus cinese, virus di Wuhan… quante ne abbiamo sentite? Secondo lei queste denominazioni hanno contribuito ad aumentare la paura delle persone verso la popolazione cinese presente in Italia?
“Più che di paura, io parlerei di stigma. Si tratta di un fenomeno sociale che tende ad attribuire un marchio a un individuo o, come in questo caso, ad un gruppo di persone. Molto frequente durante le epidemie, ha un ruolo preponderante nella diffusione di queste ultime. Identificando la malattia con un target ristretto, si rischia di ritardare la diagnosi qualora quella stessa malattia dovesse insorgere in un individuo esterno alla categoria sulla quale ci si era focalizzati. Questo successe, ad esempio, durante l’epidemia di Mers.“
Cosa successe?
“Come si evince dal nome, la maggior parte dei contagi avvenne in Arabia Saudita, e tutti i casi al di fuori del paese furono di importazione. Mers è infatti l’acronimo di Middle east respiratory syndrome. La Corea del Sud fu il paese più colpito al di fuori del Medio Oriente: 186 casi, 36 morti. Ma cosa successe? Localizzando mentalmente la malattia, ci fu un enorme ritardo nella diagnosi di un paziente. Si, una sola persona, un uomo di 68 anni che, tornato da un viaggio di lavoro dall’Arabia Saudita il 4 maggio 2015, iniziò presto ad accusare evidenti difficoltà respiratorie. Prima che qualcuno collegasse i sintomi con la sua recente permanenza in Medio Oriente venne rimbalzato tra vari ospedali, infettando a sua volta altre persone. Il 20 maggio fu stabilita la diagnosi, ma ormai era troppo tardi, e il virus aveva già preso piede.”
Tornando all’attuale Covid-19: la sua identificazione con la Cina a suo parere ha portato un rallentamento nella diagnosi del virus in Italia?
“Lo stigma ha sicuramente favorito la diffusione del Covid-19 in Italia: associare in maniera così forte il virus alla Cina, al cibo cinese, o ai pacchi provenienti dalla Cina ha fatto si che venissero trascurate tantissime persone che presentavano già i sintomi, ancor prima del famoso paziente uno. Ricordiamo che in Italia il primo caso di Covid-19 è stato diagnosticato il 22 febbraio. Se fossero stati testati indipendentemente dai loro possibili contatti con l’Oriente, solo sulla base della loro sintomatologia, sarebbero stati riconosciuti prima. C’è da dire però che in quel periodo la stessa Oms suggeriva di sottoporre a tampone solo delle persone che, oltre ai sintomi, avessero avuto in qualche modo un legame con la Cina. Questo è sicuramente stato un errore di valutazione, senza il quale sarebbe stato possibile far partire prima le procedure di contact tracing per risalire dai casi sospetti a tutti i loro possibili contatti.
In questo modo il numero di contagi sarebbe attualmente molto più basso?
“È probabile. C’è però da sottolineare però che una malattia come il Covid-19, con un’alta contagiosità e dei sintomi che nella maggior parte delle persone sono lievi, è molto difficile da gestire e da contenere”.
Abbiamo parlato di nomi di malattie e di stigma. Mi viene in mente l’Aids…
“Nel caso dell’Aids, lo stigma sociale nei confronti delle persone omosessuali ha enormemente favorito l’espansione della malattia. Provocata dal virus dell’Hiv, il suo primo nome non era Aids (Acquired immune deficiency syndrome), bensì Grid (Gay related immune deficiency). Questo ha fatto sentire erroneamente tranquilli tutti gli eterosessuali, fino a quando si è capito che il contagio non dipendeva dalle scelte sessuali individuali. Ormai però il virus era già enormemente diffuso. Il pregiudizio nei confronti degli omosessuali ha prodotto più di un effetto disastroso. In primis, come già detto, ha fatto sì che gli eterosessuali non prestassero la dovuta attenzione verso la possibilità del contagio. In secondo luogo ha per anni reso impossibile diagnosticare la sindrome in tutti gli individui che ne erano affetti, focalizzando in maniera errata (o meglio, incompleta) l’attenzione dei medici. La terza, gravissima conseguenza ha a che fare con l’omofobia: negli anni ’80 un eterosessuale che sospettasse di essere ammalato di Aids avrebbe avuto molta paura di essere bollato come “frocio”, rimandando così i controlli”.
Il termine omofobia è stato coniato negli anni ’60 da George Weinberg, per indicare “la paura dell’omosessualità, sia come timore ossessivo di essere o di scoprirsi omosessuale, sia come atteggiamento di condanna dell’omosessualità” (Dizonario di Medicina, 2010). È chiaro che questo atteggiamento di paura ha favorito la diffusione di una malattia che poco aveva a che vedere con l’omosessualità. Per anni è stata definita come “il cancro dei gay” o ancora “la peste dei gay”. Per anni Gaetan Dugas, uno steward che lavorava per la compagnia aerea Air Canada è stato considerato il paziente zero americano, solamente perché si trattava del primo caso diagnosticato, e ovviamente perché omosessuale sessualmente attivo. Nel 2016 finalmente questo pesante fardello è stato cancellato dalla sua memoria: grazie a uno studio di Michael Worobey, pubblicato sulla rivista americana Nature, si è scoperto che in realtà il virus era da molti anni presente negli Stati Uniti.
Leggi anche: Cibo e benessere: vivere in casa ai tempi del Covid-19
Articolo pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()
Immagine: Pixabay