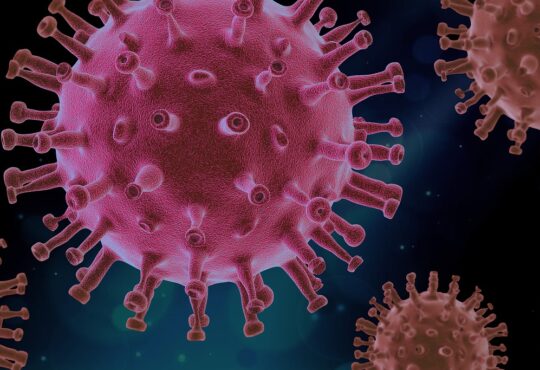Quanto sono davvero pericolose le nuove varianti del coronavirus?
Alcune mutazioni comparse in Gran Bretagna, Brasile e Sudafrica offrono un vantaggio evolutivo a SARS-CoV-2, diventato più contagioso e forse capace di aggirare le nostre difese immunitarie.

Tutti i virus accumulano mutazioni e SARS-CoV-2 non fa eccezione. Due mutazioni nucleotidiche al mese, stimano gli esperti, da quando il coronavirus della COVID-19 è comparso tra gli avventori del mercato di Wuhan. Niente di speciale per un virus a RNA, una famiglia di patogeni con la fama di avere un genoma alquanto mutevole. Tanto più che, come sempre accade, la gran parte di queste mutazioni causali lascia pressoché invariate le caratteristiche del virus: esercizi di stile dell’evoluzione che di per sé non dovrebbero sorprendere, se non fosse che di SARS-CoV-2 abbiamo imparato a diffidare.
Nonostante il suo genoma sia due volte più stabile dell’influenza e il quadruplo più dell’HIV, l’enorme diffusione di SARS-CoV-2 nella popolazione umana è un rischio aggiuntivo perché più un virus circola, più aumenta la probabilità che dalla lotteria delle mutazioni emerga qualche variante con un vantaggio evolutivo. E di solito, per un virus – che per sopravvivere deve riuscire a passare da un corpo all’altro prima che l’ospite muoia o che il sistema immunitario abbia la meglio – il più ambito dei vantaggi evolutivi è una maggiore contagiosità. È quel che è successo alle varianti scoperte nel Regno Unito, in Sudafrica e in Brasile: tutte e tre hanno accumulato un certo numero di mutazioni capaci di modificare le proteine virali (almeno una dozzina) e alcune di queste sembrano rendere SARS-CoV-2 più contagioso.
Per definizione, affinché emerga una nuova variante, un virus deve accumulare diverse mutazioni specifiche: non è un evento molto frequente, ma quando un patogeno è ubiquitario come SARS-CoV-2, anche gli eventi insoliti possono accadere molte volte. L’aspetto più interessante – e inquietante – è però un altro: almeno una delle mutazioni potenzialmente in grado di aumentare la trasmissibilità è stata trovata in più varianti del coronavirus ma è avvenuta in modo indipendente. «Si parla di omoplasia: la stessa modificazione genetica è comparsa più volte, in luoghi geograficamente molto distanti, senza che si possa risalire a un progenitore comune», spiega Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e tra i maggiori esperti italiani di analisi filogenetiche. «È un esempio di evoluzione convergente e un forte indizio che queste mutazioni offrono un vantaggio evolutivo alle nuove varianti del coronavirus, che diventando più contagiose possono diffondersi con più facilità fino a diventare dominanti».
La mutazione N501Y
Le mutazioni più temute sono quelle che influenzano l’ormai celebre proteina spike che forma la corona puntuta del virus consentendo a SARS-CoV-2 di legarsi alle nostre cellule e infettarle. La prima mutazione capace di aumentare la trasmissibilità, nota come D614G, era comparsa già a febbraio e ha facilitato la diffusione del coronavirus in tutto il mondo. Tra quelle scoperte più di recente, la più degna di nota è invece la mutazione N501Y, così chiamata perché riguarda il 501esimo amminoacido della proteina spike, che in origine era un’asparagina (N) e che la mutazione ha sostituito con una tirosina (Y). La mutazione N501Y è presente in tutte e tre le varianti più temute del coronavirus, identificate tra novembre e gennaio nel Regno Unito, in Sudafrica e in Brasile, e facilita l’abbraccio mortale della proteina spike con le nostre cellule.
La mutazione N501Y è stata individuata in numerose altre sequenze virali isolate in tutto il mondo ed è anche per questo che è così studiata. Sebbene si ritenga che conferisca un vantaggio evolutivo, in genere una singola mutazione non è sufficiente a modificare in modo radicale il comportamento di un agente patogeno. È dunque più probabile che l’aumento di contagiosità sia dovuto all’effetto combinato di più mutazioni. La variante scoperta nel Regno Unito, per esempio, ritenuta responsabile del picco di contagi registrato in dicembre a Londra e nel sudest dell’Inghilterra, oltre all’ormai famigerata mutazione N501Y vanta altre 16 mutazioni in grado di influenzare le proteine virali. Oggi questa variante è presente in oltre 50 nazioni, Italia inclusa. In Gran Bretagna, Irlanda e nei Paesi Bassi è già diventata dominante, mentre in Francia e negli Stati Uniti si teme che lo diventerà entro marzo.
La mutazione E484K
Le nuove varianti scoperte in Sudafrica e in Brasile, oltre alla N501Y, hanno anche altre due mutazioni in comune che interessano la proteina spike. La più importante è indicata con la sigla E484K perché la mutazione è avvenuta nel 484esimo amminoacido, che ha cambiato la sua carica elettrica da negativa a positiva. Con ogni probabilità anche questa mutazione influenza la forma della proteina spike e il modo in cui il coronavirus aggancia le cellule. È inoltre possibile che le mutazioni N501Y e E484K agiscano in sinergia, e magari anche insieme ad altre mutazioni, per rendere più solido il legame della proteina spike e aumentare la capacità d’infezione del virus. Sembra infine che la mutazione E484K sia comparsa di recente anche nella variante che circola in Gran Bretagna: se fosse confermato, sarebbe una pessima notizia.
Alcuni studi suggeriscono infatti che le varianti presenti in Sudafrica e Brasile con la mutazione E484K siano in grado di ridurre l’efficacia protettiva degli anticorpi sviluppati dalle persone guarite dalla COVID-19. Non si potrebbe così escludere il rischio di reinfezione, cioè la possibilità che le persone guarite possano ammalarsi una seconda volta qualora venissero in contatto con le nuove varianti. È quel che sembra essere già accaduto a Manaus, capitale dello stato brasiliano di Amazonas, ma su quest’ipotesi torneremo più avanti.
La variante “bresciana”
Il 10 novembre del 2020 un uomo di 59 anni che aveva contratto il coronavirus sette mesi prima senza mai riuscire a sconfiggere l’infezione ha fatto l’ennesimo test molecolare. Sebbene l’uomo fosse asintomatico, il tampone è risultato ancora una volta positivo. Arnaldo Caruso, professore di microbiologia dell’Università di Brescia, ha deciso di vederci chiaro e si è rivolto a Massimo Ciccozzi affinché facesse un’analisi filogenetica del genoma virale estratto dai tamponi eseguiti in agosto e novembre. I risultati hanno mostrato che, rispetto al ceppo di riferimento scoperto a Wuhan, la variante trovata nel corpo del paziente di Brescia (chiamata in modo improprio anche “variante bresciana”) aveva accumulato ben 13 mutazioni. Tre di queste si erano aggiunte tra agosto e novembre, compresa la mutazione N501T, che ancora una volta riguarda il 501esimo amminoacido della proteina spike, ma con la sostituzione dell’amminoacido asparagina (N) con la treonina (T).
La scoperta, pubblicata sulla rivista scientifica The Lancet, sembra confermare l’ipotesi che queste varianti possano essersi evolute in persone immunodepresse rimaste infette per un lungo periodo di tempo. Nel caso bresciano, il sistema immunitario del paziente era stato fortemente debilitato da una grave malattia. La debole risposta immunitaria non ha potuto debellare l’infezione, lasciando al coronavirus l’opportunità di accumulare mutazioni in un ambiente non troppo ostile. Casi simili sono rari, ma con oltre cento milioni di persone infettate nel mondo è senz’altro successo molte volte. Non è però chiaro se anche la variante scoperta a Brescia sia più contagiosa. «La stiamo ancora studiando e nelle prossime settimane pubblicheremo i primi risultati delle nostre ricerche», dice Ciccozzi.
Più contagiose e più letali?
Sul fatto che le nuove varianti isolate nel Regno Unito, in Sudafrica e Brasile siano più contagiose non sembrano invece esserci ormai molti dubbi. La loro rapidità di diffusione in questi Paesi ha fornito un primo indizio del vantaggio evolutivo conferito dalle mutazioni che rafforzano il legame tra la proteina spike e le nostre cellule. Già a dicembre un gruppo di epidemiologi britannici aveva stimato che la variante individuata nel Regno Unito potesse essere circa il 50% più trasmissibile, giustificando così il picco di infezioni e di ricoveri nel sudest dell’Inghilterra.
L’impennarsi della curva epidemica, tuttavia, può avvenire per diversi motivi e non basta a dimostrare che una variante è più contagiosa. Serviranno solide prove di laboratorio a conferma delle osservazioni epidemiologiche. Alcune ricerche sui criceti sembrano evidenziare una più elevata carica virale nelle vie aeree superiori dei roditori infettati con le nuove varianti in grado di giustificare la maggiore contagiosità. Qualcosa di simile è stato osservato anche tra gli esseri umani: alcuni studi preliminari condotti in Gran Bretagna e in Sudafrica suggeriscono che le persone contagiate con le nuove varianti abbiano una concentrazione più elevata di particelle virali nel naso e in gola, che possono essere più facilmente espulse respirando, parlando, tossendo o starnutendo.
Il 22 gennaio il governo britannico ha lanciato l’allarme anche rispetto alla possibilità che la nuova variante possa essere il 30% più letale, ammettendo però di non avere ancora prove abbastanza solide. «Non disponiamo di evidenze scientifiche sulla maggiore letalità della variante scoperta nel Regno Unito», taglia corto Ciccozzi. Purtroppo però basta il solo aumento della contagiosità per causare un maggior numero di infezioni e quindi anche di vittime.
Per difenderci, in attesa della copertura vaccinale, non resta che mantenere il rigore nelle misure di contenimento che abbiamo imparato a conoscere: indossare le mascherine, lavarsi spesso le mani, rispettare il distanziamento, evitare luoghi chiusi e affollati dove il rischio di focolai è maggiore. Oltre, naturalmente, a tracciare i contagi e isolare le persone infette. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), per ritardare la diffusione delle nuove varianti non c’è modo migliore che ostacolare la circolazione di SARS-CoV-2, poiché ogni persona infetta offre al coronavirus un’ulteriore occasione di mutare.
Il rischio di reinfezione
A Manaus, la capitale dello stato di Amazonas, nel nord del Brasile, si è verificata un’ondata di contagi che ha sorpreso anche gli esperti perché la città era stata già duramente colpita dalla pandemia: secondo uno studio pubblicato su Science, tre quarti degli abitanti avevano già contratto l’infezione e dunque avrebbe dovuto essere protetto dagli anticorpi. Anche se la diffusione del contagio potrebbe essere stata sovrastimata, si credeva che l’immunità di gregge non fosse comunque troppo lontana. Si è quindi diffuso il sospetto che la nuova variante trovata in Brasile sia in grado di rendere meno efficace l’azione immunizzante degli anticorpi sviluppati dalle persone guarite, esponendole al rischio di riammalarsi. Al momento è solo un’ipotesi, ma le evidenze si stanno accumulando, e nel dubbio diversi Paesi, compresa l’Italia, hanno introdotto restrizioni ai viaggi nel Paese sudamericano.
L’incertezza è dovuta al fatto che gli studi sono stati condotti su un numero ristretto di persone guarite dalla COVID-19 e hanno potuto esaminare soltanto il comportamento degli anticorpi neutralizzanti, mentre in realtà anche altre componenti del sistema immunitario, come per esempio le cellule T, capaci di eliminare le cellule infette, svolgono un ruolo importante. A livello molecolare, il principale indiziato resta comunque la mutazione E484K, presente anche nella variante che oggi circola in Sudafrica. È però improbabile che un singola mutazione, e neppure il numero relativamente ristretto di mutazioni che si sono accumulate in queste varianti, possano vanificare l’immunità acquisita dopo la guarigione. La risposta immunitaria coinvolge infatti molti anticorpi in grado di riconoscere diverse parti della proteina spike, perciò si ritiene che la protezione dalle nuove varianti possa essere al più ridotta, ma non annullata.
L’efficacia dei vaccini
Un discorso analogo vale anche per la protezione offerta dai vaccini. «Quelli di Pfizer-BioNTech e di Moderna stimolano una forte reazione immunitaria e raggiungono un’efficacia del 94-95% nel prevenire la malattia, perciò la vaccinazione dovrebbe garantire una protezione sufficiente anche se l’azione protettiva contro le nuove varianti fosse leggermente inferiore», afferma Ciccozzi.
Gli studi preliminari condotti dalle aziende produttrici sembrano confermare che l’immunità offerta dai vaccini non risulta compromessa, sebbene si osservi una riduzione dell’efficacia degli anticorpi neutralizzanti. Se è vero che la gran parte dei vaccini ha scelto come bersaglio la proteina spike del coronavirus che circolava a Wuhan, le mutazioni che coinvolgono questa molecola chiave sono ancora troppo poche, a detta degli esperti, per vanificare l’effetto della vaccinazione, che induce la produzione di una grande varietà di anticorpi in grado di riconoscere diverse porzioni della proteina virale.
Se invece dovessero accumularsi altre mutazioni in grado di eludere l’azione del sistema immunitario, sarà necessario aggiornare i vaccini per la COVID-19, come già avviene ogni anno per l’influenza stagionale. La buona notizia è che i vaccini a mRNA sviluppati da Pfizer-BioNTech e Moderna possono essere adattati alle varianti nell’arco di appena sei settimane, secondo quanto assicurano i produttori. «Si basano infatti sulla sintesi chimica dell’mRNA del coronavirus, perciò basterebbe sintetizzare l’mRNA con le mutazioni trovate nelle varianti», spiega Ciccozzi. Bisognerà però aggiungere il tempo necessario per la distribuzione e per l’approvazione da parte delle agenzie regolatorie. Sarebbe invece più complicato aggiornare i vaccini tradizionali o identificare nuovi anticorpi monoclonali, un processo che per essere completato richiederebbe almeno sei mesi. Di certo SARS-CoV-2 continuerà a evolversi e nei prossimi mesi potrebbero emergere altre pericolose varianti. L’unico modo per non farsi fregare da un virus che muta di continuo è marcarlo stretto.
Chi cerca trova
Se le varianti più recenti sono state scoperte nel Regno Unito, in Sudafrica e in Brasile, non è solo perché in questi Paesi il coronavirus ha circolato di più nella popolazione. SARS-CoV-2 si è diffuso molto anche negli Stati Uniti o in Italia, dove però non esiste un sistema di sorveglianza in grado di sequenziare in modo sistematico il genoma virale in cerca delle varianti. «La cosiddetta “variante inglese”, che potrebbe essere anche emersa altrove, è stata scoperta in Gran Bretagna perché qui è stato creato un apposito consorzio, finanziato con oltre 20 milioni di sterline, per analizzare circa il 10% dei tamponi positivi e mappare tutte le mutazioni del coronavirus», racconta Ciccozzi.
Dunque chi cerca trova. E poiché non si può escludere l’emergere di altre varianti capaci di eludere le nostre difese immunitarie o la protezione offerta dal vaccino, è diventato sempre più chiaro che occorre dotarsi di strutture in grado di tenere d’occhio le mutazioni di SARS-CoV-2. Una nuova circolare del Ministero della Salute ha stabilito che il contact tracing dovrà dare precedenza ai contagi delle nuove varianti, mentre l’isolamento delle persone positive al tampone non potrà più essere ridotto a dieci giorni. Infine, dopo settimane di tentennamenti, anche l’Italia ha finalmente deciso istituire un consorzio per la sorveglianza attiva delle mutazioni del coronavirus e dei loro potenziali effetti sui vaccini, che sarà coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Una buona notizia per la nostra sicurezza.
Leggi anche: Dall’algoritmo MIT i suggerimenti per restrizioni efficaci contro il COVID-19
Articolo pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()
Fotografia: Macau Photo Agency via Unsplash