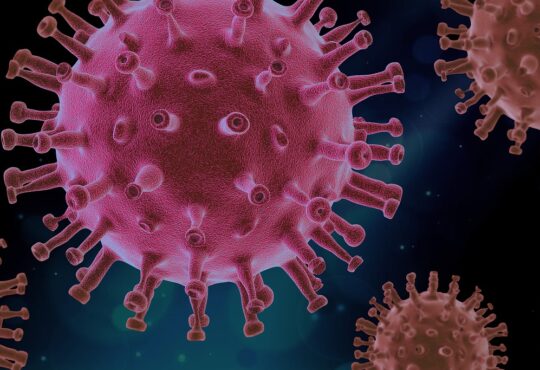In sala parto ai tempi del Covid-19
Papà ammessi solo in sala parto, travaglio e parto con la mascherina, solitudine totale durante la degenza. Per molte donne (anche Covid free) nelle ultime settimane le cose sono andate così.
Paolo è nato in un grande ospedale di Milano il 25 marzo scorso. All’accettazione il tampone di mamma Chiara si è rivelato negativo e papà Pietro è stato rassicurato sulla possibilità di entrare in sala parto. Alla fine è andato tutto bene, ma per Chiara e Pietro quel momento non è stato affatto come se l’erano immaginato. “Nelle settimane precedenti abbiamo vissuto nell’incertezza, non solo rispetto ai possibili effetti del virus sulla gravidanza se l’avessi preso, ma anche sul percorso nascita in sé” racconta la mamma.
“Il corso preparto in ospedale è stato interrotto il 20 febbraio e a lungo non abbiamo avuto notizie ufficiali. Se pensavo al parto, l’idea di doverlo affrontare da sola, con la mascherina e senza epidurale mi sembrava un incubo e lo stesso era per le mie compagne di corso”. Poi qualche certezza dal punto nascita è arrivata: sì alla possibilità di epidurale e sì al papà in sala parto (solo se senza sintomi e con mamma asintomatica e negativa al tampone), ma i disagi non sono mancati. “Il travaglio l’ho fatto da sola: otto ore in una stanza con una ragazza sconosciuta nelle mie stesse condizioni. L’ostetrica del reparto è stata presente e incoraggiante, ma sono certa che avere accanto il mio compagno sarebbe stata tutta un’altra cosa. Quando finalmente è arrivato il momento di andare in sala parto anche per lui è stato un trauma rivedermi: non gli sembravo più io”.
Dopo la nascita di Paolo le cose sono andate di fretta: pochi minuti di pelle a pelle – nonostante sia una pratica raccomandata addirittura in caso di donna con Covid-19 dall’Istituto Superiore di Sanità (in base a indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) – poi il neonato è stato portato via e il papà ha dovuto andarsene.
“Non abbiamo avuto il tempo di assaporare insieme le emozioni legate all’arrivo del bambino”, racconta Chiara con un po’ di rammarico, legato anche alla grande solitudine vissuta nei giorni successivi. “Non avevo mai preso in braccio un neonato: non sapevo come tenerlo, mettergli il pannolino, lavarlo, vestirlo”. Ci fosse stato Pietro avrebbero imparato insieme a farlo, ma lui non c’era e il sostegno del personale è stato limitato. “Non metto in discussione gli operatori, che hanno sempre cercato di fare il possibile, ma le puerpuere erano più numerose del solito e il tempo da dedicare a ciascuna piuttosto scarso”.
Allo stesso modo, durante l’intervista Chiara ripete più volte di non voler mettere in discussione neppure l’ospedale. “Anche io sono un medico ospedaliero e posso immaginare quanto sia stato complesso riorganizzare al volo un percorso nascita per garantire la sicurezza di tutti: partorienti, neonati e operatori. In effetti dal punto di vista infettivo ci siamo sempre sentiti protetti, ma non posso fare a meno di chiedermi se davvero far partecipare il papà al travaglio o ammetterlo in reparto per un paio d’ore al giorno avrebbe aumentato di molto il rischio di contagi. E a fronte di questo dubbio, ho la certezza di essere stata privata di esperienze che non potremo più rivivere e di aver sofferto difficoltà, per esempio nell’avvio dell’allattamento, che forse avrebbero potuto essere alleviate almeno dal punto di vista emotivo”.
Non solo: “Per tutta la gravidanza – aggiunge Chiara – le donne e i loro partner leggono e si sentono ripetere quanto siano importanti i primi tempi con il bambino. Oggi per ogni insicurezza nel mio rapporto con Paolo mi chiedo se non dipenda da come abbiamo vissuto i primi giorni insieme”.
Anche Elia è nato nello stesso ospedale qualche settimana dopo, a metà aprile, e fino al parto il percorso di mamma Nadia è stato analogo a quello di Chiara, con la differenza di essere stata un po’ più a lungo con il neonato e il compagno dopo la nascita. Nel suo caso i problemi sono arrivati poco dopo la sistemazione in camera. “Ho cominciato ad avvertire un dolore fortissimo, come se avessi ancora le contrazioni finali del parto. Si era formato un ematoma ed è stato necessario un intervento chirurgico. Nessuno aveva avvertito mio marito e quando me ne sono accorta l’ho fatto io, mentre con l’infermiera aspettavamo l’ascensore per scendere in sala operatoria”.
In quel momento i pensieri di Nadia non erano certo rosei: aveva appena partorito, era sola, temeva di non rivedere più Elia e il marito. Ma anche lui non ha passato ore tranquille: “Non ho più saputo nulla per ore” racconta. “Neppure in questa situazione mi è stato permesso raggiungerla”. Anche in questo caso alla fine è andato tutto bene, ma quella lontananza è costata un grosso carico di preoccupazione in più e di certo non è stato facile per Nadia prendersi cura da sola di Elia dopo l’intervento, tra flebo e cateteri.
Proprio come non lo è stato per Alessandra in un altro grande ospedale lombardo. Anche per lei tampone negativo e comunicazione che il papà sarebbe stato ammesso solo in sala parto. “Via via che il travaglio procedeva il mio unico obiettivo era rivederlo, mentre il personale mi invitava a non lamentarmi della sua assenza perché tanto era così per tutte” ricorda. Quando Carolina nasce il papà è presente, ma non c’è tempo per coccole ed emozioni: Alessandra ha un’emorragia e va portata subito in sala operatoria. “Sono molto riconoscente per tutto quello che è stato fatto, so che non era una situazione semplice, ma non posso negare che i giorni successivi all’intervento sono stati terribili. Sono stata per più di 24 ore in osservazione in una stanza del pronto soccorso ostetrico, quasi senza mangiare né bere, senza vestiti puliti, su un letto sporco di sangue, sempre con la stessa mascherina che avevo indossato all’ingresso in ospedale, tenuto per tutto il travaglio e il parto e che avrei tenuto fino all’uscita, piena di flebo e cateteri, cercando di occuparmi praticamente da sola della mia bambina”.
Con l’arrivo in reparto le cose sono andate un po’ meglio: “Ho potuto sistemarmi, ma mi sono sentita in prigione. Non si poteva uscire, neppure per andare a prendere una bottiglietta d’acqua al distributore: dovevamo farci bastare quella portata ai pasti (un litro per tutto il giorno) o chiedere a un familiare di portarla e lasciarla al personale. Ma io abito distante dall’ospedale, mi sembrava assurdo far fare a mio marito tutti quei chilometri per l’acqua”.
Solitudine e mancanza di sostegno
Cronache di nascite da mamme senza coronavirus durante i giorni più caldi dell’emergenza coronavirus: nessuna di queste e di altre mamme che hanno raccontato la loro esperienza a OggiScienza se la prende con gli operatori sanitari o gli ospedali. Tutte riconoscono il grande impegno degli operatori spesso in numero insufficiente a far fronte alla situazione, l’attenzione e la vicinanza che molti hanno sempre cercato di offrire, lo sforzo delle strutture per garantire sicurezza. Allo stesso tempo, però, denunciano la sofferenza di un parto e un post parto vissuti in piena solitudine e la mancanza di sostegni pratici nei loro primi momenti da mamma: le prime poppate – che per molte donne sono tutt’altro che facili, anche quando c’è forte motivazione ad allattare – le prime interazioni con il neonato.
Prima del Covid-19 oltre ad avere accanto il papà, i nonni, qualche amica, si poteva contare sul confronto con le altre puerpuere e con gli operatori che spiegavano come cambiare il pannolino, lavare un sederino, fare il bagno al bebè o medicare il moncone del cordone ombelicale. Dopo per molte donne tutto questo è mancato, soprattutto nelle regioni più colpite dalla diffusione del virus. Ed è mancata anche la possibilità di parlarne apertamente: c’è quasi un senso di colpa a farlo, come se durante l’emergenza coronavirus richiamare l’attenzione sui bisogni della nascita sia in fondo qualcosa di futile. “Si è parlato molto e giustamente della disumanizzazione della morte durante questa pandemia, ma anche la disumanizzazione della nascita è una ferita che può far male ai genitori, ai nonni e chissà, forse anche ai bambini”, dice Chiara.
“Sì, la solitudine delle donne è un problema importante in questo periodo: stanno sicuramente subendo un grande disagio, ma anche la paura di poter contrarre il virus è grande, per cui molte tutto sommato si sono adattate alla situazione, almeno nel mio reparto” afferma Anna Locatelli, responsabile del dipartimento materno-infantile dell’Asst di Vimercate – dove i papà sono ammessi in travaglio e parto, ma non in stanza – e segretaria scientifica della Società italiana di medicina perinatale. Locatelli invita anche a vedere le cose da una prospettiva più ampia, che tenga conto di qualcosa che è rimasto inviolato nel corso dell’emergenza e cioè la grande forza delle donne, che hanno comunque continuato a partorire trovando punti di forza inaspettati.
“Mi ha molto colpita una paziente che temeva tantissimo la solitudine per via di una precedente depressione post parto e che invece al suo ritorno a casa mi ha mandato un whatsapp pieno di energia, in cui dichiarava che lo scenario vissuto le aveva dato l’opportunità di prendere consapevolezza di sé e di sentirsi più forte e serena”.
Mascherine e assenza dei papà sono davvero utili?
Resta il fatto che anche tra gli operatori c’è chi si chiede se, in fondo, misure come l’allontanamento dei papà o l’obbligo della mascherina durante travaglio e parto fossero e siano davvero necessarie. Laura Castellarin è ostetrica dell’Ospedale Castelli di Verbania, dove si partorisce senza mascherine e il papà è ammesso a travaglio e parto e può far visita a mamma e bambino, anche se per poche ore al giorno. “Mi riesce difficile capire perché, passati i primissimi giorni di emergenza, debba ancora essere così radicalmente stravolto il percorso assistenziale per donne che stanno bene. Certo, servono tutte le precauzioni del caso per proteggere operatori e pazienti, ma perché mai il partner di una donna in buona salute non dovrebbe assisterla o andarla a trovare un paio di ore al giorno dopo il parto?”.
Dello stesso avviso anche il pediatra Alessandro Volta, direttore del programma materno-infantile dell’ASL di Reggio Emilia e membro del comitato tecnico nazionale del progetto europeo PARENT, che punta alla prevenzione della violenza verso le donne attraverso la promozione delle cure paterne nel periodo dalla gravidanza ai primi anni del bambino. “È stato fatto molto, bene e tempestivamente, anche in termini di protocolli istituzionali, per le donne con Covid-19, ma si sono un po’ perse di vista le altre. Certo, le difficoltà oggettive non sono mancate, a partire dal fatto che nelle regioni più colpite sono stati chiusi molti punti nascita per creare percorsi dedicati ai pazienti positivi, per cui i parti si sono concentrati negli ospedali più grandi, senza un adeguato aumento del personale. Tutto questo ha inevitabilmente intaccato la dimensione ‘umana’ della nascita in ospedale”.
E come spesso accade c’è stata una grande frammentazione delle indicazioni, per cui punti nascita anche vicini sul territorio hanno fatto scelte molto differenti per esempio in fatto di assistenza da parte del papà. “Tutto questo è sconcertante per i genitori, che non ne capiscono le ragioni e anche io mi chiedo se davvero, in caso di buona salute, la presenza del papà non possa essere garantita ovunque e per tutto il travaglio e se non sia possibile prevedere brevi visite dopo il parto”.
A preoccupare Volta, tuttavia, è soprattutto un altro aspetto e cioè la quasi totale assenza dei padri dalle linee guida e indicazioni ufficiali sulla gestione della gravidanza in questa emergenza. “Sono pochissime quelle che vi fanno riferimento, spesso in modo superficiale, ma questo significa che siamo ancora molto lontani da un’ottica di vera co-genitorialità e fermi alla visione della genitorialità come qualcosa di esclusivamente femminile, da mamma fattrice. Il papà viene considerato al massimo un accompagnatore, un visitatore, non una parte attiva della coppia”.
E se questa è la visione generale della “questione papà”, il rischio è che passata l’emergenza si possano fare passi indietro sulle timide conquiste fatte in Italia a questo proposito. E attenzione: la posta in gioco è ben più alta che far entrare il papà in sala parto perché possa girare un video o tagliare il cordone ombelicale. Coinvolgere il papà durante gravidanza, parto, primi anni di vita del bambino, fargli vivere una diversa paternità fin dal concepimento è un modo per costruire relazioni familiari differenti, più eque.
Parto a casa e supporto territoriale
Anche se, come dice Locatelli, molte donne e famiglie si sono adattate alla nuova situazione, le storie che abbiamo raccolto raccontano che la paura di contagiarsi, di vivere il parto e il post parto da sole, di dover subire fatiche e dolore in più (la mascherina obbligatoria, la mancanza di garanzie sull’epidurale) ci sono state eccome e sono forse alla base di un possibile aumento dei travagli e dei parti in casa nelle ultime settimane. Mancano ancora dati precisi sul fenomeno, ma la percezione degli operatori è che siano aumentati, come confermano anche Volta per l’Emilia Romagna e, più in generale, Lisa Forasacco, ostetrica e presidentessa dell’associazione Nascere a casa.
“In queste settimane – ci ha scritto in un’email – sono sicuramente aumentati l’interesse per la ricerca di luoghi diversi dall’ospedale in cui partorire”. Sottolineando che nonostante l’incremento della richiesta le ostetriche dell’associazione cercano sempre di parlare con la donna delle motivazioni più profonde che le spingono, “perché un parto in casa non si improvvisa”. Un altro fenomeno che sembra essere cresciuto nell’ultimo periodo (ma anche qui mancano dati definitivi) riguarda la richiesta di dimissioni precoci o precocissime. “Ci sono mamme che firmano per andare a casa 12 o 24 ore dopo il parto, ma anche 3 ore dopo: troppo poco per garantire che ci sia stato un buon adattamento del bambino. Si rischia di non vedere casi di ittero neonatale e ipoglicemia e di dover poi intervenire in emergenza” spiega Volta. “Per questo in Emilia Romagna chiediamo di rimanere almeno 24 ore e abbiamo attivato ambulatori territoriali extra per le dimissioni precoci”.
“Territoriale” è una parola molto importante per il percorso nascita, ma troppo spesso trascurata perché negli ultimi decenni tutto è diventato molto centrato sugli ospedali. Prendiamo proprio la questione delle dimissioni: “A meno di complicazioni e situazioni specifiche, non ci sono giustificazioni concrete per tenere una puerpuera in ospedale per tre giorni, se non il fatto che manca una rete di assistenza territoriale (in altre parole i consultori) adeguata. Se ci fosse, la neomamma potrebbe tornare a casa con il suo bambino già 12 ore dopo il parto” dichiara Locatelli. Che l’emergenza coronavirus possa dunque aiutare a illuminare meglio i punti critici dell’assistenza alla nascita nel nostro paese (per molti versi per altro eccellente, come testimoniano i bassissimi tassi di mortalità materna e perinatale)?
“È quasi filosofico, pensare che per anni abbiamo considerato l’ospedale come il luogo più sicuro in assoluto, anche rispetto alla nascita, mentre ora si è capito che la sicurezza non passa necessariamente da lì e che le cose si possono fare bene anche in altra sede” afferma Locatelli (attenzione: il riferimento non è al parto in casa, ma appunto ai servizi territoriali NdR). Secondo Giovanni Fattorini, dell’Associazione ginecologi territoriali italiani, questa potrebbe essere proprio una delle “lezioni” da imparare dal coronavirus: “Capire che, soprattutto in Lombardia, il modello ospedaliero ha mostrato i suoi limiti e approfittarne per spostare di più l’assistenza alla gravidanza e al post parto fisiologici sul territorio”.
E, aggiungiamo, sulla competenza della figura professionale prevista proprio per l’assistenza alla gravidanza fisiologica (o a basso rischio, come si preferisce dire oggi) che è quella dell’ostetrica. D’altra parte lo stesso Fattorini non è affatto sicuro che questo ripensamento ci sarà davvero. “Credo che nei prossimi anni arriveranno nuove risorse per la sanità, ma credo anche che saranno dedicate soprattutto a settori come la rianimazione, l’emergenza, l’infettivologia e che in questo nostro paese sempre più vecchio salute sessuale e riproduttiva non riceveranno grandi benefici”.
Al di là di eventuali ragionamenti a lungo termine sulla ristrutturazione dei servizi, l’auspicio di chi scrive è che questa situazione eccezionale diventi occasione per dare ancora più voce alle madri e ai loro bisogni. L’emergenza è arrivata in modo veloce, forse inatteso (nonostante si parli da tempo della possibilità di pandemie da nuovi agenti infettivi) ed è più che comprensibile che all’inizio ci sia stato un ripensamento dei servizi in senso protettivo, sia per i pazienti sia per gli operatori.
La prospettiva di dover convivere a lungo con il Sars-Cov-2 però è concreta: ora più che mai è importante lavorare per trovare il modo di conciliare, basandosi sulle conoscenze scientifiche disponibili, la protezione dal virus con la difesa delle conquiste fatte nel percorso nascita negli ultimi anni, in tema di autodeterminazione nel parto, di coinvolgimento paterno o di promozione e assistenza dell’allattamento al seno. Combattendo anche quella solitudine post parto già tanto diffusa nella nostra società e che ora rischia di ingigantirsi ancora di più.
NB I nomi delle mamme, dei papà e dei bambini riportati in questo articolo sono di fantasia
Leggi anche: Coronavirus e gravidanza: come convivere con l’ansia
Articolo pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()
Immagine: Pixabay