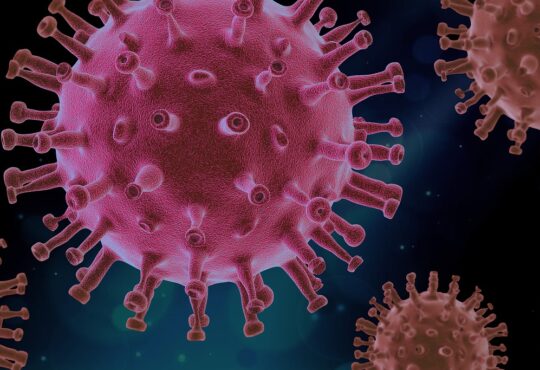Come si trasmette davvero il coronavirus della Covid-19
Le ultime ricerche indicano che gli eventi di superdiffusione hanno un ruolo cruciale nella pandemia, suggerendo quali luoghi e comportamenti dobbiamo evitare per difenderci dal contagio
Abbiamo imparato nostro malgrado a temere la contagiosità del coronavirus SARS-CoV-2, che secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) potrebbe avere già infettato un decimo della popolazione umana. Eppure, per quanto possa destare stupore di fronte al dilagare della pandemia, la gran parte delle persone positive al tampone non infetta nessuno. È la conclusione del più ampio studio di tracciamento epidemiologico condotto finora sulla COVID-19, appena pubblicato dalla rivista Science.
La ricerca, che si è svolta negli stati indiani di Andhra Pradesh e Tamil Nadu, dove i sistemi sanitari dispongono di efficaci sistemi di sorveglianza sviluppati durante l’epidemia di AIDS, ha analizzato oltre mezzo milione di persone sottoposte a tampone. I risultati confermano un sospetto che nelle ultime settimane si è molto rafforzato: SARS-CoV-2 non si diffonde nella popolazione in modo uniforme ma a grappoli (o cluster, nel gergo degli epidemiologi). Nello studio di Science, infatti, mentre il 70% delle persone risultate positive non ha contagiato nessun altro, il 60% di tutti i contagi è riconducibile ad appena l’8% degli infetti.
Un’altra ricerca condotta a Hong Kong e pubblicata sulla rivista Nature Medicine arriva a conclusioni molto simili: meno del 20% delle persone infette ha causato l’80% dei contagi, mentre quasi il 70% dei positivi al tampone non ha infettato altre persone. Confrontando i risultati dei diversi studi disponibili, oggi si stima che il 10-20% delle persone positive sia responsabile di almeno l’80% dei contagi.
L’epidemia di COVID-19 sembra dunque avanzare sotto la spinta di singoli eventi di superdiffusione in cui una persona positiva viene a trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, finendo per contagiarne molte altre. Il caso più famoso è avvenuto in febbraio a Daegu, in Corea del Sud, quando una donna di 61 anni, indicata come Paziente 31, ha infettato una cinquantina di fedeli appartenenti alla sua stessa chiesa, dando origine a un cluster di oltre 5.000 contagi.
Un episodio più circoscritto ma dalle conseguenze ancora più rilevanti si è verificato il 26 settembre alla Casa Bianca, durante a cerimonia con cui il presidente Donald Trump ha annunciato la nomina di Amy Coney Barrett a giudice della Corte Suprema; sebbene l’evento si sia svolto all’aperto, pochi invitati indossavano la mascherina e hanno rispettato il distanziamento sociale, cosicché alla fine si sono contati 13 contagi, tra cui il presidente, la first lady e due senatori.
Nel posto sbagliato al momento sbagliato
Nella gran parte dei casi, il momento sbagliato è uno o due giorni prima che si manifestino i sintomi, quando la carica virale è già molto elevata ma la persona infetta, che ancora non avverte malesseri e non sa di avere contratto la COVID-19, continua fare la vita di sempre, rischiando di finire nel posto sbagliato. Il posto sbagliato è quasi sempre uno spazio chiuso, molto affollato e con scarsa ventilazione. Peggio ancora se i presenti non indossano la mascherina, parlano ad alta voce, cantano o fanno attività fisica.
All’inizio i ricercatori hanno cercato di tracciare un identikit del superdiffusore (o superspreader, in inglese) e identificare quali caratteristiche potessero favorire la trasmissione del coronavirus a decine di altre persone. Si è parlato di predisposizione genetica, di pazienti con una carica virale elevata o con una spiccata capacità di spargere droplet parlando a voce alta o in preda a un attacco di tosse. La biologia, tuttavia, sembra giocare un ruolo minore rispetto al contesto ambientale. In altre parole, più che di superuntori, è più appropriato parlare di ambienti e comportamenti a rischio che possono favorire la superdiffusione.
La maggior parte di questi eventi si è verificata in ospedali, residenze per anziani, mezzi di trasporto, bar e ristoranti, palestre, impianti di lavorazione della carne, riunioni di lavoro, luoghi di culto, call center, prigioni, navi da crociera e durante eventi come matrimoni, funerali o feste private. Secondo un’indagine condotta negli Stati Uniti, le scuole sembrano invece essere meno a rischio di quanto si potesse temere; tuttavia, poiché in gran parte del mondo sono state riaperte da poche settimane, è ancora presto per trarre conclusioni.
Il fattore k
Nelle prime fasi dell’epidemia, la comunità scientifica si è interrogata a lungo sulla contagiosità del nuovo coronavirus. Per stimare quanto un patogeno si trasmetta facilmente da persona a persona si ricorre al parametro R0, che rappresenta il numero medio di persone infettate da un singolo individuo se non viene presa alcuna precauzione. R0 è perciò una caratteristica intrinseca del patogeno e si stima che per il coronavirus SARS-CoV-2 sia circa 2,5. Nel mondo reale, tuttavia, le persone imparano a proteggersi e la contagiosità effettiva tende a diminuire. Gli epidemiologi impiegano perciò un secondo parametro, Rt, cioè il tasso di contagiosità che si rileva quando vengono introdotte le misure per contenere il diffondersi della malattia.
C’è tuttavia un terzo parametro, meno noto alle cronache ma cruciale per comprendere l’evoluzione della pandemia di COVID-19. Si chiama fattore di dispersione e viene indicato con la lettera k. Più k è grande, più il contagio si trasmette in modo uniforme nella popolazione, come avviene per l’influenza stagionale. La COVID-19, al contrario, così come la SARS, sembra invece caratterizzata da un basso fattore di dispersione, indice che il contagio si diffonde a partire da pochi individui che infettano gruppi numerosi di persone, dando origine a un cluster.
Se è così, c’è una buona e una cattiva notizia. La cattiva notizia è che risulta più difficile prevedere l’evoluzione dell’epidemia perché la casualità gioca un ruolo importante. Anziché seguire un andamento graduale e deterministico, come avviene per l’influenza, la COVID-19 ha un andamento stocastico, cosicché quel che è successo ieri non offre indicazioni attendibili per sapere cosa ci attende domani. Pochi eventi di superdiffusione possono amplificare i contagi e fare impennare la curva epidemica: in breve tempo si può passare da una fase di relativa calma a un’esplosione di casi impossibile da arginare in assenza di un vaccino o di restrizioni drastiche. Forse è quel che è accaduto in Italia lo scorso 19 febbraio, quando allo stadio San Siro di Milano si è svolto l’incontro di Champions League tra l’Atalanta e il Valencia, un evento ricondotto a circa settemila contagi che potrebbe avere dato la spinta decisiva alla prima ondata epidemica.
La buona notizia è che il ruolo preminente della superdiffusione può indicarci quali luoghi evitare e quali contromisure adottare per difenderci dal contagio. Locali rumorosi e affollati, dove le persone abbassano la mascherina per bere, magiare o conversare, e dove per parlarsi si è costretti ad alzare la voce o a sporgersi verso l’interlocutore, sono in cima alla lista dei luoghi a rischio. Più in generale, ovunque si accalchino molte persone, risulta più difficile mantenere il distanziamento e crescono le probabilità che tra i presenti ci sia qualcuno infetto. Il rischio aumenta ulteriormente se lo spazio è al chiuso e poco ventilato; al contrario, decresce se è presente un sistema di ricambio dell’aria, se si indossa la mascherina, se si riduce il rumore.
Anche un’intensa attività fisica al chiuso può essere pericolosa perché si respira più forte, emettendo e inspirando una maggiore quantità di goccioline potenzialmente infette. In Corea del Sud, le lezioni di fitness svolte nelle palestre di Cheonan hanno innescato una catena di contagi, a differenza delle lezioni di yoga tenute nelle medesime strutture. Infine, più a lungo si resta in un luogo a rischio, più aumentano le probabilità di essere contagiati. I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statunitensi stimano in almeno 15 minuti il tempo necessario affinché possa verificarsi la trasmissione virale.
Ripensare le contromisure
Intervistato da The Atlantic, l’epidemiologo Samuel Scarpino della Northeastern University (Stati Uniti) ha spiegato che le autorità sanitarie occidentali, abituate a usare l’influenza stagionale come modello per la gestione delle epidemie, hanno sottovalutato l’elevata capacità del coronavirus di diffondersi in cluster, a differenza di quanto è avvenuto in Asia sulla scorta dell’esperienza maturata con la SARS. Forse abbiamo discusso troppo di R0 e di Rt, ma non abbastanza del fattore di dispersione k, più utile per comprendere le dinamiche della pandemia di COVID-19 e per indirizzare le restrizioni per limitare le circostanze che favoriscono la superdiffusione.
Secondo l’inchiesta dell’Atlantic, riconoscere l’importanza della diffusione a cluster dovrebbe mettere in discussione anche le modalità con cui viene effettuato il contact tracing. Anziché tracciare le persone con cui un paziente è venuto a contatto dopo avere contratto l’infezione – come avviene oggi in gran parte del mondo, Italia compresa – potrebbe essere molto più efficace procedere a ritroso, identificando la persona da cui è partito il contagio, che ha maggiori probabilità di avere infettato anche altre persone. A breve, un aiuto dovrebbe arrivare dai tamponi antigenici che, seppure meno sensibili di quelli molecolari, sono molto più rapidi ed economici, consentendo indagini su larga scala.
Il tracciamento retrospettivo impiegato in Corea del Sud e in Giappone sembra avere contribuito a controllare la diffusione dell’epidemia. Quando nei mesi scorsi sono emersi diversi cluster legati ai locali notturni di Seul, le autorità hanno tracciato decine di migliaia di persone che avevano frequentato i luoghi dove si era verificata la superdiffusione, al di là che avessero avuto o meno contatti con le persone risultate positive al tampone, riuscendo così ad avere la meglio sui focolai.
In Giappone le autorità sanitarie raccomandano la regola delle tre C: evitare gli spazi chiusi con scarsa ventilazione (closed spaces), i luoghi affollati (crowded spaces) e i contatti stretti (close-contact). E quando non è possibile, come in metropolitana, indossare sempre la mascherina e non parlare. Persino negli stadi ai tifosi è vietato incitare la propria squadra del cuore. I parchi pubblici sono rimasti aperti, ma non si può né urlare né cantare. In sostanza, le regole adottate sono meno restrittive ma mirate a evitare gli eventi di superdiffusione, prendendo inoltre in considerazione qualsiasi modalità di trasmissione per via aerea: non solo starnuti e colpi di tosse, ma anche l’aerosol che emettiamo respirando e parlando.
I rischi dell’aerosol
Per non soccombere un virus ha un’unica possibilità: passare da un corpo all’altro prima che le difese immunitarie abbiano il sopravvento o che l’organismo ospite muoia. Da quando circola negli esseri umani, SARS-CoV-2 ha escogitato (in termini evolutivi) diversi stratagemmi per farlo. Si serve soprattutto degli ormai famigerati droplets, le goccioline di muco e saliva che espelliamo con starnuti e colpi di tosse, oppure cantando e parlando ad alta voce. Ma la trasmissione virale può avvenire anche per contatto diretto e prolungato con una persona infetta, come accade negli ospedali e in famiglia, o per contatto indiretto con una superficie contaminata.
Da tempo gli esperti dibattono sull’ipotesi che SARS-CoV-2 possa trasmettersi anche sfruttando l’aerosol che emettiamo respirando e parlando normalmente. Più piccole e leggere, le goccioline di aerosol possono fluttuare a lungo nelle correnti d’aria, soprattutto se l’ambiente è chiuso e non ventilato. A luglio 239 scienziati avevano scritto una lettera aperta all’OMS esprimendo preoccupazione per la trasmissione mediante aerosol, che se riconosciuta imporrebbe di rivedere le disposizioni di sicurezza negli spazi chiusi, dotandoli di sistemi di filtraggio dell’aria o aprendo le finestre almeno ogni ora.
La trasmissione con l’aerosol potrebbe spiegare diversi episodi di superdiffusione in ristoranti, mezzi di trasporto e open space aziendali dove il contagio è avvenuto anche tra persone che si trovavano a più di due metri di distanza (quella che di norma coprono i droplets prima di ricadere al suolo). Le evidenze si sono moltiplicate, ma la pistola fumante ancora non è stata trovata. Raccogliere le minuscole goccioline di aerosol senza distruggere il coronavirus si è rivelato finora un’impresa piuttosto ardua e non è chiaro se SARS-CoV-2 mantenga la capacità infettiva anche in queste minuscole goccioline.
Dopo aver tentennato a lungo, nei giorni scorsi i CDC statunitensi hanno riconosciuto anche questa modalità di trasmissione, mentre per l’OMS le prove sono ancora insufficienti. Un atteggiamento conservativo che rischia di ritardare l’introduzione di misure precauzionali negli ambienti chiusi dove è più facile che si possa verificare la superdiffusione. Nel dubbio, come sempre, meglio sbilanciarsi dalla parte della prudenza.
Leggi anche: Breve guida ai tamponi per la Covid-19
Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()
Immagine: Pixabay