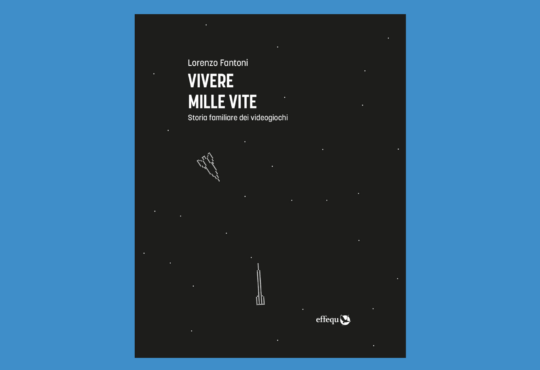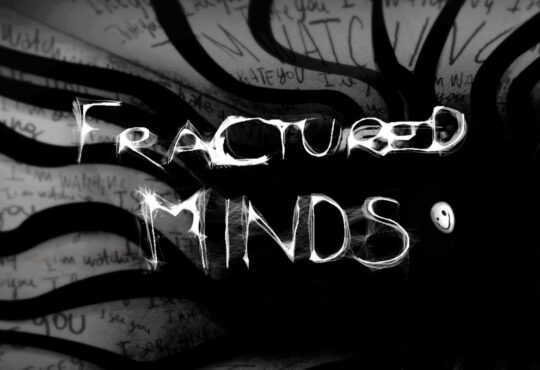SALUTE – Sarà capitato a molti, guardando sconsolati un figlio, un amico o un compagno incollato a un videogioco, di domandarsi “Ma non ha niente di più intelligente da fare piuttosto che sparare a orde di zombie?”.
SALUTE – Sarà capitato a molti, guardando sconsolati un figlio, un amico o un compagno incollato a un videogioco, di domandarsi “Ma non ha niente di più intelligente da fare piuttosto che sparare a orde di zombie?”.
Quanti però farebbero la stessa domanda se li trovassero sprofondati in un tomo di Tolstoj o impegnati in un allenamento per una maratona?
Se lo chiede Daphne Bavelier, professoressa di neuroscienze cognitive all’Università di Ginevra e all’Università di Rochester, nello stato di New York. Il suo gruppo di ricerca studia alcuni aspetti della plasticità cerebrale, cioè del modo in cui il cervello si modifica in risposta all’esperienza.
Si conoscono da decenni le alterazioni che alcune attività inducono sulla struttura e sul funzionamento cerebrale. Leggere, imparare una lingua, praticare uno sport, anche guidare un taxi per le vie di Londra: numerose ricerche hanno osservato che la struttura e l’attività del nostro cervello sono influenzate dalle diverse esperienze con cui lo nutriamo. Alcuni laboratori di neuroscienze, tra cui quello di Daphne Bavelier, si sono dedicati a studiare un tipo di esperienza che occupa oggi una larga parte del tempo di adulti e bambini: giocare ai videogiochi.
“Nel mese che ha seguito il suo lancio,” scrive la ricercatrice in un commento pubblicato su Nature, “il videogioco Call of Duty: Back Ops è stato giocato in tutto il mondo per un tempo equivalente a 68.000 anni.” Certo un’assiduità che poche altre occupazioni possono vantare. Con quali conseguenze sui giocatori?
Così come altre attività praticate intensamente per lungo tempo, anche i videogiochi sono in grado di modificare le capacità cognitive, e la ricercatrice ricorda che diversi studi hanno mostrato, contro le aspettative di genitori apprensivi, che ripetute sessioni di gioco possono avere sul nostro cervello effetti più positivi che negativi.
Il dibattito sulla possibile pericolosità dei videogiochi per gli utenti più fedeli non è certo nuovo nel mondo della ricerca e in quello della politica. Non mancano gli studi che hanno suggerito un legame tra l’uso intensivo di videogiochi e alcuni effetti negativi, chiamati in causa ciclicamente da sostenitori di crociate per la censura. Secondo alcuni, i giocatori più assidui si ridurrebbero a individui asociali, con propensione alla violenza e tendenza all’obesità, se non veri e propri drogati da gioco. Ma è poi vero che giocare troppo crea dipendenza? Se ne è parlato a lungo. Nel 2007 l’American Psychiatric Association ha valutato la possibilità di inserire la dipendenza da videogiochi nel DSM-5, la versione aggiornata del manuale diagnostico per i disturbi mentali, la cui uscita è prevista a breve, concludendo che non esistevano sufficienti dati scientifici per dichiararla un vero problema psichiatrico.
Accanto alle posizioni più allarmiste, è però emerso negli ultimi anni un filone di ricerche che ha suggerito che i videogiochi sono sì in grado di modificare comportamenti e capacità cognitive, ma per lo più in meglio. Un allenamento intensivo ai video game sembrerebbe migliorare alcune capacità di visione e di attenzione dei giocatori, che mostrerebbero, secondo alcuni studi, anche vantaggi nella memoria a breve termine e nella capacità di prendere decisioni in modo rapido e preciso. Anche la creatività sembra essere favorita nei giocatori più accaniti: una ricerca condotta su circa 500 bambini americani ha osservato che l’uso intensivo di videogiochi tendeva a essere associato a un punteggio più alto in una serie di test che misuravano la creatività.
I risultati incoraggianti di diverse ricerche non bastano però a sradicare la diffusa opinione che i videogiochi siano, in fondo in fondo, un passatempo negativo soprattutto per gli utenti più giovani. Secondo un’analisi condotta nel novembre 2012 da Ipsos MediaCT in collaborazione con l’Interactive Software Federation of Europe, i genitori italiani si rivelano i più pessimisti in Europa riguardo gli effetti dei videogiochi. Secondo molti genitori italiani, i videogame porterebbero i propri figli a essere più aggressivi, meno creativi e meno sociali, un’opinione decisamente più negativa rispetto alla media europea.
Eppure l’enorme potere attrattivo di questo passatempo, capace di tenere i giocatori in attenta dedizione anche per tempi molto lunghi, può rivelarsi una risorsa da non sottovalutare anche al di fuori dell’ambito di gioco.
Non sono in pochi ad aver colto le potenzialità dei videogame, mutuando il loro utilizzo all’interno di terapie o allenamenti specifici. Persino la Cina ha ritrattato l’iniziale scetticismo nei confronti di questa tecnologia: dopo aver messo al bando nel 2000 i videogiochi a console per timore che corrompessero la gioventù, la Repubblica Popolare Cinese ha promosso negli ultimi anni l’uso di Glorious Mission, un first-person-shooter, per addestrare i suoi soldati al combattimento. Se piloti e chirurghi utilizzano già da tempo i videogiochi per allenare attenzione, precisione e capacità di concentrazione, alcuni progetti cercano invece di sfruttare l’interesse e la facilità con cui gli utenti giocano per veicolare in modo più efficace alcune terapie.
È il caso, tutto italiano, di The Fifth Element Project, un’applicazione dedicata ai bambini autistici, sviluppata da quattro giovani ingegneri con il supporto di una terapista. Il programma sfrutta la tecnologia Kinect, un dispositivo che rileva i movimenti del corpo e permette di interagire con il computer senza un contatto diretto, coinvolgendo i pazienti in diversi giochi adattati alle singole esigenze. L’idea, spiega Matteo Valoriani, dottorando di ingegneria informatica al Politecnico di Milano, è di utilizzare la tecnologia come incentivo per fare terapia, e al tempo stesso permettere di creare programmi di riabilitazione personalizzabili che possano essere usati da paziente e terapista anche a distanza. Dopo i risultati positivi dei primi due centri coinvolti, il progetto punta a raggiungere altre strutture in cui sperimentare la terapia.
La possibilità di realizzare programmi di riabilitazione a distanza attraverso la tecnologia dei videogiochi è stata sfruttata anche in diversi progetti dedicati alla cura degli anziani. Nel laboratorio Pong, nel dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano, Dario Maggiorini e Laura Ripamonti si sono occupati, tra le diverse aree di ricerca, di sviluppare software da utilizzare nella cura a lungo termine di pazienti anziani. La sfida, commenta Dario Maggiorini, è di creare un gioco intuitivo, adatto a persone che non sempre hanno molta dimestichezza con la tecnologia, che presenti una minima invasività e possa essere facilmente adattabile alle esigenze specifiche della terapia.
La facilità e l’intuitività del gioco sono le chiavi per l’utilizzo di questo tipo di strumento anche nella riabilitazione di persone con deficit cognitivi. Ne parla Matteo Cella, ricercatore di psicologia presso il King’s College di Londra, coinvolto in un progetto per la riabilitazione cognitiva di pazienti schizofrenici: “Alcuni disturbi cognitivi presenti in casi di schizofrenia, come difficoltà di attenzione e di memoria o alterazioni delle funzioni esecutive, non sono trattabili con le medicine. Anzi, può capitare che i farmaci antipsicotici peggiorino i deficit già presenti.” Per intervenire su questi problemi sono state studiate pratiche di rimedio cognitivo, che comprendono alcune attività di training computerizzato individuale. “La riabilitazione può essere molto impegnativa per i pazienti”, spiega Matteo Cella, “e presentarla in forma di gioco può renderla più accessibile per molti.” Il progetto in cui è coinvolto è ora in fase di sperimentazione in Inghilterra, ma per rendere i programmi veramente utili e funzionali sarebbe necessaria, secondo il ricercatore, una forte collaborazione con l’industria del videogioco.
L’interazione tra sviluppatori di videogame, neuroscienziati e operatori del servizio sanitario potrebbe facilitare l’introduzione di questa tecnologia in diversi ambiti terapeutici, e garantire uno sfruttamento controllato dei vantaggi offerti dal fascino dei videogiochi.
Accantonando timori e pregiudizi, anche i più tecnofobici potrebbero scoprire che sparare a orde di zombie non è poi così inutile come potrebbe sembrare (e non solo nel caso di un epidemia di non-morti).