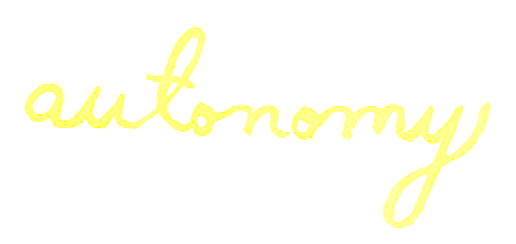Amniocentesi e villocentesi: qual è il rischio di aborto?
La letteratura scientifica disponibile ha molti limiti, ma secondo una recente revisione le percentuali di perdita dopo diagnosi invasiva sarebbero inferiori a quelle riportate di solito
 GRAVIDANZA E DINTORNI – Sono, al momento, le uniche tecniche per una diagnosi certa di anomalie cromosomiche, come la trisomia 21, responsabile della sindrome di Down, o le trisomie 13 e 18. Parliamo di villocentesi (prelievo dei villi coriali da un abbozzo della placenta) e di amniocentesi (prelievo di liquido amniotico): da questi materiali si possono derivare cellule fetali, sulle quali compiere le opportune indagini genetiche. Il problema è che tutto questo può avere un costo altissimo e cioè quello di aborto. Ma quanto è alto, esattamente, il rischio di perdere un bambino (magari sano) per effetto di una di queste tecniche? La domanda è fondamentale, perché è uno degli elementi in base ai quali una coppia decide di eseguire o meno una diagnosi prenatale invasiva. Ora, uno studio apparso su Ultrasound in Obstetrics & Gynecology sostiene che il rischio è molto più basso di quanto indicato di solito, anche in linee guida istituzionali o di società scientifiche. Vediamo.
GRAVIDANZA E DINTORNI – Sono, al momento, le uniche tecniche per una diagnosi certa di anomalie cromosomiche, come la trisomia 21, responsabile della sindrome di Down, o le trisomie 13 e 18. Parliamo di villocentesi (prelievo dei villi coriali da un abbozzo della placenta) e di amniocentesi (prelievo di liquido amniotico): da questi materiali si possono derivare cellule fetali, sulle quali compiere le opportune indagini genetiche. Il problema è che tutto questo può avere un costo altissimo e cioè quello di aborto. Ma quanto è alto, esattamente, il rischio di perdere un bambino (magari sano) per effetto di una di queste tecniche? La domanda è fondamentale, perché è uno degli elementi in base ai quali una coppia decide di eseguire o meno una diagnosi prenatale invasiva. Ora, uno studio apparso su Ultrasound in Obstetrics & Gynecology sostiene che il rischio è molto più basso di quanto indicato di solito, anche in linee guida istituzionali o di società scientifiche. Vediamo.
Le Linee guida per una gravidanza fisiologica del Ministero della Salue citano un rischio di perdita fetale pari all’1,9% dopo amniocentesi al 2% dopo villocentesi. Significa che si stimano circa due aborti ogni 100 procedure. Secondo il Royal College of Obstetricians and Gynaecologists del Regno Unito, il rischio è rispettivamente dell’1% e dell’1-2% dopo amnio e villocentesi. Per l’American College of Obstetricians and Gynecologists la stima è più bassa, con una perdita ogni 300-500 procedure sia per amniocentesi sia per villocentesi, mentre i membri della Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada citano, almeno per l’amniocentesi, un rischio molto variabile, che si colloca tra lo 0,19% e l’1,53%.
La situazione, dunque, è tutt’altro che chiara e uniforme, ma che cosa dicono gli studi scientifici? Ecco: proprio qui sta il problema. Il punto è che il modo migliore per stimare con la massima accuratezza possibile il rischio associato a tecniche invasive di indagine prenatale sarebbe quello di condurre uno studio clinico controllato e randomizzato. In pratica, bisognerebbe partire da un campione molto omogeneo di pazienti, suddividendoli “casualmente” (in modo randomizzato) in due gruppi: uno dovrebbe ricevere il trattamento (o l’intervento, o la procedura diagnostica) oggetto di studio, l’altro funzionare da controllo. In effetti, uno studio così per l’amniocentesi esiste ed è quello che indica un rischio di perdita fetale pari all’1%. Purtroppo, però, è uno studio di più di 30 anni fa. Praticamente un’era geologica, quando apparecchiature, attrezzature, formazione ed esperienza degli operatori erano inevitabilmente molto diversi da quelli di oggi.
Da allora sono stati condotti molti altri studi su amniocentesi e villocentesi e qualcuno ha anche affrontato il tema delle perdite fetali correlate, anche se non in modalità controllata e randomizzata. Ebbene, Ranjit Akolekar e colleghi, dell’Unità di medicina fetale del Medway Maritime Hospital di Gillingham, in Gran Bretagna, hanno deciso di mettere insieme questi studi, provando a sintetizzarne i risultati. Un metodo – tecnicamente si parla di revisione sistematica della letteratura e metanalisi – che almeno entro certi limiti dovrebbe permettere di aggirare le difficoltà delle singole indagini.
In breve, sono stati analizzati 21 studi clinici pubblicati dopo il 2000, per garantire uniformità rispetto ad attrezzature, materiali e tecniche e relativi a campioni di almeno 1000 procedure: 14 studi riguardavano l’amniocentesi e 7 la villocentesi. Il dato che emerge dalla metanalisi è di un rischio di aborto pari allo 0,11% dopo amniocentesi e allo 0,22% dopo villocentesi (uno-due casi ogni 1000 procedure). Non è zero, ma è decisamente più rassicurante di quello riportato attualmente per esempio dalle nostre linee guida. Non solo: per Akolakar e colleghi è comunque possibile che si tratti di una sovrastima, cioè che il rischio reale sia ancora più basso, perché l’analisi condotta non ha permesso di distinguere eventuali perdite fetali avvenute dopo l’indagine invasiva ma causate in realtà da situazioni preesistenti. In effetti è vero che spesso si arriva all’indagine invasiva perché ci sono stati “segnali negativi” in un precedente test di screening (come il test combinato), segnali che sono a loro volta associati a una maggiore probabilità di morte fetale spontanea.
Se il messaggio della metanalisi vuole essere rassicurante, c’è comunque un fattore importante di cui tenere conto: come ricordano anche gli autori, molti studi sottolineano che il rischio di perdita fetale dopo una procedura invasvida dipende molto anche dall’operatore: più questo ha esperienza, più il rischio è basso. Da qui il consiglio a rivolgersi a centri specializzati, dove queste indagini siano eseguite “in massa” e di routine. Questo vale per oggi, ma varrà ancora di più in futuro, quando probabilmente, grazie all’aumento del ricorso ai test di screening classici o ai recentissimi test sul DNA fetale circolante nel sangue materno, la frequenza di amniocentesi e villocentesi calerà.
Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()
Credit Immagine: Ultrasound examination of woman by Scott – Regina’s belly / Wikimedia Commons