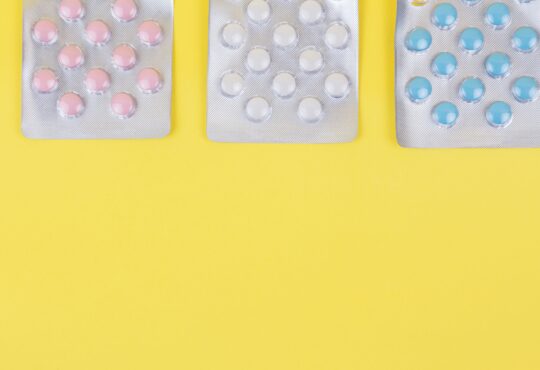Morte in utero: è ora di rompere il silenzio
Ogni giorno nel mondo 7200 bambini muoiono prima di nascere: un'epidemia silenziosa secondo la rivista Lancet, che chiama all'azione. Per prevenirla e abbattere il tabù che la circonda.
 GRAVIDANZA E DINTORNI – Nel 2015 in Italia circa 1600 bambini, quattro ogni giorno, sono morti prima di nascere, nel terzo trimestre di gravidanza. Quattro famiglie – una ogni 350 in attesa – hanno affrontato ogni giorno l’evento tragico e inaspettato della morte in utero, insieme ad altre 7200 famiglie nel mondo. Nel solo 2015 due milioni e 600 000 bambini sono morti così e la metà di loro durante il parto, a un soffio dalla luce, dalla possibilità di essere accolti vivi tra le braccia di mamma e papà. Una cifra sconcertante, messa nero su bianco dalla rivista Lancet che parla di “epidemia silenziosa“, perché nessuno ne parla. Perché nell’agenda degli organismi internazionali che si occupano di salute delle donne e dei bambini, a partire dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di fatto della natimortalità non c’è traccia o quasi. “L’idea che un bambino vivo nel momento in cui inizia il travaglio muoia nella manciata di ore successive, e per lo più per ragioni che possono essere prevenute, dovrebbe essere uno scandalo di proporzioni internazionali”, ha dichiarato il direttore della rivista, Richard Horton. “E invece non lo è”. Proprio per rompere questo “silenzio indicibile”, Lancet ha aperto il 2016 con una serie di articoli dedicati all’argomento, ma soprattutto con una call for action: “Non abbiamo bisogno di altri dieci anni di ricerca, di mettere a punto farmaci o vaccini, per poter fare qualcosa” sostiene Horton. “Possiamo agire subito”.
GRAVIDANZA E DINTORNI – Nel 2015 in Italia circa 1600 bambini, quattro ogni giorno, sono morti prima di nascere, nel terzo trimestre di gravidanza. Quattro famiglie – una ogni 350 in attesa – hanno affrontato ogni giorno l’evento tragico e inaspettato della morte in utero, insieme ad altre 7200 famiglie nel mondo. Nel solo 2015 due milioni e 600 000 bambini sono morti così e la metà di loro durante il parto, a un soffio dalla luce, dalla possibilità di essere accolti vivi tra le braccia di mamma e papà. Una cifra sconcertante, messa nero su bianco dalla rivista Lancet che parla di “epidemia silenziosa“, perché nessuno ne parla. Perché nell’agenda degli organismi internazionali che si occupano di salute delle donne e dei bambini, a partire dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di fatto della natimortalità non c’è traccia o quasi. “L’idea che un bambino vivo nel momento in cui inizia il travaglio muoia nella manciata di ore successive, e per lo più per ragioni che possono essere prevenute, dovrebbe essere uno scandalo di proporzioni internazionali”, ha dichiarato il direttore della rivista, Richard Horton. “E invece non lo è”. Proprio per rompere questo “silenzio indicibile”, Lancet ha aperto il 2016 con una serie di articoli dedicati all’argomento, ma soprattutto con una call for action: “Non abbiamo bisogno di altri dieci anni di ricerca, di mettere a punto farmaci o vaccini, per poter fare qualcosa” sostiene Horton. “Possiamo agire subito”.
Due gli ambiti fondamentali nei quali intervenire: la prevenzione, perché moltissime di queste morti precoci potrebbero essere evitate, e la lotta contro la stigmatizzazione e i tabù che in molti Paesi le circondano ancora, avvolgendo le famiglie colpite in una cappa dannosa di silenzio e negazione, quando non di condanna. Come prevedibile, molta attenzione si concentra sui Paesi poveri, quelli più colpiti dall’epidemia, con il 98% delle morti in utero totali. Come ricorda Lancet, “circa il 60% dei casi si verifica in zone rurali, e più della metà in aree interessate da conflitti”, cioè in condizioni con sistemi sanitari carenti o addirittura inesistenti. Anche i più ricchi, però, non possono tirarsi fuori dal discorso. “Lancet bacchetta anche Paesi come il nostro, che hanno tassi ridotti di morte in utero, ma che potrebbero abbassarli ulteriormente”, dichiara Claudia Ravaldi, psichiatra e presidente dell’associazione CiaoLapo Onlus per la tutela della gravidanza e della salute perinatale, fondata insieme al marito dopo la morte in utero del figlio Lapo. A questo proposito, Lancet prova a fare qualche conto e il risultato fa un certo effetto: se nel 2015 tutti i Paesi sviluppati avessero già raggiunto un tasso di natimortalità del due per mille, uno dei migliori registrati (l’Italia è a 3,3), avrebbero potuto evitare 19 440 morti in utero. Per l’Italia, questo significa che 640 famiglie avrebbero accolto il nuovo anno con un neonato tra le braccia, e non con la morte nel cuore.
Dati a parte, la domanda pressante è ovviamente “come prevenire”? Nei Paesi poveri, i colpevoli principali sono le malattie infettive – malaria in primis – e l’assenza di un sostegno competente alla gravidanza e al parto, ed è su questi aspetti che Lancet invita all’azione. Al centro del richiamo c’è la figura dell’ostetrica: ne servono di più, con una formazione adeguata, nei piccoli ospedali rurali oppure “itineranti”, in grado di raggiungere le partorienti di villaggio in villaggio. Anche nei Paesi ricchi la strada per limitare il numero di morti in utero passa per due stazioni principali, che sono la comprensione dettagliata delle cause e l’educazione – delle donne, ma anche degli operatori – sui fattori di rischio.
Per quanto riguarda le cause, l’ultimo rapporto Cedap (Certificato di assistenza al parto) del Ministero della salute offre un dato inquietante: solo nel 22,8% dei casi registrati è presente un’indicazione della causa. Il che vuol dire che molto spesso, di fronte a un bambino morto in utero non si sa dire il perché. “Una lacuna dolorosa per la famiglia, ma anche un problema sanitario importante, perché riduce la possibilità di prevenire altre perdite”, sostiene Ravaldi, che è anche tra gli autori di uno degli articoli della serie di Lancet. Dunque bisogna lavorare di più sulla diagnosi, compiendo indagini accurate sul feto e sulla placenta. In Italia esiste già dal 2008 un documento, presentato dal Ministero della salute, relativo alle indagini cliniche e all’assistenza in caso di morte in utero, con indicazioni molto precise su cosa fare, quando e come. E su come compilare in modo preciso la cartella clinica del bimbo nato morto, il primo passo fondamentale per la raccolta di dati puliti. “Il problema è che questo percorso viene seguito solo in pochi centri, per il resto rimane inapplicato” sottolinea Ravaldi.
L’altro filone, dicevamo, è quello dei fattori di rischio. “Nei Paesi ad alto reddito le cause principali di morte fetale sono legate a disfunzioni della placenta” spiega Ravaldi. “Sono condizioni complesse, che non conosciamo ancora in dettaglio, ma sappiamo che vari fattori possono influire negativamente sul funzionamento di questo organo: per esempio l’età materna, la presenza di diabete o pressione alta, oppure lo sviluppo di diabete e ipertensione durante la gravidanza, l’obesità, l’aumento eccessivo di peso in gravidanza, il fumo, il consumo di alcol“. Messo così, l’elenco fa pensare al rischio di gettare ancora una volta la croce addosso alla donna, incolpandola per non essere più troppo giovane, o per i chili di troppo, o perché fuma. “Ma non si tratta di colpevolizzare nessuno”, sbotta Ravaldi. “Si tratta solo di assumersi la responsabilità di cominciare a fare vera educazione su questi temi, come società in generale e come professionisti della salute in particolare”. Ravaldi cita alcuni esempi: “Alcuni professionisti sono ancora oggi restii a sottoporre una donna che abbia avuto una morte fetale a una batteria davvero completa di test. Magari se ne fa qualcuno, ma non si approfondisce la questione più di tanto. Altri affrontano con troppa leggerezza temi come il fumo o l’alcol. Senza rendersi conto che a donne che dovrebbero avere qualche attenzione in più, perché magari non sono più giovanissime, o hanno uno stile di vita poco sano, arrivano messaggi erroneamente tranquillizzanti”.
Resta il fatto che, prevenzione o non prevenzione, fattore di rischio o meno, la morte di un bambino nella pancia della mamma può accadere, ed è qui che si colloca la seconda linea d’azione di Lancet. Perché una volta che l’evento è accaduto non si può e non si deve negarlo, nasconderlo, minimizzarlo. Se già di morte, in molte culture, si parla poco, di quella in utero non si parla proprio mai. “Troppo spesso le donne sono lasciate sole a soffrire in silenzio”, sottolinea la rivista nella sezione dedicata a infrangere i tabù sul lutto perinatale. Non vale solo per certi Paesi poveri o poverissimi, in cui l’evento si associa a un profondo stigma sociale, nella convinzione che a causarlo siano stati addirittura spiriti maligni. Vale anche per molti Paesi avanzati, dove spesso la perdita di un bambino durante la gravidanza diventa un immenso elefante nella stanza.
“Spesso c’è una corsa a minimizzare la questione, da parte sia di operatori sanitari, sia di parenti e amici”, racconta Ravaldi, ripensando alle centinaia di esperienze riferite dalle donne che hanno chiesto aiuto all’associazione. Mamme – e papà – di bambini nati morti possono sentirsi dire che capita, che non ci devono rimuginare sopra, che la prossima volta andrà meglio. Una pacca sulle spalle e via: quello che è stato è stato, ritenta e sarai più fortunato. “Ma il lutto non funziona così, tanto più il lutto di un evento traumatico come questo”, precisa la psichiatra. “Il lutto ha bisogno di essere riconosciuto e accolto, e ha bisogno di tempo per essere elaborato. È un processo fisiologico, del tutto normale. Negare che ci sia, negare il dolore e la sofferenza, non è di nessuno aiuto, anzi ostacola il percorso di ‘guarigione’ e può portare a patologie psichiatriche”. Anche in questo caso Lancet formula qualche stima, dichiarando che sarebbero 4,2 milioni le donne nel mondo che soffrono di depressione associata a una morte in utero. Con conseguenze importanti per la loro salute, per quella dei loro famigliari, ma anche per la società, se si pensa alla riduzione della performance lavorativa di una persona con depressione (per altro, anche i papà ne sono colpiti). Per Lancet, insomma, non è più tempo di tentennamenti: “i bambini che muoiono in utero devono essere riconosciuti e le voci dei loro genitori ascoltate”.
Leggi anche: La placenta su chip
Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()
Crediti immagine: YLegrand, Flickr