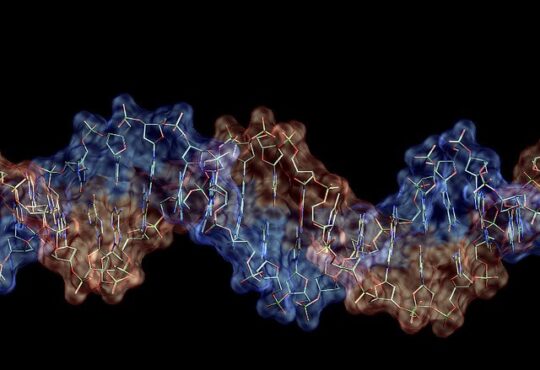Presbiopia, gotta e infarti: le scimmie hanno le nostre malattie
Uno studio, pubblicato su Current Biology, ha mostrato che la presbiopia colpisce anche i bonobo verso i 40 anni di età. Ma quali altre malattie condividiamo con i primati?

RICERCA – Arrivati a una certa età, tendiamo ad allontanare dal viso giornali e oggetti: colpa della presbiopia. Ma non siamo l’unica specie a farlo. Ora sappiamo che anche il bonobo, o scimpanzé nano (Pan paniscus), ne soffre.
Uno studio pubblicato su Current Biology spiega perché i soggetti più attempati dei suddetti primati si tenessero a una certa distanza nello spulciare i propri simili. Firmato da ricercatori della nipponica Università di Kyoto e da quella britannica di St. Andrew, la ricerca è nata da un’osservazione casuale: un bonobo che teneva le braccia quasi del tutto distese durante il cosiddetto grooming, l’immancabile tolettatura reciproca di grande rilevanza sociale.
Osservando un gruppo di 14 esemplari dall’età compresa tra gli 11 e i 45 anni, si è constatato che i primi sintomi di presbiopia si manifestavano tra i tardi 30 e i primi 40 anni: un andamento incredibilmente simile a quello che si riscontra nell’uomo, a evidenziare quanto questa patologia non sia un frutto del nostro moderno stile di vita (che ci costringe sempre più a utilizzare oggetti vicini agli occhi, a partire dagli smartphone).
“Ciò suggerisce che questa senescenza degli occhi non sia cambiata granché dall’antenato comune Pan-Homo, nonostante la longevità degli umani moderni sia assai più lunga di quella di scimpanzé e bonobo” spiega Heungjin Ryu del Primate Research Institute dell’Università di Kyoto.
I bonobo che ne soffrono, non vivono solamente con meno praticità il rito del grooming (dovendo operare spesso anche nella penombra della foresta), ma subiscono anche una sorta di emarginazione: i presbiti vengono chiamati in causa quasi sempre come seconde scelte.
A differenza degli aggressivi scimpanzé, i pacifici bonobo maschi riescono a superare i 40 anni di vita, il che ha consentito di venire a conoscenza della loro presbiopia. Una fortuita scoperta che può aprire la strada per gli studi sulla longevità post-menopausa nella specie Homo, verosimilmente accresciutasi in ambienti coesivi e tranquilli.
Ma la presbiopia non è la sola malattia che gli esseri umani condividono con i primati: c’è anche la degenerazione maculare senile, causa principale di cecità in età avanzata, nota anche con l’acronimo inglese di AMD. Ne sono affetti i macachi resi, i cui occhi presentano una struttura complessa identica a quella degli umani: un modello naturalmente perfetto per la ricerca.
Firmato da ricercatori della University of Florida, della Medizinische Hochschule di Hannover e della Christian-Albrechts–Universität di Kiel e pubblicato sulla rivista Experimental Eye Research, uno studio del 2005 ha analizzato una regione cromosomica e alcuni marcatori genetici della degenerazione maculare sia degli umani che delle scimmie.
Il gruppo ha esaminato sette siti genetici nei macachi, i cui siti corrispondenti nei cromosomi umani sono associati alla malattia maculare (in una di queste aree risiedono i geni che ne predicono lo sviluppo). Pur ignorando molti elementi alla base di questo male incurabile, da lungo tempo gli autori sospettavano che il disturbo negli uomini e nelle scimmie avesse simili origini. Cosa puntualmente confermata dai risultati.
Tutt’altra patologia è invece la gotta. Ne soffrono scimpanzé, gorilla, orangutan e gibboni. Questa forma di artrite – la più grave che esista – è caratterizzata da un eccesso di acido urico nel sangue. Tale sostanza, che normalmente verrebbe filtrata dai reni ed espulsa con le urine, si accumula invece nelle articolazioni sotto forma di cristalli insolubili, gonfiandole e rendendone dolorosa l’attività. Causa di tutto questo è la mancanza dell’enzima uricasi, dalla lunga storia evolutiva. Piante, batteri e la maggior parte dei mammiferi lo producono. Le grandi scimmie no.
Il gene che lo regola sarebbe scomparso durante il Miocene, cioè tra 10 e 20 milioni di anni fa: quello nel nostro corredo è quindi uno pseudogene. Secondo una ricerca americana pubblicato su Pnas nel 2014, ciò avrebbe consentito di accumulare rapidamente grassi attraverso il metabolismo del fruttosio ottenuto dalla frutta. Un adattamento che avrebbe poi avvantaggiato i nostri antenati quando le foreste pluviali di Europa e Asia cedettero il posto a quelle temperate, alla fine dell’Oligocene.
In un’altro studio statunitense – diffuso su Hypertension nel 2002 – si discute di come la perdita dell’uricasi abbia favorito la sopravvivenza dei mammiferi che si nutrivano di vegetali, poveri di sale, e che stavano assumendo la posizione eretta: l’aumento dell’uricemia avrebbe compensato i bassi livelli di sodio, mantenendo costante o elevando la pressione arteriosa, adeguandola di fatto alla postura.
Seppur causato da differenti processi patologici, altro male che colpisce sia gli uomini che gli scimpanzé – al centro di un’indagine californiana pubblicata nel 2009 su Evolutionary Applications – è l’attacco cardiaco. Solo che in queste scimmie (Pan troglodytes), le più simili all’uomo per quantità di patrimonio genetico condiviso, è spesso dovuta a fibrosi miocardica interstiziale di origine sconosciuta. Indagini istopatologiche e letteratura lo documentano.
Nell’uomo, invece, la maggior parte dei casi deriva da arteriosclerosi coronarica, che impedisce l’afflusso di sangue al miocardio con conseguente ischemia.
Il tipico infarto miocardico dovuto a trombosi dell’arteria coronaria è rara in queste scimmie, nonostante i loro livelli di lipidi nel sangue siano comparabili a quelli di pazienti a rischio coronarico. Sono invece le aritmie innescate da fibrosi del miocardio a causare attacchi cardiaci. Questo disturbo non è comune nell’uomo e – viceversa – gli scimpanzé non soffrono di arteriosclerosi coronarica. La risposta sembra risiedere nella glicosilazione.
Si sa che soffrono del morbo di Alzheimer anche i macachi resi (Macaca mulatta). Come spiegato in una ricerca statunitense del 2003 pubblicata su Mechanisms of Ageing and Development, gli esemplari che hanno trascorso la prima parte della vita in gabbie di piccole dimensioni presentavano un maggior numero di placche amiloidi – segnale inequivocabile della presenza di Alzheimer – e più connessioni neuronali danneggiate rispetto ad altri animali vissuti sì in cattività, ma in spazi più ampi. Non a caso nell’uomo si pensa che lo stress possa favorire la comparsa della demenza. Qui quello provocato da una gabbia eccessivamente angusta ha reso il cervello più vulnerabile.
Quanto ad altre gravi malattie degenerative (come, ad esempio, Parkinson e Huntington), ancora non si sa se colpiscono i primati. Di certo questi hanno potuto dare un contributo alla ricerca scientifica in vario modo (scimmie transgeniche), ma qui entreremmo in un altro – delicatissimo – ambito: quella della sperimentazione animale.
Resta che queste infermità rendono ancor più evidente la nostra parentela con le grandi scimmie. Una parentela scomoda per lungo tempo (e che ancora lo è per i creazionisti), che però sta dischiudendo i segreti del nostro Dna.
Leggi anche: Scimmie ingegnose e utilizzo degli strumenti
Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()