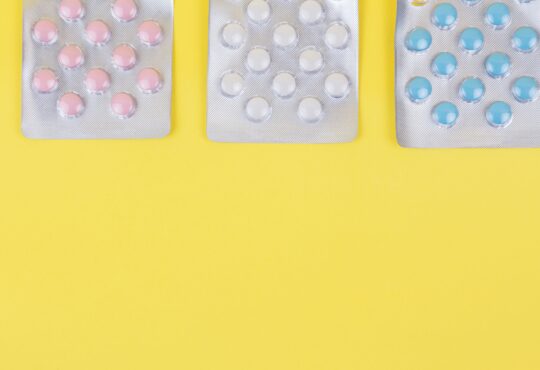L’HIV in Africa, 30 anni dopo
Come è cambiata la situazione? Ce lo racconta il medico Giampietro Pellizzer, che da decenni lavora in Tanzania attraverso Medici con l'Africa Cuamm.
APPROFONDIMENTO – Giampietro Pellizzer è un medico infettivologo, prestato in più occasioni a Medici con l’Africa Cuamm, uno di quelli che l’AIDS l’ha visto “nascere”, dalla fine degli anni Ottanta, e mettere in ginocchio un continente.
Due decenni di studio, progetti, strategie e negoziazioni con le realtà locali lo hanno convinto di una cosa: la principale sfida che dobbiamo affrontare per sconfiggere definitivamente l’HIV è ancora oggi strutturare delle strategie per portare i servizi alle persone, non solo aspettare le persone nei centri sanitari.

È il punto di partenza per porre le basi di una strategia di controllo concreta della malattia: convincere le persone a fare il test per l’HIV. Il primo degli obiettivi della strategia 90-90-90 delle Nazioni Unite per sconfiggere l’AIDS è fare in modo che entro il 2020 almeno il 90% della persone con HIV abbia fatto lo screening.
Ma siamo ben lontani da questo obiettivo. “In Tanzania il 5% della popolazione è sieropositivo ma solo il 70-80% dei sieropositivi conosce il proprio stato perché si è sottoposto al test” racconta Pellizzer a OggiScienza.
Dopo un periodo di crescita della malattia in tutta l’Africa, dal 1997 in poi le cose hanno iniziato progressivamente e lentamente a migliorare. Secondo i dati di UNAIDS, dal 2010 al 2018 è diminuito del 30% il numero di nuove infezioni in Africa Meridionale e Orientale e dell’8% in Africa Centrale e Occidentale. Nello stesso periodo la percentuale delle morti dovute all’AIDS è diminuita rispettivamente del 42% e del 24%.
Ma non basta, perché il punto non è che le persone non sanno che cos’è l’HIV e quali rischi corrono. Bensì che per molti sottoporsi al test non è una priorità: anche solo il rischio di sieropositività è uno stigma, nonostante si tratti di una malattia molto diffusa.
Combattere lo stigma
“Tante cose sono cambiate in positivo in trent’anni: oggi di HIV si parla di più e c’è sempre meno paura – ci spiega Pellizzer – ma una cosa è rimasta la stessa: l’HIV in Africa, soprattutto nelle zone rurali, è ancora un motore di esclusione sociale, per ragioni fondamentalmente antropologiche, culturali. Le persone preferiscono addirittura evitare che parenti e conoscenti pensino che possano essere malati, al di là del risultato del test”.
Non dimentichiamo poi che essere sieropositivi significa in molti casi non riuscire a trovare lavoro, fare fatica a sposarsi. “Non a caso osserviamo che in molti preferiscono intraprendere lunghi viaggi per fare il test lontano da casa rispetto al centro sanitario più vicino, fattore che ovviamente influenza economicamente la scelta di sottoporsi al test”.
Affinché la prevenzione sia davvero efficace è necessario sottoporsi al test prima che compaiano i primi sintomi, prima cioè che sia il medico a indirizzare il paziente in un centro specializzato. Se i sintomi già ci sono significa che la malattia è a uno stadio più avanzato e che il paziente può aver contagiato molte persone.
“I dati sull’utilizzo del preservativo sono variabili, difficili da valutare. Semplificando, il condom dovrebbe essere disponibile, accessibile e gratis. Cosa che tutti i programmi nazionali di lotta a HIV/AIDS si sforzano di mettere in pratica” spiega Pellizzer. “Efficace per contenere la trasmissione è anche la circoncisione maschile che, per ragioni biologiche, riduce il rischio di trasmissione del virus del 60%”.
“Dopo tanti anni posso dire che la strategia più efficace per far fare il test alle persone è andare da loro, per esempio durante grandi eventi associativi come le partite di calcio, mercati, feste nazionali, con un’unità mobile o un gazebo, unitamente alla comunicazione attraverso la radio e gli sms”. Diversamente da quanto possiamo pensare noi occidentali, nonostante la presenza di fatto capillare di internet, esso rimane ancora uno strumento di secondaria importanza per una diffusione capillare dei messaggi.
“Non tutti nelle zone più rurali hanno gli smartphone e in ogni caso non è così facile raggiungere ognuno” racconta Pellizzer.
Accesso ai servizi e aderenza alle terapie
Gli altri due obiettivi della strategia sono che 1) il 90% dei sieropositivi riceva la terapia e che 2) almeno il 90% di chi la riceve la segua con costanza, per ottenere la soppressione virale. Se la terapia viene seguita solo saltuariamente il virus diventa facilmente resistente, mentre se viene assunta con regolarità la malattia è sotto controllo, non progredisce e la trasmissione arriva vicina allo zero.
Qui ci troviamo di fronte ad altri problemi: l’accesso ai servizi e l’aderenza terapeutica, che si riesce a misurare osservando a che punto è la soppressione virale attraverso gli esami del sangue della persona sieropositiva.
“Su quest’ultimo aspetto in Tanzania i dati sono incoraggianti – racconta Pellizzer – dal momento che oltre l’80% dei trattati raggiunge la soppressione virale, che abbatte la trasmissione. Sicuramente contribuisce a questo buon risultato il fatto che i farmaci antiretrovirali siano disponibili gratuitamente per le persone sieropositive”.
Il problema rimangono i costi a carico del paziente, cioè quelli per altri farmaci o cure e quelli per l’accesso ai servizi. Anche se è difficile generalizzare, si può dire che nella maggior parte degli ospedali in Africa una quota dei costi diretti è a carico del paziente. Non esistono forme di welfare ben strutturate che prevedano esenzioni, nemmeno per i malati di AIDS. Se da sieropositivo ti ammali di epatite B o di malaria, ti devi pagare visite e farmaci, quando ci sono. E se hai la sfortuna di avere effetti collaterali dovuti alle terapie, che ti impediscono di lavorare, è un problema tuo.
Al centro il rapporto con le autorità locali
In una malattia dove è centrale il ruolo dei determinanti sociali, è cruciale il rapporto con le autorità, i governi, per un approccio davvero integrato. L’HIV si riduce lavorando laddove c’è prostituzione e facendo prevenzione nelle prigioni. Siamo portati a pensare che le organizzazioni internazionali operino in una sorta di autonomia volta all’assistenzialismo, ma nella maggior parte dei casi non è così.
“In un paese come la Tanzania per esempio, dove non c’è la guerra al momento, il sistema c’è” spiega Pellizzer. “Qualsiasi organizzazione internazionale opera seguendo le strategie governative relazionandosi con il proprio distretto, e i programmi nazionali sono costruiti seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Quando come CUAMM dobbiamo mettere in piedi una campagna informativa, per esempio, dobbiamo coordinarci con il Ministero per stabilire come formulare i messaggi da inviare alla popolazione.”
“Quello che preoccupa è la fragilità dei sistemi sanitari africani, l’impossibilità di essere, ad ora, autonomi nel gestire una malattia che assorbe ingenti risorse” conclude Pellizzer.
“Leggo spesso che i paesi donatori prospettano una riduzione degli aiuti per la lotta a HIV/AIDS, una riduzione progressiva, lenta, del 5%, tanto per cominciare, come stimolo per i governi locali, ma la verità è che non è ancora il momento anzi, rischieremmo di vanificare tutto ciò che è stato fatto, con fatica, negli ultimi anni in termini di diminuzione del numero di nuovi casi e di incremento dell’aspettativa di vita dei malati”.
Segui Cristina Da Rold su Twitter
Leggi anche: L’Africa corre ma non pianifica: una lezione dalle epidemie di ebola
Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()