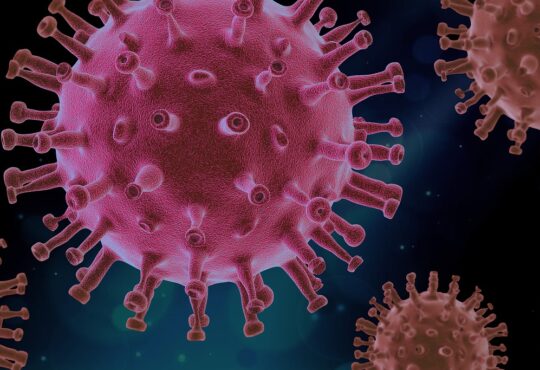Gli effetti del Covid-19 sul cervello
Nebbia mentale, emicrania, ansia, depressione. Molte persone afflitte da sindrome post-Covid soffrono di disturbi neurologici e cognitivi persistenti. Scoprire le cause potrebbe cambiare la nostra visione delle malattie infettive e aiutare chi non riesce a guarire.

Più le conoscenze si accumulano, più diventa chiaro che sconfiggere l’infezione non sempre significa guarire dal COVID-19. Oggi si stima che almeno un paziente su dieci, o forse addirittura uno su tre, continui a soffrire di disturbi fisici e mentali, spesso molto debilitanti, per settimane o per mesi. La sindrome post-COVID, chiamata anche Long COVID, è una realtà con cui la sanità dovrà presto fare i conti perché affligge milioni di persone in tutto il mondo e può manifestarsi anche con sintomi neurologici e psichiatrici che destano crescente preoccupazione.
È infatti ormai evidente che SARS-CoV-2 non mette in un pericolo solo i nostri polmoni ma, in modo diretto o indiretto, può colpire diversi altri organi, dal cuore ai reni, fino al cervello. Con ricadute importanti anche per chi non aveva sviluppato una forma grave della malattia, al punto che alcuni dei sintomi neuropsichiatrici che possono sopraggiungere dopo essere stati dichiarati guariti sono talvolta più severi di quelli causati dall’infezione. Una consapevolezza che potrebbe cambiare le conoscenze mediche sulle malattie infettive e che impone di accelerare la ricerca sulle origini e sulle possibili cure per il Long COVID, un male angosciante che continua a causare sofferenza anche quando nel corpo non c’è più traccia del coronavirus.
Quel che sappiamo sul Long COVID
Ormai disponiamo di studi abbastanza estesi da restituire un quadro attendibile della diffusione della sindrome post-COVID. Tra questi spicca una ricerca pubblicata in gennaio sulla rivista Lancet e condotta su 1.733 persone che si erano infettate a Wuhan durante la prima ondata della pandemia. I risultati mostrano che tre quarti dei pazienti ricoverati manifestavano almeno un sintomo correlato alla COVID-19 a distanza di sei mesi dall’infezione. I disturbi più diffusi erano affaticamento e debolezza muscolare, riscontrati nel 63% dei pazienti, e difficoltà respiratorie, diagnosticate nel 56% di coloro che avevano avuto bisogno di ventilazione meccanica, nel 29% delle persone a cui era stato necessario somministrare ossigeno di ossigeno, ma anche nel 23% di chi non aveva avuto necessità di supporto respiratorio. Inoltre, a sei mesi dalla dimissione ospedaliera, il 23% dei pazienti soffriva ancora di ansia e depressione.
Sono alcuni dei sintomi più comuni osservati nei long hauler, le persone che a distanza di almeno quattro settimane dal contagio continuano a manifestare disturbi persistenti. Nei primi mesi gli studi clinici si sono concentrati sulle persone ospedalizzate, dando l’impressione che il problema riguardasse per lo più chi aveva sviluppato sintomi gravi della malattia, ma con il passare del tempo si è compreso che i disturbi tipici del Long COVID sono molto più diffusi di quel che si credeva perché possono insorgere anche negli asintomatici e tra coloro che avevano manifestato solo sintomi lievi, come ha mostrato di recente uno studio pubblicato su JAMA dai ricercatori dell’Università di Washington. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riconosce che, nel complesso, il Long COVID riguardi circa un quarto delle persone contagiate da SARS-CoV-2.
Di solito i primi disturbi compaiono qualche giorno dopo che l’infezione ha fatto il suo corso. E se in principio sentirsi spossati può apparire normale dopo la debilitazione causata dalla febbre e dalla comprensibile preoccupazione che genera una diagnosi di COVID-19, nessuno è preparato a quel che può accadere nelle settimane successive, scandite da strani sintomi che vanno e vengono senza un motivo apparente e che impediscono di tornare alla normalità. Ancor di più se i disturbi toccano la sfera delle nostre capacità cognitive e d’improvviso persino trovare le parole giuste, ricordare il modello della propria auto o leggere una mail diventa un’impresa impossibile.
I disturbi neuropsichiatrici e cognitivi
Oggi sappiamo che le possibili ricadute di un infezione da SARS-CoV-2 non risparmiano il cervello e nei casi più critici possono portare anche a ictus e encefaliti. Sono tuttavia più frequenti disturbi neurologici e cognitivi meno gravi ma persistenti che, seppure più diffusi tra chi ha subito un ricovero ospedaliero, colpiscono anche le persone asintomatiche e chi durante l’infezione ha manifestato solo sintomi lievi, giovani e bambini inclusi. La pandemia è così recente che gli studi rigorosi su ampia scala sono ancora pochi, ma la ricerca clinica ha cominciato a fare luce anche sugli effetti neurologici e cognitivi a lungo termine del COVID-19.
Una ricerca condotta dall’Università di Oxford e pubblicata lo scorso 6 aprile sulla rivista Lancet Psychiatry ha stimato che in circa un terzo dei pazienti è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico o neurologico entro sei mesi dall’infezione, evidenziando che il rischio è maggiore rispetto alle persone non contagiate. I sintomi più comuni sono ansia, disturbi dell’umore, insonnia. Lo studio, che si è basato sull’analisi delle cartelle cliniche di oltre 236mila pazienti statunitensi infettati da SARS-CoV-2, evidenzia inoltre un rischio più elevato di incorrere in ictus e forme di demenza, soprattutto fra le persone ospedalizzate, mentre non è emerso una maggiore esposizione ad altre malattie neurologiche come il morbo di Parkinson o la sindrome di Guillain-Barré.
Un altro studio pubblicato sulla rivista Annals of Clinical and Translational Neurology ha invece esaminato la storia clinica di un centinaio di pazienti del Northwestern Memorial Hospital di Chicago che, pur non avendo avuto bisogno di un ricovero ospedaliero durante la fase acuta dell’infezione, hanno ugualmente sviluppato sintomi neurologici ascrivibili al Long COVID. A sei settimane dall’infezione, infatti, l’85% di loro presentava ancora quattro o più disturbi neurologici: difficoltà cognitive, mal di testa, formicolio, perdita del gusto e dell’olfatto, dolori muscolari, affaticamento e vertigini. Il 42% soffriva inoltre di ansia o depressione. Si è riscontrata anche una riduzione di capacità cognitive come l’attenzione e la memoria breve termine. I pazienti avevano un’età media di 43 anni. Nelle settimane successive la maggior parte ha riferito un miglioramento, ma non è stato così per tutti e dopo cinque mesi dal contagio solo il 64% si sentiva guarito.
Di recente ha ricevuto molta attenzione la cosiddetta nebbia mentale (o brain fog), il termine informale usato per descrivere la costellazione di disturbi cognitivi che affligge molti long hauler: difficoltà a concentrarsi o a mantenere l’attenzione, perdita di memoria a breve termine, vertigini e un generale senso di confusione. I sintomi possono diventare così debilitanti da impedire di tornare al lavoro o anche solo di svolgere qualsiasi faccenda domestica. I sintomi della nebbia mentale sono molto diffusi anche tra i giovani che prima di ammalarsi di COVID-19 non avevano problemi di salute.
Il mistero sulle cause
Come SARS-CoV-2 riesca a fare tutto questo è ancora in gran parte ignoto. Tra gli esperti circolano diverse ipotesi, che non per forza si escludono a vicenda, per spiegare l’origine dei disturbi neurologici e psicologici associati al Long COVID. Una prima ipotesi è che il coronavirus SARS-CoV-2 possa infettare le cellule del sistema nervoso, ma finora dalle autopsie e dalle risonanze magnetiche non sono emerse evidenze di danni ai neuroni.
Una seconda teoria ipotizza che il coronavirus sia ancora annidato nel corpo dei long-hauler, nascosto da qualche altra parte nell’organismo. Pur sfuggendo ai tamponi nasofaringei, sarebbe ancora in grado di replicarsi e di stimolare un’infiammazione cronica che potrebbe spiegare molti sintomi tipici del Long COVID. Ricorda del resto quel che accade con alcuni virus della famiglia degli herpes, capaci di restare a lungo quiescenti prima di riattivarsi; né è un esempio il virus della varicella, che può scatenare il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio anche a distanza di decenni.
Oppure l’infezione da SARS-CoV-2 potrebbe creare un tale subbuglio nel sistema immunitario e forse nell’intero organismo da provocare la riattivazione (o slatentizzazione, nel gergo medico) di altri virus latenti, come potrebbe essere successo un secolo fa con l’encefalite letargica, forse risvegliata dalla pandemia di influenza Spagnola.
Secondo la teoria più accreditata, tuttavia, SARS-CoV-2 innescherebbe una riposta immunitaria eccessiva che non si placa neppure dopo il superamento dell’infezione, dando origine a infiammazioni che possono colpire diversi organi, compreso il cervello. Una cascata di molecole infiammatorie prodotte dal nostro organismo in risposta al contagio finirebbe per agire come tossine per il cervello, spiegando i disturbi cognitivi che colpiscono i long hauler. Lo stretto legame fra infiammazioni e disturbi come l’ansia e la depressione, inoltre, sono noti da tempo.
Alcuni esperti hanno anche evidenziato le analogie con altre malattie enigmatiche come la sindrome da stanchezza cronica (o encefalomielite mialgica), che potrebbe spiegare l’estremo affaticamento provato da gran parte dei long hauler, o con la disautonomia, una disfunzione del sistema nervoso autonomo che controlla importanti funzioni corporee come la respirazione, il battito cardiaco e la pressione sanguigna, che potrebbe dare conto delle difficoltà di respiro o delle alterazioni nel battito cardiaco.
Si guarda infine anche al passato, perché non è la prima volta che un’epidemia lascia dietro di sé uno strascico di disturbi neurologici a lungo termine. In particolare, sintomi simili a quelli del Long COVID sono stati descritti anche durante le epidemie di SARS (2003) e di MERS (2012), entrambe causate da un coronavirus, ma il numero relativamente basso di contagi ha impedito di raccogliere abbastanza dati per indagare l’origine del problema.
In cerca di una cura
Molti ricercatori sono convinti che la mole di studi sulla pandemia di COVID-19 cambierà la nostra visione delle malattie infettive. Scoprire i meccanismi che portano al ventaglio di sintomi neurologici, psichiatrici e cognitivi riscontrati nei long hauler non è tuttavia una mera questione accademica, perché potrebbe aiutare i clinici a scegliere i percorsi terapeutici più efficaci. Riconoscendo l’importanza del problema, grazie soprattutto all’attivismo delle associazioni di pazienti sorte in numerosi Paesi, in febbraio i National Institutes of Health (NIH) statunitensi hanno annunciato un’iniziativa quadriennale per indagare le cause del Long COVID e trovare risposte terapeutiche adeguate.
Le incognite sono ancora molte, a partire dal fatto che non sappiamo quali persone siano più rischio di sviluppare i sintomi del Long COVID. Secondo quanto riporta l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), «le donne sembrano avere il doppio delle probabilità di sviluppare il Long COVID rispetto agli uomini, ma solo fino a circa 60 anni, quando il livello di rischio diventa simile». Anche l’età avanzata e un indice di massa corporea più alto sono considerati fattori di rischio. Ma come emerge dall’esperienza clinica del Policlinico Gemelli di Roma e della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), il Long COVID può colpire anche bambini e adolescenti.
Inoltre nessuno può dire con certezza quanto a lungo possono durare i disturbi associati al Long COVID, né escludere che in alcuni casi possano lasciare segni permanenti, perché conosciamo SARS-CoV-2 da troppo poco tempo. In base all’esperienza maturata con altre infezioni virali, la maggior parte degli esperti ritiene che, soprattutto tra i non ospedalizzati, i sintomi possano regredire spontaneamente dopo alcuni mesi. È quel che si osserva anche per i disturbi neurologici e cognitivi di molti long hauler, ma purtroppo ancora non è stato così per tutti.
Considerando inoltre che gli effetti della pandemia sulla salute mentale si estendono purtroppo ben oltre il perimetro del Long COVID, soprattutto a causa delle privazioni sociali imposte dal lockdown e per la difficoltà di offrire un supporto psicologico adeguato durante l’emergenza, nei prossimi mesi, quando grazie alle vaccinazioni la fase più critica dell’epidemia potrebbe essere superata, la sanità potrebbe trovarsi ad affrontare «uno dei più grandi eventi invalidanti di massa nella storia moderna».
Ancora non sappiamo se i vaccini siano in grado di mitigare i sintomi dei long hauler, né se prevengano anche le infezioni lievi o asintomatiche, offrendo così un argine alla diffusione del Long COVID; la loro efficacia è stata infatti valutata in base al grado di protezione contro le forme più severe della malattia.
Perciò, come ha scritto sul Guardian Fiona Lowenstein, portavoce di Body Politic, finché non avremo certezza che i vaccini forniscano un’immunità sterilizzante, qualsiasi contagio, anche in forma lieve o asintomatica, dovrebbe essere considerato una minaccia sia per la salute pubblica sia per l’economia, per via delle tante persone, spesso in età lavorativa, esposte al rischio di sviluppare i sintomi debilitanti del Long COVID. Un motivo in più, se non ce ne fossero già abbastanza, per cercare di limitare con ogni mezzo la circolazione virale e abbassare al più presto la curva epidemica.
Leggi anche: “Il viaggio segreto dei virus”, di Ilaria Capua
Articolo pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia.
Photo by S&B Vonlanthen on Unsplash