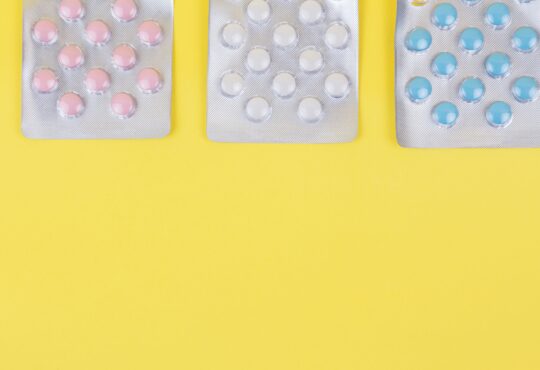Sequenziare il DNA dei neonati. Oppure no?
Luci e ombre di una delle ultime frontiere della medicina genomica: quando serve davvero e quando, invece, potrebbe essere critico.

Giacomo nascerà tra pochi giorni e, se i suoi genitori lo desiderano, potrebbe avere a disposizione da subito un pacchetto di informazioni sul rischio di andare incontro nella vita a certe malattie, sugli alimenti da evitare e i farmaci da non assumere – pena pesanti effetti collaterali – o sulle dosi più opportune dei farmaci consentiti. Tutto grazie a un prelievo di sangue o di saliva dal quale ricavare la sequenza completa (o quasi) del suo DNA. È la promessa di una delle ultime frontiere della medicina genomica, non priva però di zone d’ombra. Così i genitori di Giacomo hanno preso contatti con un’azienda privata che offre questo servizio, ma non hanno ancora deciso se richiederlo davvero.
Per molti il futuro non potrà che essere questo: sequenziare alla nascita il DNA di un individuo – anzi di ogni individuo, non con test genetici offerti direttamente al consumatore, ma nell’ambito di programmi pubblici di screening – in modo da stabilire per ciascuno, già dai primi giorni di vita, un piano personalizzato di prevenzione del rischio di malattie. Ne è convinto Francis Collins, uno dei papà del Progetto genoma umano, che nel 2003 ha consegnato alla storia la prima sequenza completa del DNA della nostra specie, oggi direttore dei National Health Institutes americani. Lo scriveva nel 2010 nel libro The language of life: “Via via che riconosciamo nuovi interventi per la prevenzione di fattori di rischio genetico e scopriamo che sono tanto più efficaci quanto prima sono messi in atto, diventa sempre più urgente ottenere queste informazioni alla nascita”.
Zone d’ombra e possibilità del futuro della prevenzione
Non tutti, però, la pensano così. Di sicuro non rispetto a test come quello che stanno valutando la mamma e il papà di Giacomo: “Indagini che banalizzano il significato delle analisi genomiche trascurandone i rischi e vendono più l’illusione di farci conoscere il destino che strumenti concreti per modellarlo davvero”, dice a OggiScienza Faustina Lalatta, direttrice dell’Unità di genetica medica del Policlinico di Milano.
Su questi test si è espressa chiaramente la Società europea di genetica umana, dichiarando nel 2010 che “non devono essere proposti per individui che non abbiano raggiunto la maggiore età”. Ma la discussione che si sta svolgendo a livello internazionale riguarda anche la possibilità e l’opportunità di usare il sequenziamento del DNA come test di screening per tutti i neonati nell’ambito di sistemi di sanità pubblica.
Intendiamoci: ci sono situazioni nelle quali l’utilità di questo approccio sta già ricevendo ampi riconoscimenti. “Per esempio quando ci si trova di fronte a un neonato in condizioni critiche, con malattie gravi delle quali si sospetta un’origine genetica senza però riuscire ad arrivare a una diagnosi con gli strumenti tradizionali, come singoli test genetici eseguiti passo dopo passo” chiarisce la professoressa Alessandra Renieri, responsabile dell’Unità di genetica medica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Siena e tra gli autori di un documento congiunto sull’argomento di varie società scientifiche italiane di genetica e pediatria.
“In questi casi, guardare il genoma del bambino nella sua totalità o quasi – in genere si ‘leggono’ solo le sequenze che codificano per le proteine, il cosiddetto esoma – può consentire di arrivare a una diagnosi che altrimenti sarebbe rimasta sconosciuta o di arrivarci più velocemente. Cosa che può salvare una vita”.
A volte, infatti, disporre di una diagnosi significa poter mettere in campo una terapia specifica, al posto di terapie sintomatiche magari inefficaci se non controproducenti. Un brillante esempio in questo senso lo ha descritto nel 2011 il gruppo di Elizabeth Worthey, del Centro di genetica molecolare e umana del Medical College di Milwaukee, a proposito di un bambino di 15 mesi con quella che sembrava una forma grave e anomala di malattia di Crohn, una malattia infiammatoria cronica intestinale. I medici sospettavano la presenza di un difetto genetico del sistema immunitario, ma non riuscivano a capire di cosa si trattasse. Solo con il sequenziamento dell’esoma sono arrivati a diagnosticare la carenza di un fattore con un ruolo centrale nella risposta infiammatoria, mai associato prima alla malattia di Crohn. In seguito alla scoperta il bambino è stato trattato con successo con un trapianto di cellule staminali emopoietiche (le progenitrici delle cellule del sangue).
Perché la diagnosi è importante
Non sempre le cose vanno così bene, ma avere una diagnosi è importante anche quando la terapia non c’è. Intanto perché dare un nome a una malattia può offrire un minimo di sollievo psicologico ai genitori, annichiliti anche dal non sapere di cosa soffre il loro bambino. “Ma anche perché talvolta può dare indicazioni su come evolverà la malattia nel tempo, oppure offrire informazioni utili alla coppia nel caso in cui volesse altri figli” aggiunge Lalatta. Ricordando in proposito uno degli ultimi casi arrivati alla sua attenzione, quello di una giovane coppia con tre bambini, due dei quali morti poco dopo la nascita per una malattia inizialmente sconosciuta.
“Il sequenziamento dell’esoma ha rivelato che entrambi i fratellini avevano una mutazione mai descritta prima in un gene associato a una malattia che si esprime in genere in forma più lieve e che invece in questo caso era letale”. L’équipe di Lalatta ha scoperto che entrambi i genitori erano portatori di questa mutazione: se lo vorranno, in caso di una nuova gravidanza potranno accedere a servizi di diagnosi prenatale, o addirittura pensare a un percorso di fecondazione in vitro con diagnosi preimpianto degli embrioni prodotti.
“Insomma – conclude Renieri – se di fronte a un neonato in condizioni critiche tutte le ipotesi diagnostiche sono già state esaurite o non c’è il tempo di mettere in atto il tradizionale processo di diagnosi passo dopo passo, il sequenziamento dell’esoma rappresenta un’ottima opportunità”.
Secondo un documento pubblicato nell’estate 2018 dal comitato etico del progetto americano NSIGHT, progetto che si occupa proprio di esplorare le implicazioni, le sfide e le opportunità del sequenziamento dei neonati in ambito pubblico, nel caso di questi piccolini il successo diagnostico di questo approccio arriva al 40-60%. Dati in linea con i primi, preliminari risultati che stanno emergendo a Bergamo dal progetto Rare (Rapid Analysis for Rapid carE), che punta a valutare l’utilità clinica e il rapporto tra costi ed efficacia del sequenziamento dell’esoma per la diagnosi urgente di malattie genetiche rare in bambini in condizioni critiche ricoverati in reparti di terapia intensiva neonatale e pediatrica.
“A oggi l’analisi è stata eseguita in 49 piccoli pazienti, con risultati incoraggianti” spiega Maria Iascone, referente del laboratorio di genetica medica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, uno dei primi in Italia a introdurre il sequenziamento di nuova generazione del genoma nella routine diagnostica. “Abbiamo ottenuto una diagnosi definitiva nel 50% dei casi in un tempo medio di nove giorni – mentre con l’iter tradizionale l’avremmo raggiunta solo nel 35% dei casi, con un tempo medio di quattro mesi – identificando malattie estremamente rare, forme atipiche di malattie note, o malattie che possono essere così eterogenee da richiedere anni per la diagnosi”.
E ancora: “Nel 20% dei casi con diagnosi è stato possibile mettere in atto un trattamento specifico, farmacologico o dietetico, mentre in altri casi dare un nome alla malattia ha comunque influenzato la gestione clinica dei bambini, per esempio dando indicazioni utili per decidere se sottoporre o meno un piccolo paziente a un trapianto di cuore”.
Il punto cruciale
La discussione più calda del momento, però, non riguarda tanto queste applicazioni quanto la possibilità di utilizzare il sequenziamento del genoma come test di screening per tutti i neonati. Chiunque abbia appena avuto un bambino lo sa: un test di screening che permette di identificare, prima della manifestazione dei sintomi, eventuali malattie ereditarie che potrebbero portare a danni importanti o addirittura a morte se non trattate in tempo esiste già. È lo screening neonatale esteso, un test biochimico eseguito su una goccia di sangue prelevata dal tallone del neonato due giorni dopo la nascita e che oggi in Italia riguarda una cinquantina di malattie metaboliche.
Ora, però, la prospettiva è di “illuminare” con un solo test tutto il genoma del bebè e tutte le informazioni che può contenere: non solo sul rischio di malattie a esordio infantile potenzialmente gravi e da trattare il prima possibile, ma anche sul rischio di malattie che potrebbero insorgere in età adulta (da alcune forme di cancro alla malattia di Alzheimer) oppure sul profilo farmacogenetico, che descrive la capacità dell’organismo di metabolizzare vari farmaci. Già, perché anche se ci comportiamo come se fossimo tutti uguali nella nostra capacità di metabolizzare le medicine che prendiamo, in realtà non lo siamo affatto.
Al momento non si tratterebbe di sostituire il “vecchio” test biochimico, ma più probabilmente di affiancarlo: “Anche se le tecniche di sequenziamento hanno fatto passi da gigante in termini di velocità, accuratezza e diminuzione dei costi operativi, per ora non possono essere utilizzate a tappeto, su intere popolazioni, per individuare difetti genetici che potrebbero dare origine ai primi sintomi già nel giro di ore” commenta Giancarlo La Marca, responsabile del laboratorio di screening neonatale dell’Ospedale Meyer di Firenze. “In questo senso le indagini biochimiche sono ancora le più efficaci anche perché danno meno problemi di interpretazione”.
Grandi prospettive, sfide complesse
Sulla carta l’idea di avere a disposizione un ricco pacchetto di informazioni genetiche può sembrare fantastico, ma le sfide dal punto di vista scientifico, etico e pure organizzativo sono enormi.
Il primo punto da considerare è che non sempre le informazioni che si ottengono dal DNA sono messe ‘nero su bianco’ in modo chiaro e inequivocabile: “Il che significa che bisogna mettere in conto un lavoro impressionante di interpretazione dei dati raccolti, al momento la sfida tecnica più consistente in questo ambito” sottolinea Lalatta. Non è detto che a una certa mutazione in un certo gene corrisponda per forza una malattia, e per di più con caratteristiche ben precise: la situazione può essere molto più sfumata, per cui in individui diversi le stesse mutazioni possono dare quadri clinici diversi. Per non parlare di varianti genetiche mai descritte prima, per le quali è molto difficile suggerire a priori che effetti potrebbero avere sulla salute di una persona.
Un conto è partire dai sintomi e ‘interrogare’ il genoma su quali potrebbero essere i difetti genetici collegati, mentre tutt’altra cosa è partire da varianti nella sequenza di DNA e cercare di indovinare se e quando, in una persona sana, daranno origine a una malattia. “È il motivo per cui i titoloni di giornali che presentano il sequenziamento del genoma come un modo per conoscere il destino (o il futuro) sono quanto mai fuorvianti”, commenta Lalatta. Certo, possono dare qualche informazione, ma possono anche aprire un abisso di incertezze, con un conseguente carico di ansia magari difficile da gestire. Soprattutto se non si è stati adeguatamente informati di tutti questi limiti (cosa che richiederebbe un’attenta consulenza genetica prima di eseguire il test e dopo la consegna dei risultati).
E se in ballo ci sono non individui adulti, che possono prendere decisioni in autonomia, ma bambini, la situazione è resa ancora più complicata da quello che molti esperti definiscono come il loro diritto alla conservazione di un futuro aperto. “Da un lato, il diritto a decidere se e quando richiedere informazioni sul rischio di malattie che potrebbero sviluppare da adulti (magari malattie prive di cura). Dall’altro, quello di evitare che le informazioni raccolte con lo screening condizionino la loro vita e le loro scelte future” precisa Francesco Lescai, professore di genetica umana e bioinformatica all’Università di Aarhus in Danimarca e membro del Foro per la ricerca e l’innovazione di Regione Lombardia, che ha da poco avviato uno studio di valutazione sulla possibilità di screening genomico per tutti i nuovi nati, a livello regionale.
Non è una questione da poco: come reagiranno i genitori di un neonato se il test rivelasse che il piccolo rischia di sviluppare un tumore infantile o, da grande, una malattia neurodegenerativa per la quale non c’è cura? C’è – avverte il documento del comitato etico di NSIGHT – la concreta possibilità di interferire con il processo di bonding, la formazione del legame unico e speciale che si instaura tra un bambino e i suoi genitori nelle prime settimane e nei primi mesi di vita, e di etichettare il piccolo come un “futuro paziente”, mettendolo a rischio di stigma da parte di membri della famiglia e operatori sanitari, o avviandolo a un percorso faticoso e stressante di visite ed esami magari inutili.
Un grosso problema di bioetica
Il tema è talmente delicato che anche nel caso del sequenziamento del DNA di neonati critici la comunità scientifica si sta interrogando su quali debbano essere le informazioni da passare ai genitori. Secondo quanto riferisce una nota pubblicata a marzo 2018 del Nuffield Council on Bioethics, organo indipendente di ricerca bioetica del Regno Unito, negli Stati Uniti una certa enfasi sul diritto dei genitori a sapere spinge i medici a fornire risultati non solo relativi alla condizione di cui soffre il bambino in quel momento, ma più in generale ad altre condizioni che potrebbe sviluppare durante l’infanzia (ma non in età adulta).
Nel Regno Unito e in Europa, invece, c’è un atteggiamento più centrato sul problema del momento, anche se si ammette che le cose potrebbero cambiare in futuro, considerato che da alcune indagini condotte con genitori di bambini critici emergerebbe il loro desiderio di saperne di più in generale.
Tutte queste considerazioni etiche valgono ovviamente anche per i test genetici diretti al consumatore, proposti da aziende private a singoli individui (e dunque si capisce bene l’invito della Società europea di genetica umana a non eseguirli se non per individui maggiorenni), ma nel caso di screening da portare avanti in ambito pubblico si pongono anche altre questioni altrettanto stringenti. Per esempio: “Come conservare i dati di ogni individuo in modo che ne sia garantita la privacy, e come consegnarglieli in modo che possano eventualmente essere riletti in futuro, alla luce di nuove conoscenze genetiche o di malattie che l’individuo dovesse sviluppare?” chiede Alessandra Renieri. Sottolineando che questi elementi impongono un approccio anche gestionale completamente nuovo al dato sanitario personale.
E ancora: come assicurare la corretta formazione di tutti i professionisti della salute sui risultati che possono emergere da questi test? Perché diciamocelo chiaramente: sapere quali sono le mie varianti dei geni che modulano il metabolismo dei farmaci serve a poco se poi il mio medico di base non sa come “leggere” queste informazioni, dandomi indicazioni personalizzate di conseguenza. E ancora: come assicurare un counseling serio e approfondito ai genitori dei bambini che dovessero accedere allo screening? Per non parlare della questione dei costi: non solo quelli relativi all’intervento in sé, ma anche quelli relativi alle sue possibili conseguenze.
Di nuovo: in un’ottica di sanità pubblica serve a poco mettere in piedi un sistema che permette di predire – con tutti i limiti che abbiamo visto – il rischio di malattia, se poi non ci sono i soldi per garantire adeguati programmi di prevenzione, o addirittura per assicurare le terapie necessarie a chi si scoprisse malato. O della questione delle possibili ricadute sociali, per esempio rispetto al modo di vedere la disabilità. È un altro nodo cruciale dal punto di vista etico, tanto che – ricorda il documento del Nuffield Council – c’è chi suggerisce di non contemplare la possibilità di screening genomici a livello di popolazione fino a quando non saranno affrontati e risolti la discriminazione, l’esclusione e lo stigma sperimentati dalle persone con disabilità.
Sul piatto, insomma, ci sono tantissimi elementi da prendere in considerazione per evitare che lo screening genomico dei neonati arrivi in un programma sanitario pubblico solo perché c’è la tecnologia per farlo, tanto che già nel 2015 la Società europea di genetica umana aveva stilato un elenco delle aree da approfondire per essere certi della reale utilità e fattibilità di questo approccio in ambito pubblico. Esattamente la strada lungo la quale si sta muovendo il comitato etico del progetto NSIGHT, che per ora esprime una visione piuttosto critica di questa possibilità, sottolineando che “l’idea dei benefici dello screening di popolazione del rischio genetico è ancora ipotetica”, e invitando a un approccio nuanced (“sfumato”) alla nascente tecnologia del sequenziamento del genoma. Un approccio “che sia in grado di contrastare la visione dell’informazione genetica come bene assoluto, alimentata sia da uno sfrenato ottimismo scientifico sia da interessi commerciali”.
In questo scenario sarò davvero interessante vedere i risultati nel neonato progetto del Foro innovazione di Regione Lombardia, che punta proprio a valutare implicazioni e ricadute dello screening genomico per neonati anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini, che saranno chiamati nella seconda metà di quest’anno a una consultazione sull’argomento. “Io credo – afferma Lescai, tra i membri del gruppo di lavoro – che questa tecnologia abbia grandi potenzialità di applicazione a livello di popolazione, ma che in un contesto di ricerca e innovazione responsabili, su questi temi non si possa prescindere da un ampio dibattito tra esperti e pubblico”.
Leggi anche: Il canale del parto tra evoluzione e assistenza al travaglio.
Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()