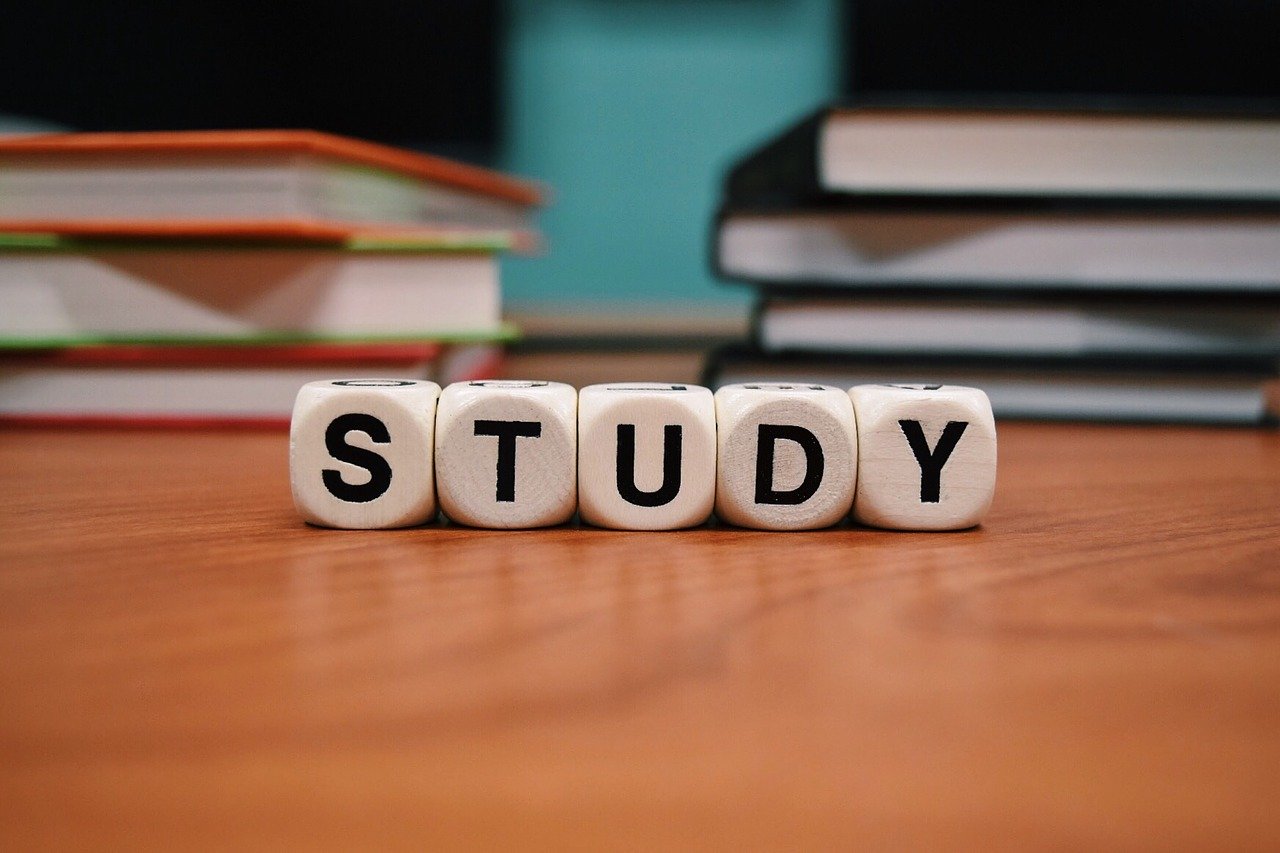Misurare un diritto
Intervista a Roberto Ricci, responsabile del settore della ricerca valutativa e parte del consiglio d’amministrazione dell'istituto INVALSI
A partire dal 2020, svolgere la prova INVALSI sarà un passaggio obbligatorio per l’ammissione alla maturità. A stabilirlo è una legge del 2017 che l’attuale governo ha deciso di non modificare. Come spesso accade, cambiamenti in ambito scolastico suscitano ampie discussioni. Noi vorremmo inserirci raccontando alcuni dei presupposti e dei meccanismi di funzionamento della prova. Per farlo, abbiamo intervistato Roberto Ricci, responsabile del settore della ricerca valutativa e parte del consiglio d’amministrazione dell’istituto.
Misurare un diritto
La prova INVALSI copre tre discipline: matematica, italiano e inglese, con l’obiettivo di misurare le competenze basilari di lettura, comprensione dei testi, capacità argomentativa e problem solving che il Miur ritiene fondamentale fornire ai cittadini attraverso il proprio sistema educativo.
L’istruzione, infatti, è un diritto costituzionalmente riconosciuto, che non si risolve nella mera possibilità di frequentare una scuola, ma si concretizza nel tipo di formazione ricevuta.
A monitorare la qualità complessiva dell’offerta formativa statale c’è l’istituto INVALSI, demandato di valutare l’effettivo apprendimento delle capacità che, nelle Indicazioni Nazionali e nelle Linee Guida del ministero, costituiscono obiettivi centrali del sistema scolastico: “ritrovare informazioni date esplicitamente nel testo; ricostruire il significato di parti del testo o del testo nel suo insieme comprendendone l’organizzazione logica e le connessioni interne; riflettere sul contenuto e sulla forma del testo e valutarli” (Rapporto Invalsi 2019, p. 40). E ancora: la capacità di affrontare quesiti che partono “da problemi del mondo reale e verificano le conoscenze disciplinari più̀ importanti, la capacità di risolvere problemi, ma anche quella di argomentare, cioè̀ di saper riflettere sul perché delle proprie scelte” (p. 60).
Come ricorda il dottor Ricci, «non tutte le competenze possono essere misurate attraverso una prova standardizzata. Per esempio, non è possibile – e forse nemmeno opportuno – cercare di valutare con prove di questo tipo quelle della produzione orale o scritta».
La prova INVALSI, somministrata ogni anno a un campione molto ampio di studenti (circa 40.000 per grado d’istruzione), non riguarda pertanto tutte le abilità necessarie a muoversi nel mondo in modo autonomo e consapevole, ma solo quelle effettivamente valutabili attraverso esercizi come domande a risposta multipla, corrispondenze, esercizi cui gli studenti riempiono gli spazi lasciati vuoti in una frase, esercizi di riordino degli elementi sulla base di criteri prestabiliti, domande aperte con una sola risposta corretta e altre più impegnative, con più risposte accettabili.
Prova, non test
Secondo Ricci, questa varietà nelle tipologie di quesiti rappresenta un primo motivo per definire l’INVALSI una prova e non un test. Ma non è l’unico, né il più importante. «Un test ha come obiettivo quello di valutare se qualcuno è sopra o sotto una determinata soglia di adeguatezza. Perciò, un test si passa o non si passa. Una prova, invece, ha come obiettivo fornire un’informazione su una scala di competenze, ed è per questo che risulta molto più articolata».
La valutazione è uno strumento utile agli studenti per comprendere quali aspetti del proprio percorso formativo è opportuno rafforzare. Ma è anche – e soprattutto – una fotografia del sistema educativo del Paese, delle sue carenze e delle disuguaglianze, della distanza che lo separa dal rendere effettivo il diritto sancito in Costituzione. Infatti, come spiega il Rapporto pubblicato ogni anno dall’istituto, “la qualità di un sistema d’istruzione si giudica, oltre che dalla sua efficacia,cioè dai risultati raggiunti dai suoi studenti, anche dalla sua maggiore o minore equità, intesa in generale come la capacità di ridurre le disuguaglianze di fronte all’istruzione” (p. 19).
Nascita di una prova, non siamo gli unici
Il terreno esperienziale e metodologico in cui si radica l’INVALSI è quello della IEA, l’International Association for the Evaluation of Educational Achievement, nata in Germania nel 1958 e dedita allo studio dell’efficacia dei sistemi educativi e alla valutazione dell’apprendimento degli studenti.
Anche l’Italia fa parte dei paesi al centro della rete di ricerca e di osservazione della IEA. «Noi facciamo riferimento a questi quadri, declinandoli nel contesto nazionale attraverso la collaborazione dei docenti italiani. Gli autori degli esercizi sono infatti al 95% insegnanti con anni di esperienza alle spalle, selezionati attraverso avvisi pubblici». Ogni autore invia le sue proposte, poi esaminate da un team di lavoro complessivo che affianca ai docenti degli esperti esterni.
«Da questa scrematura iniziale si ricava una prima bozza della prova, che viene pretestata su un gruppo selezionato di studenti. Sulla base dei risultati, vengono scartate quelle domande che risultano essere poco efficaci da un punto di vista tecnico, misuratorio. Quelle che passano la selezione vengono invece modificate e ritestate». La prova finale è, di fatto, composta dagli esercizi validati attraverso questa lunga sequenza di verifiche che, generalmente, richiede due/tre anni di lavoro.
Stabilire correlazioni
L’analisi dei dati consente di mettere a confronto i risultati conseguiti in macro-aree e regioni differenti, ma anche di visualizzare il ruolo che scuola, classe e attitudine dei singoli individui ricoprono nell’esito della prova. L’attenzione degli esperti si concentra su temi di particolare rilevanza sociale, come differenze di genere o di apprendimento tra studenti italiani e stranieri. È in questo senso che, per Ricci, il Rapporto garantisce uno spaccato generale del sistema scolastico italiano.
Tra gli elementi presi in esame c’è anche il peso giocato dal contesto familiare. Per stimare l’importanza delle relazioni familiari si utilizza l’analisi statistica, nello specifico quella multivariata. Per esempio, immaginiamo di mettere a confronto famiglie diverse, in cui i genitori possiedono titoli di studio e un backgroundsocioeconomico equipollenti, ma seguono in modo differenziato il percorso didattico dei figli.
«Questo è un tipico contesto di analisi statistica. Avere genitori con un determinato titolo di studio e un determinato background ha, mediamente, e su grandissimi numeri, un determinato effetto, che possiamo chiamare effetto medio. Si tratta di una stima che ci aspetteremo essere tendenzialmente valida per tutti coloro che presentano quelle specifiche caratteristiche sociali ed economiche. Su questo atteso si inseriscono le singole attitudini o il rapporto con i propri genitori che, invece, rappresentano un effetto singolo, il quale si riverbera nel risultato, rendendolo maggiore o minore rispetto al valore atteso per quel determinato background».
Un termometro
A questo punto, un modo utile d’intendere la prova INVALSI potrebbe essere paragonarla a un termometro. Non rappresenta una diagnosi completa, non fornisce un quadro clinico preciso per ogni paziente. È, però, un importante monitoraggio del sistema corpo nel suo complesso e una prima fonte di informazioni utili.
«A seconda del proprio profilo giuridico, è possibile accedere ai dati con livelli di dettaglio differenti. La scuola, per esempio, vede integralmente i propri risultati. Man mano che ci si allontana da essa, tanto più forte diviene la limitazione d’accesso. In ogni caso, un anno dopo la prova, i dati vengono messi in rete, a disposizione di tutti. Naturalmente,a quel puntonon è proprio possibile risalire alla singola scuola o all’individuo, come vogliono le norme che disciplinano il trattamento dei dati».
Il Rapporto allora si trasforma nel punto di partenza della riflessione sul sistema scolastico, non nel suo arrivo. «Apprezzo il fatto che i dati rappresentino una base da cui iniziare una riflessione. Preferirei non venissero trasformati in una graduatoria calcistica. Questo perché – oltre che sbagliato – sarebbe riduttivo e improduttivo».
Il senso della prova
A chi teme che l’obbligatorietà della prova induca scuole e docenti a concentrare l’attenzione nell’addestramento al test, sottraendo tempo ai piani didattici ma, soprattutto, trasformando l’INVALSI in una sorta di quiz a cui prendere a tutti i costi buoni voti, il dottor Ricci risponde con poche parole.
«Posto che qualsiasi domanda presuppone una capacità nell’essere compresa ed affrontata, va evitato che la preparazione alla prova si trasformi in mera acquisizione di tecnicalità. Di per sé, però, insegnare agli studenti a saper rispondere a domande strutturate, significa semplicemente fornire loro una competenza in più. Non solo: se “addestrarsi” alla prova significa imparare a smontare un testo, a vederne i nodi informativi ed esercitare la tecnica della comprensione, allora ha un significato molto vicino a quello di educazione. Che poi le scuole possano usare i propri risultati come strumento di vanto è possibile. Ma non lo fanno già con i propri voti o con gli esami di maturità? Va bene essere cauti, ma è importante ricordare che alle scuole non servono certamente i dati Invalsi per farsi pubblicità. Preferisco pensare che i dati trasparenti dell’INVALSI rappresentino uno strumento di giudizio in più per le famiglie».
Leggi anche: OCSE PISA 2018, oltre i numeri
Articolo pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()
Immagine: Pixabay