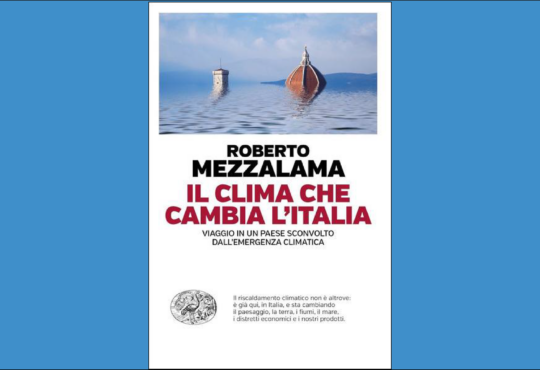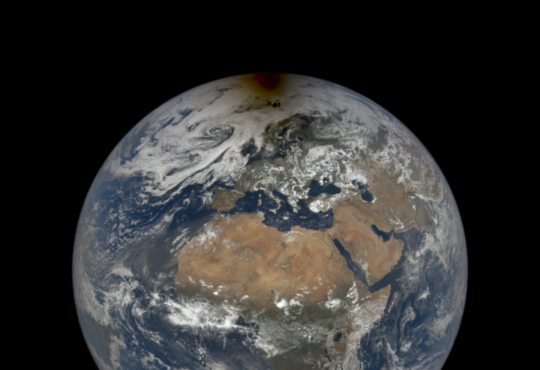Le notizie più importanti del 2020 per il clima e l’ambiente
Il coronavirus ha oscurato la crisi ecologica, ma quest’anno sono successe molte cose importanti per il futuro del pianeta (alcune anche positive)

Sebbene la pandemia di COVID-19 abbia inevitabilmente distolto l’attenzione dalla crisi climatica e ambientale, è stato un anno segnato dagli eventi estremi, con incendi devastanti in diverse regioni della Terra, temperature globali da primato e un ingorgo di uragani nell’Atlantico. Il lockdown che ha coinvolto mezzo mondo ha causato un tracollo senza precedenti nelle emissioni di gas serra, ma il 2020 si appresta ugualmente a diventare il secondo anno più caldo mai registrato, in un testa a testa con il 2016. Eppure non sono mancate le buone notizie: molti governi si sono impegnati a ridurre più in fretta le emissioni di gas serra e i fondi stanziati per stimolare la ripresa economica offrono un’occasione straordinaria per accelerare la transizione energetica. Nel bene e nel male, quel che è successo nel 2020 potrebbe lasciare un’impronta profonda: ecco dunque le notizie più importanti che potreste esservi persi in questi mesi.
Un anno di eventi estremi
Il 2020 è cominciato davvero male con gli spaventosi incendi che in Australia hanno ucciso centinaia di persone, distrutto migliaia di abitazioni e devastato interi ecosistemi. I primi roghi, favoriti dalla siccità, erano divampati nel luglio del 2019 e hanno raggiunto il culmine a gennaio. Nel complesso, sono bruciati circa 100mila chilometri quadrati di territorio (una superficie pari a un terzo dell’Italia). Per il WWF si è trattato del peggior disastro che abbia colpito la fauna selvatica nella storia moderna: a farne le spese sono stati tre miliardi di animali, tra cui 143 milioni di mammiferi, 2,5 miliardi di rettili e 180 milioni di uccelli.
Incendi devastanti hanno flagellato anche la tundra siberiana, le regioni occidentali degli Stati Uniti e le zone umide tropicali del Sudamerica. Secondo l’Istituto nazionale di ricerca spaziale brasiliano (INPE), tra agosto 2019 e luglio 2020 sono andati perduti oltre 11mila chilometri quadrati di foresta amazzonica, con un incremento del 9,5% rispetto ai dodici mesi precedenti. Nella regione del Pantanal, un quarto della zona umida più estesa al mondo è stata consumata dalle fiamme. La cause sono quelle di sempre, facilitate dalla carenza di controlli: deforestazione e incendi per fare spazio alle miniere illegali, agli allevamenti di bovini e alle coltivazioni di soia per l’alimentazione animale.
Negli Stati Uniti la violenza degli incendi è invece esasperata dal riscaldamento globale: il manto nevoso montano si riduce, le estati sono più calde e aride, gli alberi abbattuti dalla siccità e i pascoli secchi forniscono combustibile in abbondanza, le tempeste di fulmini innescano i roghi, mentre il vento e le ondate di calore rendono sempre più difficile domare le fiamme e trovare scampo. Come se non bastasse, quest’estate in California gli incendi e la pandemia si sono aggravati a vicenda. La crisi sanitaria ha tolto risorse ai soccorritori e contribuito ai blackout perché molte persone, chiuse in casa per le restrizioni, hanno alzato i condizionatori per sopportare il caldo. Chi invece ha dovuto abbandonare la propria abitazione, si è trovato più esposto al contagio. Senza contare l’aria satura del fumo degli incendi, un pericolo già di per sé, ma secondo alcuni studi anche un ulteriore fattore di rischio per la COVID-19, perché l’inquinamento renderebbe più vulnerabili i polmoni al coronavirus.
Mentre la California era alle prese con gli incendi, la costa orientale ha invece dovuto affrontare una stagione eccezionale di uragani, cominciata in anticipo a maggio con le tempeste tropicali Arthur e Bertha, e terminata in novembre con gli uragani Eta e Iota, che si sono abbattuti sull’America Centrale uccidendo oltre 270 persone e causando più di 9 miliardi di danni. Nell’oceano Atlantico, nel Mar dei Caraibi e nel Golfo del Messico è stato un susseguirsi di tempeste: oltre 30 abbastanza potenti da meritare un nome, quasi il triplo della media annuale. Cosicché a un certo punto la lista dei nomi usati per indicare gli uragani si è esaurita e si è dovuto ricorrere alle lettere dell’alfabeto greco. Per ben quattro volte si sono formate persino due tempeste simultanee. Gli esperti hanno puntato il dito sul riscaldamento dell’oceano e sui forti monsoni provenienti dall’Africa occidentale, che facilitano la formazione delle tempeste tropicali.
Più a nord, in settembre, i ghiacci artici hanno fatto registrare la seconda minore estensione in 42 anni di misurazioni satellitari, mentre all’altro capo del mondo, in Antartide, gli scienziati hanno constatato con sgomento che persino il continente di ghiaccio si sta risvegliando, con alcuni immensi ghiacciai destabilizzati dalle acque più calde. E se pensate che manchino solo le cavallette, be’, l’annus horribilis che volge al termine è stato funestato anche dalla peggiore invasione di locuste che si ricordi da almeno 70 anni a questa parte.

Il crollo delle emissioni
Con mezzo mondo in lockdown nel tentativo di arginare la pandemia, nel 2020 si registrerà un calo del 7% delle emissioni globali di gas serra. Si tratta di un tracollo senza uguali in epoca moderna, stimato in circa 2,5 miliardi di tonnellate di gas serra in meno, che però non avrà un effetto apprezzabile né sui livelli di CO2 in atmosfera, né sulla temperatura media del pianeta. Anzi, secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, il 2020 è in gara con il 2016 per il titolo di anno più caldo mai registrato, e per di più senza il contributo di El Niño, il periodico riscaldamento della superficie dell’oceano Pacifico che aveva favorito il record di quattro anni fa. Il motivo è che la CO2 resta in atmosfera per secoli e qualche mese di minori emissioni non possono certo compensare l’accumulo avvenuto negli ultimi due secoli.
La crisi ecologica, purtroppo, non ha conosciuto pause: il pianeta continua a scaldarsi, gli oceani a diventare più acidi, le specie a scomparire al ritmo di un’estinzione di massa, mentre sempre più persone sperimentano la minaccia esistenziale degli eventi estremi. Dopo la firma degli accordi di Parigi, dal 2015 a oggi abbiamo vissuto i sei anni più caldi da quando sono stati inventati i termometri. Mentre secondo il Global Biodiversity Outlook, un rapporto pubblicato dalla Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, nessuno degli obiettivi stabiliti dieci anni fa per frenare la perdita di biodiversità è stato raggiunto. Anzi, un’analisi pubblicata a giugno indica che la scomparsa delle specie sta accelerando. Molti progetti di conservazione nei Paesi tropicali, che spesso dipendono dall’ecoturismo per finanziarsi, sono stati sospesi per via delle restrizioni sugli spostamenti e per la chiusura dei confini nazionali. Nel frattempo, ondate di calore, incendi, cicloni e alluvioni diventano sempre più frequenti. Quest’anno oltre 50 milioni di persone sono state afflitte sia dalla pandemia sia dalle calamità correlate alla crisi climatica.
Gli esperti ritengono inoltre che il calo delle emissioni di gas serra sia soltanto temporaneo e verrà riassorbito in fretta con l’auspicata ripresa economica, come del resto era già successo dopo la crisi finanziaria del 2008. I consumi energetici globali, infatti, continuano a dipendere per oltre l’80% dai combustibili fossili, cosicché l’unico modo per ridurre le emissioni in modo duraturo è favorire una rapida transizione verso le rinnovabili. Già l’anno scorso, prima della pandemia, gli esperti del Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) avevano calcolato che, per riuscire a contenere il riscaldamento del pianeta entro 1,5°C, avremmo dovuto ridurre le emissioni globali del 7,6% ogni anno. Quel che è accaduto per via dal coronavirus, d’ora in poi dovrà avvenire per merito delle politiche climatiche. In caso contrario, oltrepasseremo la soglia di sicurezza di 1,5°C prima ancora del 2030, lasciando milioni di persone in balia del riscaldamento globale, in un crescendo di ondate di calore, siccità, inondazioni e povertà.
I negoziati sul clima
La pandemia ha costretto anche a rinviare di un anno la 26esima Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici (Cop26), che si sarebbe dovuta svolgere in novembre a Glasgow (Scozia). Si è perso così altro tempo prezioso per rendere finalmente operativo l’accordo di Parigi. Negli ultimi mesi, tuttavia, oltre 70 Paesi hanno ugualmente deciso di rafforzare gli impegni volontari per diminuire le emissioni. A fare da apripista è stata la Cina, che oggi è il principale produttore di gas serra con oltre un quarto delle emissioni globali di CO2. L’annuncio è arrivato a settembre per bocca del presidente cinese Xi Jinping: il governo di Pechino s’impegna a raggiungere il picco delle emissioni entro il 2030 e la neutralità climatica entro il 2060. L’11 dicembre anche l’Unione Europea ha rivisto al rialzo gli obiettivi di riduzione dei gas serra, trovando un accordo per tagliare le emissioni del 55% entro il 2030.
Secondo l’ultimo rapporto dell’UNEP, tuttavia, ancora non basta: persino se gli impegni già assunti da oltre 120 governi per ridurre le emissioni fossero rispettati, la temperatura media globale rischierebbe ugualmente di salire di oltre 3°C entro fine secolo, con conseguenze catastrofiche per molti ecosistemi del pianeta da cui dipende la nostra stessa sopravvivenza. Gli esperti dell’UNEP stimano che gli sforzi attuali debbano essere almeno triplicati per rispettare l’accordo di Parigi e mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 2°C. Senza contare che finora agli annunci non sempre sono seguiti risultati concreti.
In occasione del quinto anniversario dell’accordo di Parigi, l’attivista svedese Greta Thunberg ha detto senza giri di parole che «stiamo ancora accelerando nella direzione sbagliata». Del resto, come indica anche l’UNEP, se davvero vogliamo restare entro il limite di 2°C, allora la produzione di gas, petrolio e carbone dovrebbe diminuire del 2% all’anno, mentre oggi, al contrario, nel mondo si pianifica un aumento medio annuale del 2%. Secondo Thunberg, dovremmo smetterla di parlare di obiettivi al 2030 o al 2050: «Si fissano obiettivi ipotetici a lungo termine e si fanno grandi discorsi, ma quando è il momento di attuare le misure immediate di cui avremmo bisogno, siamo ancora di fronte a uno stato di completa negazione».
In novembre la sconfitta di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi è stata accolta con un sospiro di sollievo da chiunque abbia a cuore l’ambiente. Durante la campagna elettorale il nuovo presidente eletto Joe Biden aveva inserito la crisi climatica, definita «la minaccia esistenziale dei nostri tempi», tra le priorità della sua amministrazione. Biden ha promesso di chiudere tutte le centrali a carbone statunitensi entro il 2035 e di azzerare le emissioni nette di gas serra entro il 2050. Ha infine annunciato che dal primo giorno del suo mandato lavorerà affinché gli Stati Uniti possano rientrare dell’accordo di Parigi, rimediando così all’uscita imposta da Trump, diventata ufficiale lo scorso 5 novembre. La speranza è che gli eventi degli ultimi mesi possano rilanciare la cooperazione internazionale nella lotta ai cambiamenti climatici.
Il picco della domanda di greggio
Nella prima metà del 2020 lo stallo dell’economia globale ha fatto crollare la domanda di petrolio, che potrebbe non tornare più ai livelli precedenti alla pandemia, come a settembre ha ammesso anche il colosso energetico BP. La fuga di investitori dalle fonti fossili ha spinto diversi analisti a ipotizzare che potremmo avere già raggiunto il picco della domanda di greggio. Se così fosse, l’epoca dei combustibili fossili sarebbe ormai destinata al declino.
Le ragioni sono molteplici. Da una parte le pressioni ambientaliste hanno allontanato molti finanziatori dalle fonti fossili, ormai percepite come investimenti poco etici, al punto che quando Trump aveva annunciato di voler autorizzare la ricerca di gas e petrolio nell’Arctic National Wildlife Refuge, un’area naturale protetta nel nordest dell’Alaska, nessuna banca si era fatta avanti. Dall’altro la crescente competitività dell’eolico e del fotovoltaico ha spostato gli investimenti sulle fonti rinnovabili, che nel 2020 raggiungeranno il 90% della nuova capacità energetica installata, contro il 50% del 2015. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha definito il solare la fonte più economica di elettricità della storia, prevedendo che a breve le rinnovabili supereranno il carbone nella produzione di elettricità.
I fondi stanziati dai governi per stimolare la ripresa economica costituiscono inoltre un’occasione storica per favorire la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile. Sul piatto ci sono centinaia di miliardi di dollari destinati a finanziare progetti a basso impatto ambientale. Secondo l’UNEP, con i giusti interventi a sostegno di una ripresa green, avremo la possibilità di limitare il riscaldamento globale tra 1,5°C e 2°C, in linea con gli accordi di Parigi. Finora, però, non tutto è andato per il verso giusto: alcune analisi hanno mostrato come in diversi Paesi le risorse siano finite anche a settori molto inquinanti, come l’industria pesante, l’agrobusiness e l’estrazione di combustibili fossili.
Do certo le compagnie petrolifere non resteranno a guardare e oggi puntano sulla produzione di plastica per compensare le perdite che potrebbero derivare dalle politiche climatiche e dalla diffusione delle auto elettriche. Approfittando della pandemia e della domanda di mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione, l’industria petrolchimica non ha esitato a fare pressione sui governi affinché plastic tax e restrizioni sul monouso fossero ritirate o almeno prorogate. Nel frattempo, diversi studi hanno mostrato che l’inquinamento ambientale dei rifiuti di plastica è assai peggio del previsto. Secondo uno studio pubblicato in ottobre, nei fondali oceanici sono già finiti almeno 14 milioni di tonnellate di microplastiche, i pericolosi frammenti di diametro inferiore a 5 millimetri ormai entrati nella catena alimentare marina; una quantità 25 volte superiore a quello che si pensava finora.
La pandemia e l’emergenza ambientale
La pandemia di COVID-19 ha mostrato una volta di più che esiste un profondo legame tra la salute umana e quella del pianeta. La maggior frequenza delle malattie infettive emergenti, che per il 75% hanno un’origine zoonotica, è infatti correlata alle attività antropiche: deforestazione, allevamenti intensivi, traffico di fauna selvatica e cambiamenti climatici aumentano le occasioni di contatto con animali selvatici e domestici che possono trasmettere nuovi agenti patogeni dal potenziale pandemico. Ecco perché proteggere l’ambiente significa proteggere anche la salute globale.
Sono del resto bastate poche settimane di lockdown per riscoprire le nostre città senza più traffico né smog. Uno degli effetti più evidenti delle restrizioni sugli spostamenti è stato il miglioramento della qualità dell’aria, che ha evitato migliaia di morti nelle aree urbane più inquinate. L’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) ha misurato una drastica riduzione dei livelli di diossido di azoto (NO2), un pericoloso inquinante atmosferico emesso per lo più dai trasporti su strada. La concentrazione di particolato PM10, prodotto anche da altre fonti meno colpite dalle restrizioni, come gli impianti di riscaldamento, l’agricoltura e l’industria, è invece calata in misura minore.
Sebbene si tratti di due crisi molto diverse, la pandemia di COVID-19 e il riscaldamento globale hanno mostrato la vulnerabilità delle nostre società alle minacce globali, l’assoluta necessità di agire in modo preventivo e l’importanza della cooperazione internazionale. Quel che è accaduto in questi mesi drammatici dimostra però che di fronte a un’emergenza siamo capaci di mobilitare risorse impensabili fino al giorno prima. La speranza è che quest’anno terribile possa almeno aprirci gli occhi anche sui rischi della crisi ecologica che incombe su di noi.
Leggi anche: 2020, anno di cambiamenti per la fauna selvatica
Articolo pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()
Immagine: Pixabay