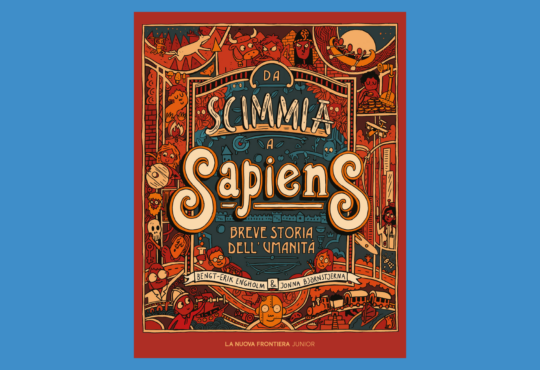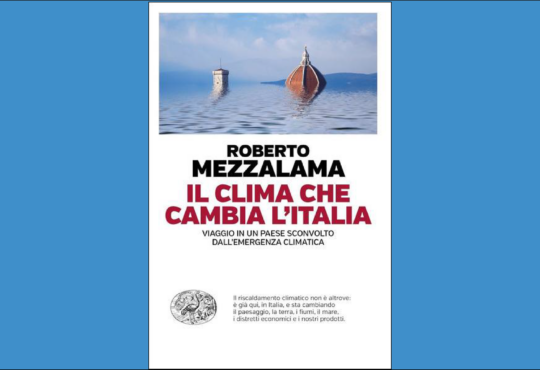LIBRI – Se abbiamo la possibilità di prevedere la trasmissione di una malattia genetica, è lecito non farlo? Questa è probabilmente la domanda cruciale all’interno del dibattito sui test genetici per la prevenzione di alcune delle migliaia di malattie genetiche esistenti. Oggi infatti le possibilità sarebbero molte, per esempio uno screening genomico su tutta la popolazione per individuare i portatori di centinaia di malattie, alcune molto gravi e diffuse, ma alla prova dei fatti si tratta di conoscenze che non stiamo sfruttando come la scienza ci permetterebbe.
 Il dibattito è infatti fervente e non è semplice fissare un punto fermo, anche perché, sottolinea Baroukh Assael nel suo prezioso libro Il gene del diavolo (Bollati Boringhieri 2016), “la prevenzione delle malattie genetiche pone il problema della vita. Lo spettro che si aggira intorno a essa è l’eugenetica”. Parlare di approccio genetico infatti non significa curare una malattia ereditaria, ma ridurre la sua incidenza nelle generazioni successive. Significa insomma parlare di procreazione, di inizio vita.
Il dibattito è infatti fervente e non è semplice fissare un punto fermo, anche perché, sottolinea Baroukh Assael nel suo prezioso libro Il gene del diavolo (Bollati Boringhieri 2016), “la prevenzione delle malattie genetiche pone il problema della vita. Lo spettro che si aggira intorno a essa è l’eugenetica”. Parlare di approccio genetico infatti non significa curare una malattia ereditaria, ma ridurre la sua incidenza nelle generazioni successive. Significa insomma parlare di procreazione, di inizio vita.
Il risultato è che – nonostante oggi possediamo le conoscenze per controllare la diffusione di molte malattie genetiche, e nonostante gli ottimi risultati ottenuti nel caso della talassemia, praticamente scomparsa in Italia grazie proprio ai test genetici – “sembra vi sia una forte reticenza a condividere questa conoscenza”.
La prospettiva di questo libro è quella di un medico, pediatra, fra i maggiori esperti italiani di fibrosi cistica, già direttore del centro per la fibrosi cistica di Verona. Abbiamo rivolto qualche domanda al professor Assael per capire meglio quali sono i termini della questione.
Qual è secondo lei il motivo di questa reticenza nell’uso dei test per la prevenzione delle malattie genetiche?
Quello che dobbiamo capire, che le istituzioni devono capire, è che si tratta di una questione prima di tutto culturale. Al di là di strategie pianificate da parte degli enti sanitari, è la risposta della singola comunità a fare la differenza. In questo ambito i test genetici devono essere proposti, non certo resi obbligatori per la popolazione. Il punto cruciale è l’adesione delle persone, che abbiamo notato essere molto differente da paese a paese, da regione a regione. Questo è risultato evidente per esempio nel caso della fibrosi cistica di cui io mi occupo. Si pensava che senza rendere il test obbligatorio sarebbero stati in pochi a presentarsi spontaneamente, e invece non è stato affatto così: sempre più persone si sottopongono volontariamente al test, e in certe zone, come il Veneto per esempio, molto più che in altre. La mia conclusione è che si tratta di una scelta ancora individuale, e su quel piano va affrontata. Il punto è che tutte queste scelte politiche, per quanto importanti, si scontrano ancora contro il muro culturale, religioso, familiare, e per questo in ogni contesto ci saranno risposte diverse.
Rimane comunque il fatto che una qualche manovra coesa in termini di salute pubblica deve essere fatta. Lei stesso nel libro ricorda quello che è stato fatto a Cipro.
Certamente, ma per me non esiste una risposta unica che possa valere per tutti. Il punto è che quando si parla di test genetici si entra nell’ambito della discussione sulla procreazione, che è profondamente influenzata da fattori culturali, in modo poco prevedibile. Pensiamo per un momento alla struttura della famiglia. Ci sono culture dove il matrimonio fra cugini è comunemente accettato, e quindi la gente resisterà sempre al test, anche se vi è il rischio di far nascere più bambini malati.
Nel caso dei vaccini però una forma di intervento dello Stato c’è. In che cosa reputa differente la questione dei test genetici?
La differenza è profonda. Il caso dei vaccini è diverso perché siamo nel campo delle malattie infettive, dove sussiste un pericolo per la sanità pubblica, e quindi lo Stato non solo può ma deve intervenire. Lo fa sin dai tempi della lebbra e del colera, quando non esisteva il concetto di vaccino e l’unica arma era isolare i malati e far sì che non contagiassero altri – pensiamo per esempio al Lazzaretto a Venezia. Nei casi delle malattie infettive il compito del governo è garantire il diritto della collettività a difendersi. Diverso è invece pensare di rendere obbligatorio un test quando non c’è un vero pericolo per la collettività, se non il problema dei costi per la gestione dei malati. In questo caso il compito del governo è garantire la libertà individuale.
È evidente comunque che fatta salva la libertà dell’individuo, la direzione verso cui dobbiamo andare come comunità globale è quella di debellare il maggior numero di malattie genetiche possibili decennio dopo decennio. Qual è quindi secondo lei la soluzione migliore per attuare questa riduzione?
L’unica vera politica sensata per me è rendere gratuiti e facilmente accessibili per tutti questi test, unitamente a un’informazione capillare. Far sì che chiunque sia consapevole di quali possano essere le conseguenze, sia che decida di sottoporsi ai test sia che decida di non farlo. Sperare in una copertura assoluta e in un convincimento globale non è realistico. Oggi la genomica è antropogenomica, il che significa che le risposte a un’offerta dipendono in misura molto maggiore da aspetti antropologici rispetto alle scelte sanitarie. In questo senso la comunicazione è fondamentale per diffondere l’informazione sull’esistenza dei test, sulla loro validità e sui benefici che possiamo trarne in termini di salute pubblica. Tra i non addetti ai lavori, poche persone oggi sanno che la talassemia, che era – ricordiamo – una malattia mortale endemica anche nel nostro Paese, è praticamente scomparsa negli anni Ottanta grazie ai centri per la microcitemia.
La società deve cominciare a parlarne di questi argomenti, è questa la soluzione. Si parla tanto di fine vita e poco di inizio vita: parlare di inizio vita non significa solo aborto. I gruppi possono organizzarsi, ma alla fine è il singolo a dover scegliere.
Leggi anche: CRISPR: editing del genoma umano, a che punto siamo?
Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()