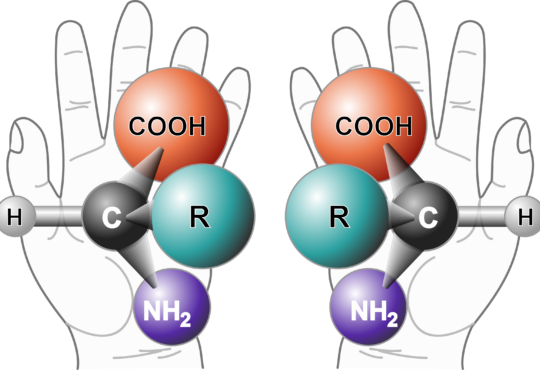Acrilammide, GE, furano: le cose da sapere
Cresce l'interesse dei consumatori per il cibo, non solo dal punto di vista nutrizionale ma anche della sicurezza degli alimenti. Ecco alcune delle sostanze più famose finite sotto la lente d'ingrandimento negli ultimi anni.

APPROFONDIMENTO – Mentre in Italia finiamo di digerire EXPO 2015, la crescente attenzione verso il cibo e i temi che vi ruotano intorno è lo specchio di quanto succede nella maggior parte dei Paesi sviluppati. Il rapporto Google Food Trends, che analizza le domande poste al motore di ricerca, ci aiuta a leggere il fenomeno: il lunedì moltissimi americani cercano informazioni sulla curcuma e su come usarla, mentre nei fine settimana del 2016 tra le grandi star c’erano i rigatoni. Le ricerche su how to ripen an avocado, come far maturare un avocado, sono cresciute del 54% (essere “foodie” non sempre vuol dire pensare alla sostenibilità) mentre sono aumentate del 105% le persone che hanno cercato i benefici di cannella e miele; del 390% quelle che si interrogavano sul latte di mandorla.
Un altro rapporto, Chemicals in food 2016 dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) guarda un altro aspetto che riscuote sempre più interesse: la chimica degli alimenti. Sull’onda di dibattiti come quello riguardo all’olio di palma (qui per sapere di più sull’aspetto economico, qui per quello ambientale) è facile per i consumatori farsi prendere dalla preoccupazione e rivedere le proprie abitudini alimentari. Di recente abbiamo parlato estensivamente del bisfenolo A nei recipienti per alimenti, prima ancora del bromato di potassio nel pane; oggi vediamo altre tre “superstar” della chimica alimentare.
Acrilammide
L’acrilammide è un composto chimico annoverato dalla IARC (International Agency for the Research on Cancer) nel gruppo 2A, ovvero probabilmente cancerogeno, insieme ad altri 80 agenti.
Nel 2002 si è scoperto che l’acrilammide si forma anche negli alimenti amidacei come pane, patate e biscotti, quando vengono cotti in forno, alla griglia, fritti o arrostiti a temperature elevate (120-150°). Non riguarda solo la lavorazione a livello industriale ma anche quella casalinga: per esempio quando abbrustoliamo il pane in forno per farne bruschette, ma anche quando friggiamo le patatine fritte nell’olio bollente. La combinazione tra aminoacidi e zuccheri, naturalmente presenti in questi cibi, origina nuove sostanze chimiche e conferisce ai cibi un sapore diverso: quando il pane si imbrunisce, per esempio, è in corso la reazione di Maillard e uno dei risultati è proprio la produzione di acrilammide.
Trattandosi di un processo naturale è virtualmente impossibile ridurre a zero l’acrilammide quando cuciniamo cibi amidacei ad alte temperature; tuttavia, mentre gli scienziati cercano varietà di patate che ne producano di meno, esistono alcuni accorgimenti che possiamo mettere in atto per ridurla (oltre a fare una dieta varia per cibi e modalità di cottura). Alcune di queste buone pratiche sono già diffuse: è consigliabile non tenere in frigo le patate, dove possono aumentare i livelli di zuccheri – dunque di acrilammide in fase di cottura o frittura – ma conservarle al riparo da fonti di calore e di luce. Una volta infornate, andrebbero cotte fino a farle dorare ma senza aspettare che si formi la “crosticina” bruna che segnala proprio la presenza di acrilammide. Idem per crocchette di patate, pane fresco o in cassetta e cibi fritti, dove è sempre la colorazione a venirci in aiuto: meglio fermarsi quando sono giallo-dorati ed evitare l’imbrunimento.
Gli studi su modelli animali hanno suggerito che l’acrilammide negli alimenti e la glicidammide, il metabolita che origina dal metabolismo dell’acrilammide dopo l’assorbimento nel tratto gastrointestinale, possono danneggiare il DNA e causare il cancro. Effetti che non sono stati confermati sugli esseri umani, dove le ricerche danno risultati discordanti; nei lavoratori esposti al composto per motivi professionali c’è un maggio rischio di disturbi nel sistema nervoso, mentre altre indagini riferiscono una relazione inversa tra esposizione ad acrilammide e peso alla nascita e altri marcatori di crescita fetale. Al momento non è possibile stabilire una dose giornaliera tollerabile (DGT).
A giugno 2015 gli esperti EFSA hanno ribadito le loro precedenti valutazioni. L’acrilammide negli alimenti può aumentare il rischio di sviluppare il cancro nei consumatori per tutte le fasce d’età ma allo stesso tempo ingredienti, modalità di lavorazione e cottura possono influenzare sensibilmente il livello del composto al quale siamo esposti. Va ricordato che i cibi amidacei non sono l’unica fonte: l’acrilammide è presente anche nel fumo di tabacco, dunque raggiunge fumatori e non attraverso il fumo passivo ed è ampiamente usata in ambito industriale, anche al di fuori di quello alimentare, per esempio come agente flocculante nel trattamento delle acque.
Glicidil esteri degli acidi grassi (GE), 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 2-monocloropropandiolo (2-MCPD)
Di esteri glicidici, 2 e 3-monocloropropandiolo si è sentito parlare negli ultimi anni in relazione all’olio di palma, ma questi composti sono presenti seppur in quantità minori anche in altri oli vegetali e nelle margarine (alle quali è attribuito un incremento del rischio cardiovascolare e che l’olio di palma ha, anche per questo motivo, gradualmente sostituito). A inizio 2016, per rispondere a questo crescente interesse l’EFSA vi ha dedicato un dossier.
Si tratta di tre contaminanti che non sono dunque intrinsechi all’olio di palma, ma che è possibile trovare in molti cibi processati come torte, dolci, biscotti, patatine, creme, cereali da colazione e merendine: gli oli vegetali sono la fonte di esposizione primaria, molto usati come ingredienti dopo un’accurata lavorazione ad alte temperature (oltre 200°C) che serve a privarli del loro aroma naturale. È proprio questo processo a portare alla formazione delle tre sostanze. Nel rapporto Chemicals in food 2016 l’EFSA ha incluso solo esteri glicidici e 3-MCPD (fissando per questo una dose giornaliera tollerabile di 0,8 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno), perché a parte alcuni studi su modelli animali sul 2-MCPD non ci sono informazioni sufficienti dal punto di vista della tossicità. Sappiamo che è presente nei cibi processati a un livello che è circa la metà rispetto al 3-monocloropropandiolo.
Alla formazione e decomposizione dei due MCPD è associato il glicidolo, un composto organico che forma monoesteri con gli acidi grassi durante il processo di raffinazione. È considerato genotossico, dunque in grado di danneggiare il DNA, ma anche cancerogeno.
Confrontando l’esposizione attraverso il cibo e il potenziale cancerogeno dei GE, gli esperti hanno stabilito il margine di esposizione (level of health concern): in una data popolazione, permette di valutare il quantitativo di sostanza alla quale “un effetto avverso minimo ma misurabile viene osservato per la prima volta e il livello di esposizione alla sostanza in questione”.
In base alla raccolta dati in tutta Europa, scrivono gli esperti EFSA, le principali fonti di esposizione cambiano in base alle diverse fasce d’età: per i neonati il latte in formula contribuisce per il 50% (e in quelli che vengono nutriti solo con latte artificiale porta a livelli 10 volte più elevati del margine di esposizione), seguito da biscotti, grassi e oli vegetali. Nei bambini fino ai 10 anni dolci, torte e biscotti in cui siano presenti oli e grassi vegetali, compresa la margarina, ma entrano in gioco anche la carne (ad esempio fritta o cotta) e in alcuni casi la cioccolata. Simili i prodotti che aumentano l’esposizione nella altre categorie come adolescenti, adulti e anziani.
Le categorie di preoccupazione, secondo l’EFSA, sono i giovani consumatori che mangiano quantità moderate di questi alimenti e i consumatori di qualsiasi età che invece ne consumino molti, ma soprattutto i bambini che vengono alimentati solo con latte in formula. L’aspetto positivo è che tra il 2010 e il 2015 i produttori si sono impegnati per ridurre il contenuto in GE nei grassi e nell’olio di palma, arrivando a dimezzarlo.
Mentre l’industria alimentare lavora su processi di raffinazione migliori in questo senso, altri documenti hanno valutato gli effetti sulla salute. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) hanno espresso la stessa valutazione EFSA in termini dei potenziali pericoli legati a questi contaminanti, ma con meno preoccupazione rispetto all’esposizione dei consumatori e indicando come dose giornaliera tollerabile quattro microgrammi per chilogrammo di peso corporeo (contro gli 0,8 indicati dall’autorità europea).
Un altro lavoro recente copre 20 anni di studi scientifici ed è a firma dell’Istituto Superiore di Sanità, i cui esperti premettono che nessun alimento o ingrediente è “tossico di per sé” e che per quantificarne gli effetti sulla salute non si può non considerare il regime alimentare in cui viene assunto. Se si segue una dieta di sole patatine e biscotti, insomma, non si può puntare il dito contro l’olio di palma.
Le conclusioni degli scienziati italiani sono caute e provvisorie, ma dipingono un quadro più positivo nonostante, per mancanza di informazioni, la quantità di olio di palma assunta sia stata sovra-stimata includendo anche altri ingredienti apportatori di grassi saturi. Il consumo totale di acidi grassi saturi nella popolazione italiana adulta è di poco superiore (11,2%) all’obiettivo suggerito per la prevenzione (meno del 10% delle calorie totali giornaliere). Nei bambini tra tre e 10 anni il consumo è invece superiore, ma “i dati unificano età in cui i consumi si differenziano in maniera significativa e vanno pertanto interpretati con cautela”.
Per di più i dati sui consumi degli italiani fanno parte di un’indagine CREA del biennio 2005-2006, ovvero prima del “giro di vite” dato al contenuto in GE nei prodotti alimentari segnalato dall’EFSA. La conclusione, per ora, è che nella letteratura scientifica non vi sono evidenze dirette che l’olio di palma abbia effetti cardiovascolari diversi da altri grassi simili (burro compreso).
Furano
Anche noto come furfurano e ossido di divilienile, il furano è un composto chimico incolore, aromatico ed estremamente volatile; è finito sotto i riflettori a partire dai primi anni 2000 per la sua presenza in molti alimenti processati, nei quali arriva in quanto sottoprodotto delle procedure di imbottigliamento e inscatolamento. Si forma perlopiù durante i trattamenti ad alte temperature, ma è possibile derivi anche da altri processi ancora non chiari. In base agli studi su modelli animali il furano è stato incluso dall’AIRC nel gruppo delle sostanze potenzialmente cancerogene.
Tramite un’analisi di dati scientifici raccolti tra il 2004 e il 2009, l’EFSA ha cercato di stimare con più precisione l’entità dell’esposizione al furano attraverso la dieta per i consumatori di 18 Paesi. I livelli più elevati sono stati trovati nel caffè, con 569 microgrammi per chilogrammo in quello istantaneo e 3611 nei chicchi tostati. I valori più elevati riguardano i chicchi appena macinati, nei quali il furano arriva a quasi 7000 microgrammi per chilogrammo. Qualche anno fa, uno studio pubblicato su Food Chemistry aveva quantificato le differenze tra il caffè espresso e quello fatto con le macchine per il caffè americane (drip coffee maker) e con le capsule; nel primo le concentrazioni erano di 43-146 nanogrammi per millilitro contro i 20-78 dell’americano e i 117-244 delle capsule. Ancora inferiori i livelli per il decaffeinato (14-65 nanogrammi/ml).
Il motivo starebbe nelle caratteristiche chimiche dello stesso furano; essendo molto volatile, le capsule chiuse ermeticamente ne impediscono il rilascio. Le macchine per il caffè usano invece acqua bollente a pressioni maggiori, il che “porta a far sì che il composto venga estratto all’interno della bevanda” spiegavano i ricercatori, aggiungendo che, in ogni caso, i livelli della sostanza erano inferiori al limite sopra il quale il furano può essere pericoloso per la salute umana: due microgrammi per chilogrammo di peso corporeo, ovvero 20 tazzine di caffè con capsula (o 30 espressi al giorno) per una persona che pesi 70 chilogrammi.
L’ultimo rapporto EFSA ha valutato il contenuto anche nelle altre categorie alimentari d’interesse oltre al caffè, quantificando il contenuto in furano a 3,2 microgrammi per chilogrammo di prodotto nel latte artificiale per neonati e 40 microgrammi/kg di prodotto in alcuni alimenti per bambini in vasetti e zuppe. Altri cibi in cui sono stati trovati livelli superiori ai 100 microgrammi/kg sono riso soffiato, sardine e sgombri in salsa di pomodoro, zuppe di pomodoro e gelatine, il che conferma che il furano è presente in una vasta gamma di prodotti che subiscono trattamento ad alte temperature in fase di inscatolamento.
La conclusione del comitato FAO, dell’OMS e della JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) è stata che il margine di esposizione per il furano rivela “una preoccupazione per la salute umana” e che vanno studiate misure per ridurre l’esposizione dei consumatori.
Proprio come per l’acrilammide, le prime attenzioni riguardo al “consumo casalingo” possono arrivare dal modo in cui si cucina e mangia il cibo. Scegliere la cottura al forno rispetto alla frittura è per esempio una buona idea, come mostra lo studio di un gruppo di ricercatori portoghesi e spagnoli, che hanno confrontato le due modalità nella preparazione dei bastoncini di pesce e la conseguente produzione di vari furani (furano, alcol furfurilico, 2-pentilfurano…).
“Il numero di furani diminuisce quando la temperatura è inferiore e si frigge meno a lungo, ma anche con il passare del tempo dopo la cottura”, spiegava María Trinidad Pérez-Palacios, tra gli autori, commentando lo studio. Friggere per quattro minuti a 160°C è più che sufficiente e, combinato con un’attesa di almeno dieci minuti tra frittura e consumo, contribuisce a ridurre la presenza di furani nel cibo. A cambiare saranno anche le proprietà organolettiche del cibo, il sapore ma anche l’odore legati proprio alla produzione di furano (al pari di quanto succede quando l’acrilammide imbrunisce il pane o le patate).
La Food and Drug Administration statunitense ha una sezione Q&A dedicata e pubblica gradualmente sul suo sito una lista degli alimenti testati per i livelli di furano, con dati relativi al 2008. Ma precisa che il livello di questo composto non va interpretato come “esposizione” né come un rischio, perché la valutazione va inserita nel contesto della dieta e della quantità di alimenti che ogni persona consuma. L’obiettivo futuro è capire gli effetti sulla salute di un’esposizione che, seppur a livelli bassi, va misurata sul lungo termine. Per confrontare i risultati ottenuti finora su modelli animali con un riscontro sulla salute umana.
Leggi anche: I parabeni finiscono nel corpo dei mammiferi marini
Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 2.5 Italia. ![]()